Mezzo secolo di femminismo impegnato ha prodotto una diversa percezione dell’universo femminino, ma non ha ancora sconfitto taluni pregiudizi che portano a galla il nostro lato più scimmiesco, al di là del compiacimento nel definirci sapiens. Una riprova la si ha in questi giorni, ascoltando le chiacchiere piazzaiole attorno alla vicenda di don Italo, il parroco di Gordola accusato di molestie e atti sessuali con fanciulli. Le modalità dell’arresto del sacerdote – una scena degna della miglior tradizione cinematografica statunitense – e, soprattutto, il ruolo della minorenne che avrebbe fatto da esca infilzata sull’amo della polizia – stanno dividendo l’opinione pubblica: c’è chi giudica inammissibile il comportamento di don Italo e c’è chi, viceversa, è più propenso a colpevolizzare la ragazzina precoce e ammiccante, rea di aver solleticato oltre misura gli istinti repressi del prete, che è maschio prima che ministro di Dio: il che porta irrimediabilmente a concludere che non è fatto di legno, come suol dirsi.
Lungi da me anche solo il ghiribizzo di prender posizione pro o contro l’accusato, la vittima, la polizia o la magistratura. Però questo filosofeggiare attorno a un plausibile peccato originale della ragazza deve suscitare una seria riflessione, perché non si può ammettere che un qualsiasi adulto si trasformi in uno sporcaccione, solo perché una ragazzina gli fa l’occhiolino più o meno inconsapevolmente. Intanto bisogna precisare che il concetto di “maggior età” è una convenzione e non una massima divina. C’è una maggior età civica e ce n’è un’altra “sessuale”; entrambe sono definite dal legislatore e si modificano nel tempo, adattandosi di volta in volta alle nuove realtà e alle ideologie dominanti. È certo curioso osservare che, mentre molti studiosi sottolineano come l’adolescenza sembri prolungarsi sempre più nel tempo, gli Stati tendono vieppiù a ridurre l’età di transito al rango di adulto.
Ma la relazione tra adulti e fanciulli – come si chiamano i nostri cuccioli in questo genere di faccende – non può limitarsi ai semplici dati anagrafici, che sono tutto sommato solo dei numeri, forse delle medie. Ciò vale soprattutto di fronte a persone che, per l’attività che svolgono, si ritrovano in una posizione gerarchicamente superiore rispetto al pubblico di cui si occupano: sacerdoti, certo, ma anche insegnanti, infermieri, capiufficio e via di seguito. Ciò che don Italo avrebbe fatto è grave di per sé, indipendentemente dalle eventuali provocazioni e dalle insidie consapevolmente celate nel tranello. E resterebbe grave anche se la ragazzina avesse avuto due o tre anni di più. Purtroppo questa vicenda – o, per lo meno, le chiacchiere che le ruotano attorno – ha messo in luce che anche da noi c’è chi è disposto a perdonare il maschio che si lascia trascinare dai suoi istinti primordiali, se solo si può ipotizzare che la vittima – una femmina! – ha usato le armi della tentazione, magari senza nemmeno accorgersene.
Sembra, insomma, di esser tornati ai tempi delle prime minigonne, quando c’era chi lanciava i suoi moralistici anatemi: poi non lamentatevi se vi violentano per la strada. Non ci sono santi che tengano: un atteggiamento del genere deve essere respinto, poiché inaccettabile e irrispettoso. Se, per contro, intendiamo prestar fede all’assioma secondo cui le donne, in primo luogo quelle giovani, carine e seducenti, possono diventare potenzialmente pericolose per i maschi più sensibili e frustrati, allora è meglio correre subito ai ripari: ad esempio introducendo il saio obbligatorio nelle scuole medie e nei licei, negli oratori e negli ospedali, nelle sale da ballo e in tutti i luoghi dove satana potrebbe lasciare il suo segno malefico.
Archivio mensile:Gennaio 2004
Quando la scuola ha bisogno di più «voci»
Un libro singolare raccoglie opinioni diverse attorno alla missione dell’insegnamento
Di questi tempi dire che destra e sinistra sono schematismi superati è assolutamente politically correct. L’affermazione è certamente giusta se l’applichiamo ai partiti tradizionali, alle prese con la moltitudine di problemi richiesti dalla quotidiana convivenza nell’ambito dello Stato, ma mantiene intatto il suo significato tradizionale quando il dibattito verte su un tema preciso, come è certamente quello della missione della scuola. Una riprova viene proprio da questo «Deux voix pour une école»: il ministro delegato all’insegnamento scolastico francese Xavier Darcos e il noto studioso di scienze dell’educazione Philippe Meirieu, sollecitati dalla giornalista di Le Figaro Marielle Court, si lanciano in un lungo e appassionante dibattito sulla scuola, oggi al centro di molte preoccupazioni.
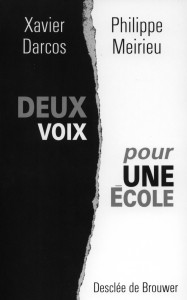 Il libro ha visto la luce in maniera per lo meno bizzarra: il 15 settembre dell’anno scorso era partito un grande dibattito nazionale sull’educazione, voluto dal primo ministro Jean-Pierre Raffarin, per far fronte alle gravi tensioni che caratterizzano la scuola francese ormai da qualche anno. Così il ministro delegato e l’illustre ricercatore, che già in precedenza si erano scontrati pubblicamente su molti dei maggiori media nazionali, si trovano discretamente per alcuni pomeriggi negli uffici della casa editrice e danno vita a questo contraddittorio, la cui uscita nelle librerie era prevista per metà ottobre, con un titolo diverso («Libres propos sur l’école»). Ma il 12 settembre – due giorni prima dell’apertura del dibattito nazionale – Le Monde dà notizia che il libro è stato censurato: «Dominique Ambiel, consigliere per la comunicazione del ministro Raffarin, ha fatto pressioni sul ministro delegato all’insegnamento scolastico affinché la sua conversazione con il pedagogista Philippe Meirieu non appaia». In altre parole: caro Darcos, o blocchi il libro o lasci il ministero. Meirieu, dal canto suo, reagisce pubblicizzando la sua parte del testo, ma non se la prende con Darcos, che giudica leale e coraggioso.
Il libro ha visto la luce in maniera per lo meno bizzarra: il 15 settembre dell’anno scorso era partito un grande dibattito nazionale sull’educazione, voluto dal primo ministro Jean-Pierre Raffarin, per far fronte alle gravi tensioni che caratterizzano la scuola francese ormai da qualche anno. Così il ministro delegato e l’illustre ricercatore, che già in precedenza si erano scontrati pubblicamente su molti dei maggiori media nazionali, si trovano discretamente per alcuni pomeriggi negli uffici della casa editrice e danno vita a questo contraddittorio, la cui uscita nelle librerie era prevista per metà ottobre, con un titolo diverso («Libres propos sur l’école»). Ma il 12 settembre – due giorni prima dell’apertura del dibattito nazionale – Le Monde dà notizia che il libro è stato censurato: «Dominique Ambiel, consigliere per la comunicazione del ministro Raffarin, ha fatto pressioni sul ministro delegato all’insegnamento scolastico affinché la sua conversazione con il pedagogista Philippe Meirieu non appaia». In altre parole: caro Darcos, o blocchi il libro o lasci il ministero. Meirieu, dal canto suo, reagisce pubblicizzando la sua parte del testo, ma non se la prende con Darcos, che giudica leale e coraggioso.
Strano destino quello di un dibattito nazionale voluto dalle più alte cariche dello Stato, che debutta con una censura: ma tant’è, dopo vari tira e molla il volume va finalmente in libreria, con un titolo nuovo ed esemplare: sì, perché i mondi che si incontrano sono davvero diversi, sono sul serio di destra e di sinistra. A destra il ministro, che preconizza la restaurazione dell’Autorità del maestro e della Scuola, anche se “l’ascensore della promozione sociale”, nel mondo globalizzato, non funziona più e genera frustrazione e amarezza negli insegnanti (e non solo). A sinistra lo studioso, che crede nella forza liberatrice della cultura e del sapere, e si impegna per il riscatto degli umili attraverso la scelta di educare (oltre il “semplice” diritto di avere un’educazione). Non mancano, beninteso, i punti di convergenza, in un dialogo tra due profondi conoscitori del sistema scolastico: il libro ha una sua universalità, anche se in tutta evidenza gli esempi e tante riflessioni si basano sulla realtà francese. Ma il dibattito resta franco e civile, al di là delle intense contrapposizioni e dei momenti anche duri e polemici.
La conclusione non può che trovarsi su due sponde diverse, seppure convergenti: per Meirieu “… in una democrazia il ministero dell’educazione nazionale dovrebbe essere il ministero dell’Utopia – l’utopia fondatrice di ogni speranza, quella di una cultura emancipatrice di tutti gli uomini”. Gli fa eco Darcos: “Il sapere, lo zoccolo d’una vita, si fabbrica a Scuola. Solo a Scuola, mentre tutto, attorno ad essa, ne nega il valore, a profitto dell’apparire, della comunicazione, dello spettacolo, dell’estetica del clip, dell’effimero, del litigio”. Resta la grande divisione: cultura per tutti o solo per taluni?
Insomma, un gran bel dibattito, civile nei toni e profondo nei punti di vista: Voltaire contro Rousseau, Darcos contro Meirieu, due voci per una scuola, al di là dei soliti problemi di bilancio, ma al cuore della scuola repubblicana.
Recensione pubblicata sul Corriere del Ticino del 21 gennaio 2004
Xavier Darcos, Philippe Meirieu, Deux voix pour une école, Novembre 2003, Paris : Desclée de Brouwer Éditeur, 203 p.
Ticino terra di poliziotti
In quel moccichino di terra elvetica a sud delle Alpi che chiamiamo Ticino c’è una presenza assolutamente sbilanciata di forze di polizia. Il fenomeno è quantitativo e qualitativo. L’informazione la si desume dalle cronache dei quotidiani, che nelle ultime settimane hanno ampiamente riferito di fatti, fattacci e fatterelli che hanno coinvolto l’universo giovani. Prendiamo l’opulento borgo di Mendrisio. Anche Mendrisio ha il suo bravo liceo e anche i liceali della cittadina mò-mò decidono di ritrovarsi in allegria per festeggiare il Natale e le imminenti vacanze. Il liceo, laggiù nel meridione estremo e levantino, dispone addirittura di una “Commissione feste”, che predispone l’atteso avvenimento in un noto ritrovo.
E qui, all’acme del divertimento, arrivano i nostri, che con camionette e un gran numero di piedipiatti irrompono fulmineamente all’interno del Panda: festa finita, perquisizioni, controlli alcolimetrici, sirene e fari lampeggianti, fulminei trasbordi in centrale, sequestri di innocui spinelli: sembra di essere in un film. E, soprattutto, genitori sgomenti, che nei giorni seguenti non perdono l’occasione di far giungere le immancabili lettere ai giornali. Al comando della Polcantonale spiegano che il massiccio intervento era mirato a colpire quei gestori un po’ disinvolti nell’applicazione delle leggi che regolano gli esercizi pubblici. Ma genitori e pargoletti non sentono ragioni: l’intervento delle truppe del comandante Piazzini sono giudicate sproporzionate e fuori luogo. Naturalmente i toni vanno sopra le righe, con paragoni improbabili: la polizia rompe le scatole ai nostri imprudenti ragazzetti, mentre i bordelli straripano di clienti e i ladri penetrano indisturbati nell’isolato villino delle vecchietta di turno. Un genitore raggiunte il top dell’esternazione mediatica: povero figliolo, chissà che trauma a farsi trasportare su un cellulare della polizia in un’età emotivamente così fragile…
Tutt’altra musica a Locarno. Sulle piazze della ridente cittadina sulle rive del Verbano (si fa ovviamente per dire, perché c’è poco da ridere) imperversa da tempo un’orda di giovinastri che spacca tutto, imbratta, provoca, taglia pneumatici e crea vistosi e minacciosi assembramenti. Sotto Natale il branco se l’è presa perfino con il mega-albero posato nella mega-rotonda di Piazza Castello. A Locarno tutto è mega: mega l’albero, mega la rotonda, mega il debito pubblico, mega le beghe tra maggiorenti locali. E la polizia? Cosa fa quella stessa polizia che vezzeggia affettuosamente i ricchi liceali del Mendrisiotto, perdendoci pure la faccia davanti agli apprensivi genitori? Va lì come una strampalata armata un po’ picaresca, non riesce ad acciuffare neanche uno straccio di sprayer e in più qualche agente finisce all’ospedale, malmenato da giovani costretti sulla pubblica via in assenza di un qualsiasi gradevole Panda.
Ma, ormai, son due mondi diversi e distanti. Pensate: un papà di Ligornetto che aveva il fragile figlio al Panda quel fatidico 19 dicembre si è rivolto ai giornali per denunciare e segnalare alla pubblica opinione i sistemi della nostrana polizia, sempre meno «educativa» e sempre più vessatoria. A Locarno, invece, nessun genitore si è sognato di scrivere ai giornali. Meglio mandare la polizia a quel paese e accusarla di non riuscire ad acciuffare i ladri. Intanto il solito scialbo qualunquista ha lanciato l’ennesima petizione, per chiedere il coprifuoco dei minorenni dopo una certa ora e per creare squadre di vigilantes volontari che tengano l’assediata città sotto controllo.
C’è, insomma, una voglia accresciuta e impellente di dare consigli e di sostituirsi all’autorità. Però vien da chiedersi: cosa sarebbe capitato se nel Panda strapieno e un po’ brillo fosse scoppiato un incendio? Si sarebbe accusata la polizia di dedicare troppo tempo ai bordelli? E se la polizia fosse intervenuta in forze a Locarno? Probabilmente il papà del liceale di turno avrebbe scritto ai giornali, per accusare le forze dell’ordine di usare metodi sproporzionati. Insomma: siamo di fronte a un Ticino squilibrato e contraddittorio. Vediamo di metterci d’accordo, perché i nostri figli hanno bisogno di messaggi chiari, più che di coccole e difese a oltranza.
Quella scuola che sfrittella il pensiero
Questo articolo è apparso nell’inserto culturale del Corriere del Ticino del 12 gennaio 2004 (Eccolo!).
Sarà l’effetto del Supercampiello 2004, vinto con il romanzo Una barca nel bosco, fatto sta che questo La scuola raccontata al mio cane, della torinese Paola Mastrocola, è diventato in pochi giorni uno dei libri più acquistati in Italia, successo di vendite non così scontato se si pensa che il volume è una sorta di saggio su un «mestiere che non c’è più». «Io insegnavo facendo letteratura» scrive unel prologo. «Tutto qui. Per me, il mio mestiere era semplicemente questo: insegnare letteratura. Adesso, improvvisamente, direi da un giorno all’altro, chi la pensa così è tagliato fuori».
La scuola raccontata al mio cane è un’aspra e circostanziata requisitoria contro il liceo italiano, giocata sui registri dell’ironia e del sarcasmo, della rabbia e dell’amore profondo nei confronti della Scuola e della gioventù: confrontata con i POF – i cosiddetti Progetti d’Offerta Formativa della riforma morattiana – e con il primato della lingua “che comunica”, Paola Mastrocola reagisce con una forza argomentativa inusitata per denunciare senza mezzi termini una Scuola che «Si adegua pari pari al mondo, non gli va contro neanche un po’, combacia perfettamente: lo riflette, lo copia, lo reduplica. Non oppone nulla di alternativo. È una scuola che “connive” con la società. Lo so che il verbo connivere non esiste, ma vorrei usarlo lo stesso; in latino voleva dire: “chiudere gli occhi”, quindi far finta di niente, essere complici». POF e comunicazione: con i POF la scuola si prostituisce, adeguandosi a richieste bottegare, che mettono il corso di chitarra o quello di giardinaggio davanti a Dante e ad Alessandro Manzoni. La lingua “per comunicare” è l’altra perversione, che intacca e avvolge anche l’insegnamento delle lingue straniere. «La nostra prima e forse unica preoccupazione – scrive in uno tra i tanti gustosi capitoli – è di renderli in grado [gli studenti] di… andarsi a comprare la baguette a Parigi! E va anche bene così, ma… forse ci sarebbe un altro modo, più “alto”: il modo indiretto e alto della letteratura. Potrei far leggere loro i romanzi di Gide e Stendhal, le poesie di Rimbaud e Apollinaire. Lì non sta scritto come si chiede una baguette in panetteria, è vero: c’è scritto molto di più! E davvero noi crediamo che un ragazzo che sappia leggere Rimbaud non sia poi in grado di andarsi a comprare una stupida baguette? Crediamo questo veramente? Diamo così poca fiducia alla letteratura? Sì. Non la riteniamo in grado di “fornire gli strumenti adeguati”. Diamo invece un’enorme fiducia… agli strumenti adeguati in sé: insegniamo per cinque anni a chiedere una baguette! Non pensiamo che, se è facilissimo scendere da Rimbaud alla baguette, non è invece affatto facile, anzi, forse è impossibile, salire dalla baguette a Rimbaud: questo vuol dire che noi priviamo per sempre i nostri ragazzi dell’“altezza” di Rimbaud, e li releghiamo per sempre alla “bassezza” quotidiana e concreta della baguette».
Certo, il liceo italiano non è il liceo ticinese, così come l’attuale Ministero Italiano dell’Istruzione ha apparentemente poco a che vedere col più nostrano e metamorfico DECS, che in fondo – come nell’intera Europa occidentale – null’altro ha fatto se non adeguarsi alle tendenze più pacchiane e diffuse. In fondo, come annota argutamente Paola Mastrocola, il ’68 è la matrice primigenia dell’attuale stato delle cose: «… era giusto volere una scuola meno autoritaria, nozionistica, severa, elitaria, separata, astratta, non socialmente attenta. Giusto. Ma era giusto trent’anni fa! La Battaglia è stata fatta, e ha ottenuto esiti direi molto positivi. Bene. Quello che oggi mi sconcerta è il constatare che si continua imperterriti quella stessa Battaglia, una Battaglia cioè che non solo è già stata vinta, ma che oggi non ha più alcun senso combattere, dal momento che il nemico è cambiato, anzi… è esattamente il nemico opposto a quello che avevamo allora». Che fare dunque? Come tentare di avviare una nuova Rivoluzione affinché la scuola – e il liceo in particolare – riesca a uscire in fretta e con prepotenza dallo strapiombo strumentale in cui si è ficcata, in parte per comodità e in parte per cecità? Come rimediare alla realtà, che ha disinvoltamente trasformato l’utopica democratizzazione degli studi nella democratizzazione dei diplomi e dei titoli di studio?
A Paola Mastrocola piace vestire i panni dell’«avvertitore di verità». Nella fiaba I vestiti nuovi dell’imperatore «…c’è un bambinetto da nulla che, in mezzo al corteo osannante, avverte: l’imperatore è nudo!». Ed è nudo proprio in virtù di una formazione annientata dai bisogni immediati, mercantili, utilitaristici e – soprattutto – facili. Chiaro: per imboccare un nuovo corso consacrato all’educazione inutile – la letteratura italiana, secondo Paola Mastrocola; ma si potrebbero ricordare per analogia la storia e la filosofia, le lingue ‘morte’ e tutto quanto rende grande la tradizione umanistica – ci vogliono Maestri in gamba, la cui definizione non è davvero facile: «Diciamo che noi, quando uscivamo dalla lezione di un maestro, camminavamo per un bel po’ a un metro da terra. Diciamo che quel metro da terra fa la differenza. […] Diciamo che forse questo contraddistingue un maestro: ti contagia». Il problema è come misurarlo, quel metro in più, considerato che «… un insegnante che non insegna procura un danno davvero incalcolabile al singolo allievo, e quindi anche all’intera società: condanna all’ignoranza, […] quindi al vagolamento professionale infinito».
La scuola raccontata al mio cane non è e non pretende di essere un libro di pedagogia, scritto da addetti ai lavori per addetti ai lavori, e nemmeno contempla un catalogo di soluzioni. Paola Mastrocola si diverte a raccontare la sua storia di insegnante di lettere del liceo italiano, confrontata oggi con una miriade di interferenze e di pedagogismi che hanno finito per stravolgere il senso stesso della Scuola: da luogo di trasmissione e di formazione, a parco giochi e centro sociale, dove il pensiero si sfrittella invece di strutturarsi. L’autrice, che rivendica dalla prima all’ultima pagina il suo diritto di essere solo e semplicemente un’insegnante di lettere, mette in luce con grande intelligenza le derive che scaturiscono dal primato della pedagogia e della didattica sulle competenze disciplinari. Essere bravi insegnanti, oggi più di ieri, significa riuscire a destreggiarsi in perfetto equilibrio tra la profonda conoscenza di ciò che s’insegna e la cultura pedagogica per saperlo insegnare. Dal ’68 in poi si è fatto un gran parlare dell’importanza del “saper essere” e del “saper fare” rispetto al “sapere-e-basta”: ogni pedagogista accorto sa però che non è possibile costruire tali attitudini sul vuoto pneumatico. In tutta evidenza il discorso non tocca solo il liceo, né quello italiano in particolare.
