Devo due parole di spiegazione in entrata, sennò ci sarà chi mi biasimerà con l’accusa di occuparmi di politica, mentre la scuola non ha nulla a che fare con la politica. Dissento, ovvio. Ho sempre detto e scritto che la pedagogia è ideologica. Ritengo inoltre, benché sembri banale ribadirlo, che non solo la scuola e la famiglia educhino, anzi.
Nei giorni degli attacchi del 13 novembre a Parigi se ne sono lette e viste tante. Ripropongo qui due riflessioni che mi sono piaciute molto – e, naturalmente, non sono le uniche: chissà quante me ne sono sfuggite.
La prima è di un comico, Maurizio Crozza. La sua copertina del talk show di Giovanni Floris dello scorso 17 novembre (DiMartedì su La7) è amaramente comica. Con un francese maccheronico – ma l’importante è capirsi – l’ha intitolata Je suis un cretin totalment brancolant dans la nuit.
Ha detto, tra le altre cose, che a gennaio, dopo la strage di Charlie Hébdo, te la potevi cavare con un «Je suis Charlie». Adesso sulle magliette cosa ci scriviamo? Je suis Paris? Sì, però due giorni prima c’è stato un attentato in Libano, 44 vittime e 239 feriti. Quindi bisogna anche scriverci «Je suis Beirut». E dieci giorni prima era esploso un aereo sul Sinai, 224 morti, per cui bisogna aggiungerci anche «Airbus 321 avec les touristes russes».
Cioè: se qualcosa accade a Parigi, giustamente ci sentiamo tutti coinvolti. Se accade sul Sinai, meno, quasi nulla. Quanto deve essere vicina una barbarie perché ci colpisca come esseri umani? Cioè: piangiamo solo le città di cui abbiamo un souvenir attaccato sul frigo?
La verità è che l’unica maglietta che mi sentirei bene addosso è Je suis un cretin total, brancolant dans la nuit, un perfetto cretino che brancola nel buio. Qualcuno parla di guerra di religione. Ma a Beirut i terroristi erano mussulmani e hanno ucciso altri mussulmani. E allora? E allora io non lo so.
Alle volte invidio chi ha le idee chiare. Poi mi accorgo che chi le ha è gente come Gasparri, Belpietro e Salvini. E mi dico: ma sai che forse essere un cretin che brancola nella nuit non è mal pour moi? Il giorno dopo gli attentati, «Libero» di Belpietro titolava «Bastardi islamici»; Gasparri ha scritto: «Radiamo al suolo lo stato islamico»; e Salvini ha detto «Il terrorismo va bombardato».
Io sarò anche un cretin dans la nuit, ma loro sono dei cretin anche in pieno jour.
In effetti bombardare tutti è una soluzione: non nuovissima. Perché dopo l’11 settembre l’abbiamo fatto. E oggi in Afghanistan i talebani controllano molto più territorio di quello che avevano quindici anni fa. E il terrorismo nel mondo è più forte di prima.
Ma io sono un cretin. Brancolo.
So solo che coi nostri bombardamenti sono stati uccisi un milione di civili iracheni, 220 mila civili afghani e 80 mila civili pachistani. Più che una guerra di civiltà per ora è stata una riuscitissima guerra ai civili. E quella, secondo me, l’abbiamo già vinta. Ma sbaglio o adesso stiamo per rifare la stessa cosa?
E no, io sbaglio, je suis totalement cretin.
La seconda riflessione, pubblicata su La Regione del 18 novembre, è una lucida riflessione di Dick Marty: e non sembri irriverente l’accostamento. Si intitola Tragico tranello. Per chi non avesse il tempo o la voglia di leggerselo interamente, eccone la conclusione:
Il dibattito politico, come inteso oggi, appare purtroppo poco idoneo ad atteggiamenti di fredda analisi e di scelte razionali. La tentazione di capitalizzare consensi facendo leva sulle emozioni e la paura è grande. Poche ore dopo la strage di Parigi c’era già chi era all’opera in tal senso. Oltre alla repressione, necessariamente rigorosa, occorre anche agire a livello di prevenzione, ricercare e capire cioè i motivi che contribuiscono a scatenare gesti talmente disumani e indurre giovani a farsi saltare in aria per meglio uccidere altri a loro totalmente estranei. I terroristi finora identificati sono nati e cresciuti in Europa, spesso in zone gravemente trascurate dalle istituzioni e caduti nelle maglie di predicatori dell’odio, un odio e un’ideologia alimentati anche dalle ingiustizie commesse nei confronti del mondo arabo e dalla tragedia palestinese tuttora irrisolta, non senza responsabilità occidentali. Questo non giustifica niente, sia ben chiaro, ma dovrebbe almeno indurci a riflettere per definire risposte più adeguate. La stragrande maggioranza dei musulmani non si riconosce per niente in questi criminali. La reazione a questo terrorismo deve fondarsi pertanto su di un’alleanza con il mondo musulmano.
Nel generale schiamazzo politico, massmediatico, bombarolo e di pancia, converrebbe davvero lasciarsi alle spalle il proprio ticinocentrismo e provare a pensare. Già il tentativo sarebbe di per sé un bel segnale.
Giorno dopo giorno gli insegnanti accolgono nelle nostre aule schiere di bambini, ragazzi e giovani, che naturalmente han sentito parlare del 13 novembre parigino e di tutte le complessità storiche e politiche che l’accompagnano. E quasi certamente sono portatori delle interpretazioni ascoltate dai grandi, spesso senza mediazione alcuna.
Non sarebbe male riprendere in classe questi temi, magari senza bisogno di organizzare chissà quali itinerari didattici: in fondo basterebbe mettere in dubbio qualche certezza. Perché, come ha scritto una volta Umberto Eco in un suo articolo sul “Corriere della Sera”, è importante imparare a confondersi le idee fin da piccoli, per avere le idee in chiaro da grandi (citazione a memoria, purtroppo: ma anche se non l’avesse scritto è comunque un bel trattatello di pedagogia).
Anche questa sarebbe educazione civica.
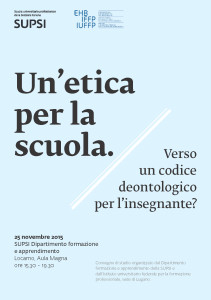 Mercoledì 25 novembre 2015 si terrà a Locarno, al Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento della SUPSI, un importante Convegno di studio che il DFA organizza in collaborazione con la sede ticinese dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP).
Mercoledì 25 novembre 2015 si terrà a Locarno, al Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento della SUPSI, un importante Convegno di studio che il DFA organizza in collaborazione con la sede ticinese dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP).