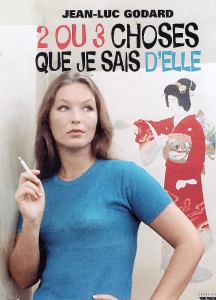Nella sua edizione del 20 marzo il domenicale gratuito Il Caffè ha dedicato ampio spazio alla scuola, prendendo le mosse dal “famoso” sciopero al contrario che sarebbe andato in scena di lì a qualche giorno. Evito intenzionalmente di dire la mia sulla manifestazione più o meno massmediatica e sindacale del 23 marzo, alla vigilia delle vacanze pasquali: per tre mesi abbiamo letto di tutto, nel bene e nel male. Rammento solo che, negli ultimi vent’anni, il giorno di congedo supplementare per i docenti (e degli impiegati dello Stato in genere), deciso per compensare qualche misura di contenimento salariale, è stato frequente, senza che a nessuno saltasse in mente di inventare scioperi al contrario o altre amenità. Per quel che ricordo, non usciva neanche una striminzita lettera ai giornali: un giorno in più di vacanza non scocciava a nessuno.
È stato giusto gridare di nuovo Giù le mani dalla scuola pubblica e obbligatoria. È capita e concordo, ci mancherebbe.
Torno al Caffè di domenica 20 marzo. In prima pagina, nel consueto spazio dell’editoriale, ecco una lettera aperta di Manuele Bertoli, direttore del DECS, Cari professori, cari studenti io vi dico che…, un testo accorato che, per quello che può contare, mi sento di sottoscrivere quasi integralmente. A seguire, alle pagine 2 e 3, ecco un florilegio di contributi d’ogni genere e competenza (si possono leggere le due pagine nell’edizione e-paper del Caffè del 20 marzo, con l’accortezza di scegliere l’edizione del 20 marzo 2016).
La settimana precedente mi aveva contattato il giornalista Ezio Rocchi Balbi, che ha curato il servizio e che ha introdotto il tema con un articolo intitolato La scuola si è rivoltata, “esami” più difficili per il ministro Bertoli. Con Rocchi Balbi siamo rimasti al telefono per circa un quarto d’ora. Nell’articolo è uscita questa sintesi:
«Devo riconoscere che mai avevo visto un ministro come Bertoli così a contatto con le scuole. Tanto di cappello – sottolinea Adolfo Tomasini, ex direttore delle scuole comunali di Locarno. Ma il disagio dei docenti continuerà fino a quando non si eliminerà un peccato originale che incide su tutti i nodi della scuola, dalle competenze all’educazione civica fino all’ora religione: bisogna decidere se la scuola deve selezionare o formare».
Naturalmente poteva andar peggio, ma quando si parla coi giornalisti bisogna sempre essere consapevoli che quel che si dice può essere riportato alla lettera e sembrare l’esatto contrario di quel che era l’intenzione. Qualcuno, forse il solito Andreotti, disse una volta che una smentita è una notizia data due volte. In effetti qua non smentisco, mi limito a dire che mi è andata bene: un quarto d’ora di colloquio è finito in una sessantina di parole, onore alle doti di sintesi del giornalista.
Poi, però, ecco, a seguire, un commento di Bertoli, riferito alla mia domanda – selezionare o formare? – domanda un poco retorica, ne convengo:
«In realtà è una scelta già fatta con la riforma scolastica del 1990 e ora, semmai, si tratta di concretizzarla – replica Bertoli. Il mio concetto di una scuola dell’obbligo sempre più inclusiva è conclamato […]».
Che sia ora di concretizzare l’arcaica Legge della scuola è possibile e gradito, a oltre cinque lustri di distanza. Che sia possibile realizzare quelle nobili finalità lasciando tutto il resto immutato mi sembra un po’ azzardato. Che l’attuale parlamento abbia la lucidità per farlo, e per farlo senza cedere ai richiami seducenti delle sirene populiste (con buone ricadute elettorali), lo escludo.
Ho scritto più volte che la riforma scolastica del 1990 è rimasta per tanti versi sulla carta. Tenuto conto della gestazione, dalla durata geologica, e del contesto storico e politico in cui la Legge della scuola del 1990 ha visto la luce, avevo scritto un articoletto, sul Corriere del Ticino, in occasione del suo ventesimo compleanno: «Una legge della scuola incartapecorita». E anche sul tema dell’inclusione avevo pubblicato qualche riflessione in questo sito, circa un anno e mezzo fa: «L’inclusione tra sogni e realtà».
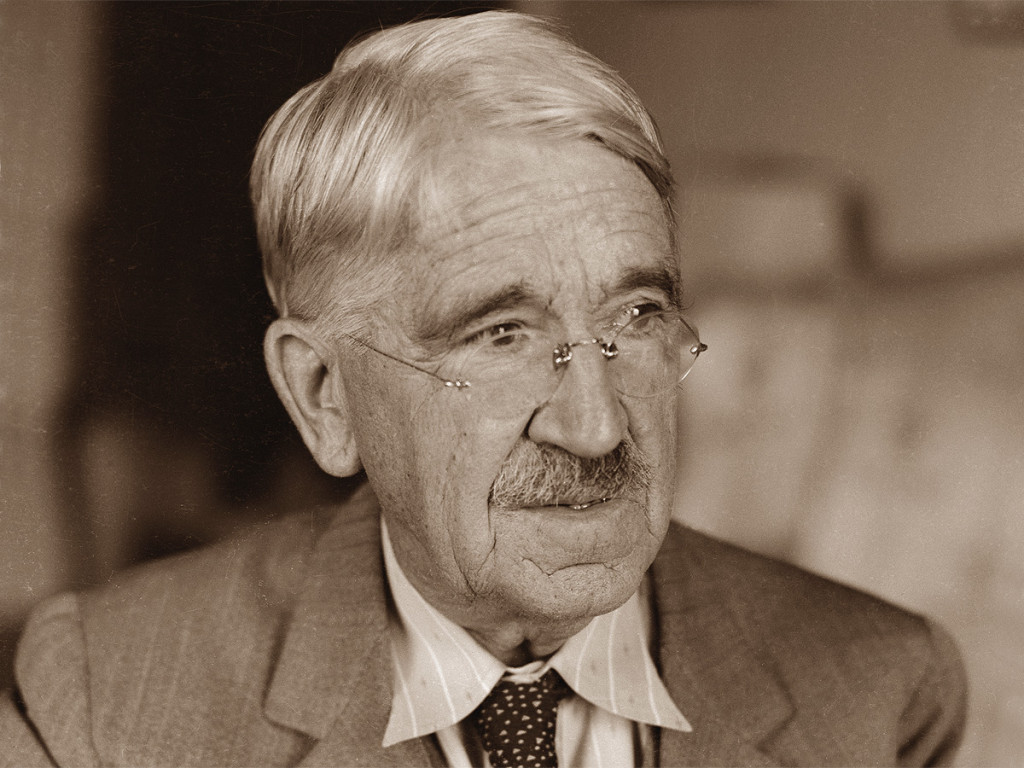
Quindi sì, continuo a essere convinto che la scuola dell’obbligo debba finalmente scegliere da che parte stare. A mente mia c’è bisogno di qualche alleggerimento e di tanta serenità nel corso di tutta la durata della scuola dell’obbligo. Per le competizioni feroci ci sarà tempo una vita.