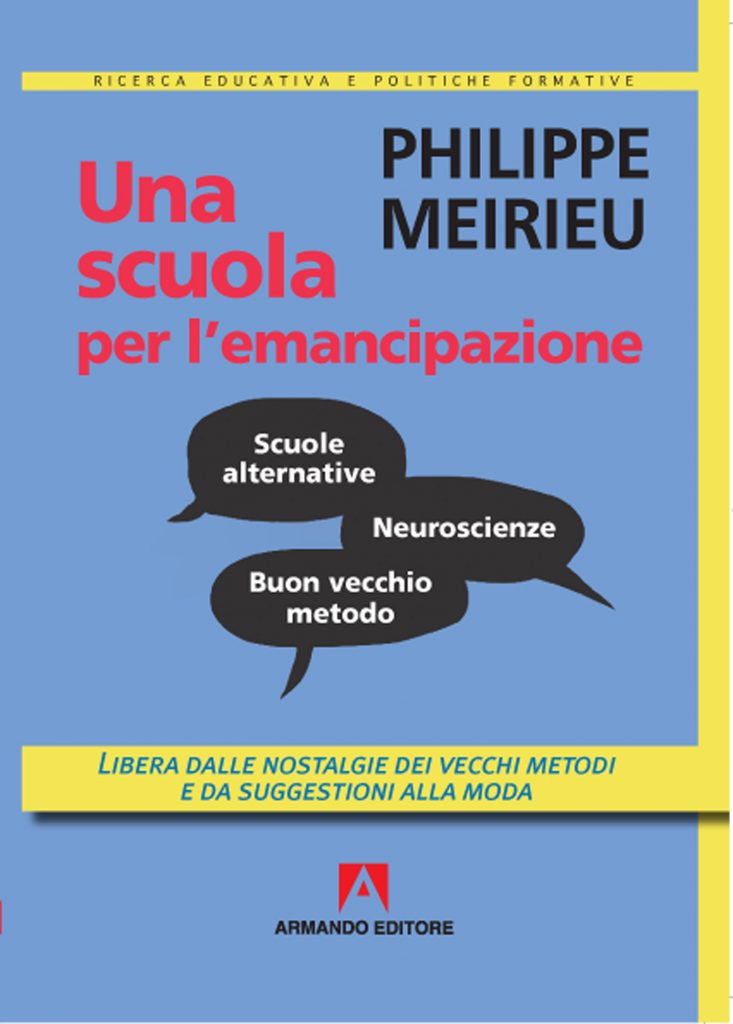In tanti si sono chiesti, e continuano a chiedersi, come sarà possibile recuperare quei tre mesi di scuola che, tanto o poco, sono andati persi. Manuele Bertoli, direttore del DECS, ha correttamente chiarito che «La scuola è un percorso, a volte lungo. C’è quindi il tempo di recuperare quanto si è inevitabilmente perso da metà marzo a fine anno, pur con tutto quel che è stato messo in campo per evitare un blocco dell’insegnamento e dell’apprendimento»: una scuola dell’obbligo col contagocce, tra insegnamento a distanza e riapertura parziale, a classi dimezzate – anche laddove il numero degli alunni e le ampie superfici delle aule avrebbero permesso di mantenere una scuola normale –, con griglie orarie ridotte all’osso, materie depennate e procedure di valutazione annullate.
Per certi versi la situazione che si è creata potrebbe addirittura far sorridere, se solo si pensa alla difficile arte di ficcare nell’anno scolastico tutte le discipline ritenute essenziali, con programmi densi e tempi prestabiliti: perché l’anno scolastico dura esattamente trentasei settimane e mezza. Già in situazione normale, cioè quando gli anni scolastici iniziano e finiscono senza emergenze, si sentono maestri e professori che si lamentano perché, al rientro dopo le lunghe vacanze estive, molti studenti hanno dimenticato quasi tutto. Poi qualcuno, con un po’ di allenamento, riuscirà a riaccendere la memoria, mentre altri saranno condannati ad aggiungere confusioni e vuoti ai ritardi dell’anno prima.
Ma c’è poco da fare, almeno nell’immediato. Qualcuno aveva suggerito di mantenere aperte le scuole durante l’estate, ma giustamente non se n’è fatto nulla, anche perché gli edifici scolastici sono progettati per proteggere dal freddo, mica dal caldo. Anzi: le scuole, da noi, chiudono in estate perché fa caldo, benché la storia del calendario scolastico racconti di altre variabili, che affondano le loro radici indietro nei secoli e nell’economia agricola dell’Ottocento. Tant’è: nel nostro cantone si va a scuola da settembre a giugno, per una trentina di ore alla settimana. Perché? Boh, forse perché si è sempre fatto così. D’estate si va in vacanza, salvo chi va al doposcuola perché mamme e papà lavorano nel turismo.
Il blackout scolastico dei mesi scorsi propone diversi spunti di riflessione, già a partire da due funzioni che hanno molto condizionato l’organizzazione degli istituti, chiamati a istruire e accudire, con questo secondo ruolo paradossalmente irrinunciabile rispetto al primo. Già questo è un aspetto delicato, visto che occuparsi dei figli quando i genitori lavorano è un compito della scuola, al quale, di solito, si pensa poco: tanto ci sono gli asili nido, i doposcuola, le colonie, le solidarietà tra famiglie e conoscenti, nonché chi si arrangia come può. Ma sono finiti da oltre mezzo secolo i tempi in cui la scuola dettava i suoi ritmi a Roma e al mondo.
Tuttavia anche dentro il contesto più nobile della scuola vi sono dei nodi delicati: qual è il giusto tempo da dedicare alla formazione e all’educazione dei cittadini di domani? Come organizzarlo? Con questo monte-ore cosa è essenziale insegnare? Più lingua o più lingue? E quali: il cinese o l’inglese? Più scienze o più arti? Cosa, insomma, è utile e spendibile e cosa non lo è? E, ancora, quale deve essere il ruolo dei genitori sul piano della formazione? Devono, per dirne una, collaborare attivamente con i professionisti della scuola a insegnare l’italiano e la matematica?

Ho trattato più volte il tema del calendario scolastico, per lo più nella mia rubrica sul Corriere del Ticino:
-
- Riflettendo sulle vacanze estive (12.06.2002)
- La grande ricreazione di fine anno (04.06.2003)
- Giù le mani dalle nostre vacanze estive (10.09.2003)
- La scuola e il plenilunio di primavera (26.01.2005)
- La scuola ticinese fra cicli lunari e orbite solari (29.02.2008)
- Se la scuola non detta più i ritmi quasi a nessuno (15.05.2018)