Il mese scorso i delegati nazionali del partito radicale svizzero, riuniti a Morat, hanno a lungo dibattuto la proposta di generalizzare in tutto il Paese l’introduzione dell’uniforme per scolari e studenti, prendendo spunto dalla trovata di una scuola professionale basilese, che da quest’anno ha introdotto la pensata a titolo sperimentale. A che pro? Giancarlo Dillena, che ha commentato l’idea sul Corriere del 30 agosto, scrive che la divisa «… evita il confronto basato sull’esibizione da parte dei più “ricchi” di abiti e scarpe che gli altri non si possono permettere, si disinnescano le tensioni legate alle tenute sempre più provocanti delle ragazze, si favorisce anche sul piano visivo l’integrazione dei giovani immigrati». Queste, e altre ancora, sono le motivazioni invocate da chi, ormai da qualche anno, vedrebbe di buon occhio gli studenti delle nostre scuole addobbati come soldatini o come i cinesi ai tempi della rivoluzione culturale: il che dovrebbe portare indubbi vantaggi anche nel frenare certi eccessi di consumismo. Sarà, e per certi versi si può persino condividere.
Quando frequentavo la scuola elementare, nei primi anni ’60, portavamo ancora il grembiulino, ma non per questo eravamo tutti uguali, nemmeno all’apparenza. È vero che a quei tempi le differenze di classe permeavano tutta la società, e quasi quasi ne erano una caratteristica di cui neanche vergognarsi: c’erano compagni che non potevano andar male a scuola, e ce n’erano altri che per forza (e per ceto) non potevano pretendere chissà che. Per restare agli ambiti ancor oggi «uniformati», non sono uguali gli ecclesiastici, che ostentano bardature diverse a seconda del rango occupato. E lo stesso dicasi per i militari. Si potrebbe chiosare: ma due caporali sono agghindati alla stessa maniera, indipendentemente dal fatto che uno, nella vita civile, studi filologia romanza a Friborgo, mentre l’altro abbia appena terminato l’apprendistato di lattoniere. Giusto. Ma è quando aprono bocca che li voglio: perché il rischio che a uno dei due si vedano i buchi nei calzini è molto alto, a conferma dell’adagio popolare secondo cui l’abito, per una volta, non distingue obbligatoriamente il monaco.
D’altra parte i “nobili” hanno sempre trovato il modo per distinguersi dal popolino: nel ’700 arrivarono le forchette – attrezzi pericolosissimi e misteriosi – per far pesare la diversità di ceto: meglio ferirsi la lingua e il palato con le aristocratiche posate piuttosto che mangiare con le mani… È un po’ come l’Avvocato, che pochi anni fa indossava il Rolex sopra i polsini, facendo tendenza: basta distinguersi. Oggi tutto è più confuso. Se noi, teenagers del post ’68, acclamavamo la nostra appartenenza al gregge coi jeans e il “Reporter” (senza dimenticare “Peace and love” e le inevitabili Clarks), oggi le tribù sono più variegate: i “rappers” dipendono da Eminem e i metallari dagli Iron Maiden; poi ci sono i seguaci dei Vadvuc – acronimo quanto mai rivelatore – i discendenti dei Beatles e dei Rolling Stones, i nostalgici della canzonetta italiana, gli ultras delle varie curve e senza dubbio i nazi-skin: ognuno con la sua uniforme, gli atteggiamenti coatti, l’incedere oratorio zoppicante.
Così noi potremo imporre l’uniforme scolastica al figlio del notabile – sempre che frequenti la scuola pubblica – e al suo compagno fresco di esodo dall’Angola, ma non avremo fatto nessun passo avanti sul piano dell’integrazione e delle pari opportunità. In altre parole, se domani il Liechtenstein ci occupasse manu militari e io dovessi rifugiarmi – che so? – in qualche dipartimento francese, vorrei che i miei figli imparassero bene la lingua, la storia e la geografia, i modi di dire, di fare e di essere. Mi augurerei che la scuola non si limitasse e insegnar loro che «Sur le pont d’Avignon, l’on y danse tout en rond», ma smanierei che imparassero a conoscere Hugo, Verlaine e Rimbaud, Voltaire, Rousseau e Diderot, Bizet e Debussy, Renoir e Cézanne. Per intanto, fortunatamente, posso restare qui: andrò avanti ad arrangiarmi come posso per far passare Manzoni e Leopardi, Verdi e Puccini, Giotto e Tiziano. A ’sto punto spero solo che i nostri figli possano almeno continuare a vestirsi come vogliono, nella certezza che le divise essenziali sono altre.
Dimenticavo: i delegati radicali hanno poi deciso di lasciar perdere; ma coi problemi che ci sono, questo dell’uniforme fa venire l’orticaria.
Tutti gli articoli di Adolfo Tomasini
Scuola e HarmoS: ma perché nessuno ci copia?
Mi sa che per un po’ si sentirà parlare di HarmoS, il concordato sull’armonizzazione della scuola obbligatoria promosso dalla Conferenza svizzera dei Direttori cantonali della Pubblica Educazione e attualmente in consultazione. HarmoS – come è forse noto – si propone essenzialmente di omologare gli esistenti 26 sistemi scolastici, affinché anche il semplice trasloco di una famiglia da Basilea città a Basilea campagna non rappresenti più un ostacolo penalizzante se si hanno figli nella scuola dell’obbligo. È subito evidente che il Ticino rischierà di ritrovarsi con un sistema scolastico più o meno stravolto, in virtù di pratiche e strutture molto più popolari e diffuse nel resto della Svizzera rispetto a noi – e, soprattutto, nei cantoni che contano. Insomma: in piena globalizzazione e con una popolazione assai mobile, non è più pensabile una scuola tanto frammentata e strutturalmente diversificata. Nel 1970 i cantoni avevano già stretto un altro accordo intercantonale – invero ben più blando – al quale, tuttavia, il nostro cantone non aveva aderito, insistendo in tal modo sulla sua diversità. Lo scorso 21 maggio, però, il popolo svizzero ha accolto a larghissima maggioranza una riforma costituzionale in materia di formazione: rispetto ad HarmoS, ciò significa che la Confederazione potrà costringere qualsiasi cantone riottoso a rassegnarsi e ad accettare l’accordo intercantonale, una volta che una decina di cantoni vi avranno aderito.
Il direttore del nostro Dipartimento ripete da sempre, e l’ha ribadito il 18 agosto scorso in occasione di un pomeriggio di studio promosso dal DECS, «… che noi ticinesi abbiamo l’interesse ad aderire […] all’accordo sull’armonizzazione della scuola obbligatoria a condizione che non vengano stravolte le conquiste della scuola pubblica ticinese», per evitare di «compiere passi indietro e rinunciare a conquiste costruite faticosamente sull’arco di decenni». Interesse di adesione a parte, la pensano un po’ tutti come Gendotti: la nostra organizzazione scolastica, seppur perfettibile, va bene così com’è. È fuor di dubbio che la ricetta miracolosa non esiste. Restando alla Svizzera, si constatano differenze anche importanti a diversi livelli. Eppure è impossibile dire se, in uscita, gli argoviesi imparano più dei giurassiani, seppure un po’ distanziati dagli appenzellesi dell’Innerrhoden. Anche perché il sistema scolastico di ogni cantone è stato forgiato da tradizioni, localismi, convenienze politiche, congiunture storiche ed economiche…
Gli scettici di oggi appartengono a quelle generazioni che, dopo il primo uomo sulla luna ma prima dell’apparizione del PC, hanno dato vita a quel grande cambiamento che si chiama «Scuola media»: dopo innumerevoli polemiche – perché anche allora non mancarono le voci ostili – nel 1974 il Gran Consiglio votò la nuova legge, che non rappresentò soltanto un cambiamento de jure. Fu necessario edificare nuove scuole, rivedere diverse strutture (ginnasio e scuola maggiore a parte, qualcuno ricorda il liceo di tre anni, l’anno di avviamento professionale o la scuola di economia domestica?), aggiornare gli insegnanti e rifare da cima a fondo tutto l’impianto legislativo. Eppure il Ticino ne uscì col petto in fuori, nella consapevolezza di aver fatto una riforma opportuna e progressista: quella di oggi è la scuola che noi cinquantenni e sessantenni abbiamo costruito per le generazioni seguenti. Quando questo concordato diverrà operativo, invece, noi saremo tutti in pensione, o quasi.
Faccio parte anch’io della schiera dei sospettosi. Anch’io ho il complesso del balivo. Anch’io mi sento di difendere questo sistema scolastico, che molti lodano, ma che nessuno copia, come ha ironizzato il capo della divisione della scuola Diego Erba durante la citata riunione del 18 agosto. Ma forse i giovani che oggi disertano le giornate di studio proposte dal DECS – quei giovani colleghi che sono ancor fuori dalle stanze dei bottoni, anche perché momentaneamente ci siamo noi – sapranno escogitare le giuste risposte agli stimoli di HarmoS: per costruire una nuova scuola degna della nostra tradizione (e nella speranza che a nessuno venga in mente di restaurare il passato, ripescando ginnasio e scuola maggiore). Allora – si parla del 2020 o giù di lì – noi dei ’40 e dei ’50 avremo levato le tende. Da saggi pensionati potremo trascorrere la quiescenza lagnandoci dei bei tempi andati, proprio come hanno fatto i colleghi che ci hanno preceduti nella loro battaglia contro la scuola media, annessi e connessi. Nel frattempo è difficile immaginare che Berna avrà inviato le sue truppe su Bellinzona per farci rispettare gli accordi che non abbiamo voluto o saputo girare a nostro vantaggio: con l’originalità di pensiero di cui ci piace vantarci.
Un’esperienza, viaggiando nel mondo della scuola
Nell’agosto del 2001 – ormai oltre settanta articoli fa – ho dato il cambio all’amico e collega Emilio Franti nella gestione di questa rubrica, con la piena consapevolezza che esperienze di questo tipo non possono durare oltre un ragionevole lasso di tempo. Discorrendo con lui – che cercava con modi suadenti di convincermi a subentrargli, perché ero del tutto restio a raccogliere il testimone – avevo capito che l’impegno poteva diventare assillante: il vincolo più o meno quindicinale presta il fianco alla ripetitività, ciò che porta a contrarre abitudini e vezzi, a tutto svantaggio del lettore. Meglio, quindi, se continuerà a perdurare la buona usanza della rotazione.
Oddio, non che i miei lettori fossero una schiera infinita… Tutti parlano di scuola e di educazione, perché tutti, in tempi più o meno prossimi, hanno frequentato una qualche scuola. E nel caso se ne siano usciti con le ossa rotte, avranno pur trovato qualche immancabile capro espiatorio, così da avere in mano, più tardi, l’infallibile ricetta dell’uovo di Colombo per appianare ogni seccatura. In questi quattro anni, tuttavia, ho cercato – non sta a me dire con quale esito – di parlare di istruzione e di educazione prendendo le distanze dai soliti stereotipi. Nel mondo della scuola, quella istituzionale, vi sono dei must imprescindibili, che vengono a galla con ciclica regolarità: il numero di allievi per classe, le note, la triade maestro-aula-allievi, l’immarcescibile selezione scolastica, che, socialmente, non è per niente cieca (anzi ci vede benissimo, e sa dove abbassare la mannaia). Ho quindi cercato di orientarmi in un mondo che sconcerta sempre più, dominato com’è dalla globalizzazione e dall’individualismo, in cui altri veicoli fuori dall’aula la fanno da padroni – almeno in parte anche grazie all’ignavia dei sistemi scolastici, sempre al traino di chi strilla più forte.
Per me, comunque, si è trattato di un’esperienza stimolante e nel contempo avvincente, perché i problemi della scuola di oggi sono i problemi di una società dominata dagli interessi particolari, da un gran numero di specchietti per allodole, dalla crescente complessità che aiuta a perdere irrimediabilmente la bussola e ad accrescere così il suo disorientamento. Chi, almeno una volta, non ha dovuto affidarsi al proprio intuito per decidere come esprimersi – sì o no – in occasione di qualche chiamata alle urne su temi finanziari, bio-etici, economici o sociali? Chi, mesi dopo, non si è sentito platealmente turlupinato perché il suo sì (o il suo no) gli si era rivoltato contro, colpendolo con un poderoso pugno sul naso? Eppure la scuola, questa nostra scuola che tanto spreme in termini economici e che influenza il nostro vivere quotidiano anche senza che ce ne accorgiamo, continua imperterrita nel solco della consuetudine, senza nemmeno intuire che – fuori – il mondo cambia anno dopo anno.
Se non che, come dice qualcuno, la democratizzazione degli studi si è tramutata nella liberalizzazione dei diplomi: venghino signori!, diplomi per tutti, certificati, bachelors, masters, dottorati. Il grande business della formazione, dove non conta cosa sai fare, mentre contano – eccome! – i pezzi di carta, i legami di sangue e le giuste conoscenze, se ne fa un baffo del suo scopo primordiale: che sarebbe la formazione di cittadini consapevoli, istruiti, capaci di esprimersi e pensare. Preferibilmente con la propria testa. No, i sistemi scolastici contemporanei sono sedotti dalle sirene del plurilinguismo, del profitto, dell’informatica, del culto del corpo sano e scultoreo: consumo e m’inchino, quindi sono. Nel frattempo chissenefrega se l’italiano va in malora, se il latino e il greco non li studia più nessuno, se la valenza di discipline come la storia, la musica, la filosofia o la storia dell’arte è ai minimi storici, se i mezzi di comunicazione di massa – ufficialmente i mastini della democrazia – privilegiano il dibattito starnazzante e l’epica del centravanti, gli amori dell’attricetta di turno e le vicende matrimoniali dei Windsor. Avanti così, a martellate sulle dita.
Nel momento del congedo definitivo da questa rubrica non posso sottacere la soddisfazione per aver potuto collaborare con un giornale serio, indipendente, equilibrato e liberale – nel senso che non esercita l’antipatica istituzione della censura. Come detto, la mia esperienza “Fuori dall’aula” è stata ricca, vera, stuzzicante. Ma è giunto il momento di passare il testimone ad altri, che meglio di me sapranno interpretare la «battaglia» per avere una scuola più attenta alla diffusa preoccupazione della società civile, che vorrebbe cittadini in grado di comunicare e pensare nella nostra lingua. Perché – si sa – è con la padronanza della lingua materna che si capisce il mondo, si imparano altre lingue, si afferma la propria identità: alla quale già si attenta abbondantemente per altre vie.
Una questione di sostanza, of course!
E così da quest’anno anche il nostro Cantone, sulla scia dei più blasonati Ginevra e Vaud – per stare ai cantoni neolatini – ha la sua bella scuola elementare in lingua inglese. Gran parte dei ticinesi ne sentiva chiaramente la mancanza, tanto che, per dare risalto al lieto evento, il DECS si è fatto rappresentare al battesimo dal direttore della Divisione della scuola, Prof. Diego Erba. Stando alle cronache locali l’idea è vecchia di almeno vent’anni, ma c’è voluto nientepopodimeno che una riforma legislativa per dare la stura a questa fondamentale innovazione: «Un obiettivo che non si era potuto concretizzare – ha rilevato questo giornale il 6 settembre scorso – poiché la legislazione cantonale non consentiva agli studenti residenti nel Cantone di frequentare la scuola elementare non in lingua italiana. La recente revisione della legge scolastica cantonale – avvenuta grazie alla collaborazione tra il Dipartimento e il Consiglio di Stato da una parte e diverse associazioni, tra le quali la Camera di Commercio Americana in Svizzera, dall’altra – ha reso possibile lo sviluppo di quest’iniziativa a condizione che vengano impartite lezioni in lingua italiana pari al 20 per cento delle ore totali».
Non posso sapere come si ossequierà quest’ultima condizione, ma non è così difficile immaginarlo. Da tempo immemore, ormai, tutte le scuole includono nel loro pacchetto “tutto compreso” ben più di un quinto di attività non propriamente sostanziali, per cui ci vuole veramente poco per inventare quelle cinque o sei ore settimanali durante le quali ci si perita di comunicare nell’idioma dei Chiesa e degli Orelli. D’altra parte ben prima di questa trovata mercantile dell’American School di Montagnola esistevano, qua e là in Ticino, scuole svizzero-tedesche, dove in italiano non ti rispondevano nemmeno al telefono. Ma che ci vogliamo fare? Ormai il settore pubblico della formazione sta cedendo sempre più al privato, al di là del risulto popolare della memorabile votazione del 18 febbraio 2001: se la scorsa settimana a Montagnola era presente ufficialmente il nostro DECS al varo della prima scuola elementare in lingua inglese, non è raro trovare qualche politico che stringe mani e butta là due parole in occasione di questa o quella manifestazione promossa da scuole private: sarebbe curioso fare una statistica, ma credo che, proporzionalmente, sia più facile trovare l’onorevole di turno o il grand commis dello Stato – poniamo – alla consegna dei diplomi della Villa Erica di Locarno piuttosto che in una qualsiasi scuola obbligatoria del Cantone.
Ma il bello è che, pochi giorni dopo l’inaugurazione della grande novità pedagogica ticinese in cima alla Collina d’Oro, è arrivata una singolare e simpatica notizia dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale, che raccomanda di inserire nella legge sulle lingue il principio secondo cui «La Confederazione e i cantoni si adoperano congiuntamente affinché la prima lingua straniera insegnata sia una lingua nazionale». Sarà che noi – quando fa comodo – diventiamo un affettato “Sonderfall”; sarà che a furia di menarla con l’importanza dell’inglese c’è venuto naturale cambiare addirittura la legge per fare un cortesia alla Camera di Commercio Americana in Svizzera: ma rischiamo di rimediare l’ennesima figuraccia, perché – come ha scritto questo giornale – «Se le Camere dovessero confermare la decisione della commissione, i cantoni che hanno optato per l’inglese dovranno fare dietrofront»: noi abbiamo addirittura concesso l’inglese prima ancora dell’italiano. D’altra parte lo stesso Consigliere di Stato direttore del DECS, in risposta ad un attacco un po’ di casta giunto dal “Movimento per la scuola”, negli scorsi giorni ha scritto che «… bisogna spostare l’auspicato dibattito dalle preoccupazioni sindacali, contabili e di risparmio alle questioni di sostanza». Appunto.
«Attenzione! Scuola pericolosa!»
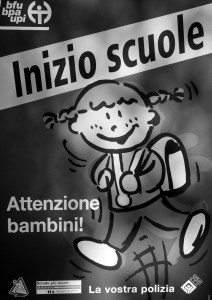 Ha proprio fatto bene, la nostra Polizia, a mettere in guardia i bambini sul fatto che, da oggi, si torna sui banchi di scuola. La scelta, ancorché un po’ strampalata, è ragionevole, perché la scuola non è più quella di un tempo: bambini e ragazzi iniziavano la scuola magari storcendo il naso, perché sapevano chiaramente che le vacanze erano terminate e che, da quel momento in poi, per un po’ di mesi avrebbero dovuto sgobbare per imparare competenze e nozioni. Da qualche anno, però, la scuola sembra cambiata: non è più quella riserva protetta in cui si impara a scrivere, leggere e far di conto.
Ha proprio fatto bene, la nostra Polizia, a mettere in guardia i bambini sul fatto che, da oggi, si torna sui banchi di scuola. La scelta, ancorché un po’ strampalata, è ragionevole, perché la scuola non è più quella di un tempo: bambini e ragazzi iniziavano la scuola magari storcendo il naso, perché sapevano chiaramente che le vacanze erano terminate e che, da quel momento in poi, per un po’ di mesi avrebbero dovuto sgobbare per imparare competenze e nozioni. Da qualche anno, però, la scuola sembra cambiata: non è più quella riserva protetta in cui si impara a scrivere, leggere e far di conto.
No, ora a scuola si realizzano faccende ben più complesse e multiformi. In parte per stimoli interni – ispettori, pedagogisti, insegnanti, … – e in altra parte per spintarelle estrinseche – i genitori, l’opinione pubblica, il parlamento, … – la scuola di oggi “fa” molte più cose: un sacco di lingue straniere, l’alimentazione e il sesso, l’educazione stradale e l’informatica, e via enumerando secondo la propria inventiva e la propria esperienza. Da anni non passa giorno senza che a qualcuno non venga in mente qualche nuova stramberia di cui la scuola dovrebbe occuparsi.
È fuor di dubbio che negli ultimi anni la nostra scuola, solo in parte inconsapevolmente e in ogni caso senza una precisa coscienza dei propri limiti, ha voluto strafare, e si ritrova oggi a esser ripagata col tipico calcio dell’asino: perché gli osservatori internazionali vengono a dirci che i nostri ragazzi non sanno leggere, e che anche in ambito matematico non tutto fila via liscio come l’olio. Nel contempo lo Stato, stretto nella morsa delle difficoltà economiche, toglie risorse un po’ qua e un po’ là, aggiungendo difficoltà a difficoltà. Infine – è notizia del giugno scorso – ci si mettono gli ambienti economici, che dopo aver imposto informatica e inglese ora pretendono che la scuola potenzi le refezioni e incrementi il doposcuola: per meglio rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano (ma delle recenti proposte di Avenir Suisse – che si definisce Think tank for economic and social issues (letteralmente un «serbatoio pensante su argomenti economici e sociali») –avrò forse modo di discorrere prossimamente).
Certo che a guardarsi attorno vien da dire che la scommessa di oggi abita proprio in queste grandi accozzaglie di ruoli: la posta che vende occhiali, i telefoni portatili che scattano fotografie, le stazioni di benzina che spacciano alcolici e salumi, il negozio di elettronica che vende caffé. Personalmente non mi dà fastidio comprare il pane dal benzinaio, mentre il telefonino pieno di carabattole mi irrita assai. Ma ancor più sgradevole è il vedere un’istituzione fondamentale come quella scolastica ridotta sempre più a livello di un qualsiasi emporio di quartiere, che deve rispondere alle esigenze più mutanti e bizzarre della clientela locale.
Questa scuola, per farla breve, sconcerta, frastorna e disorienta. Alcune moderne conquiste delle scienze dell’educazione permetterebbero per davvero di avere una scuola migliore, in cui tutti – anche i figli dei soliti poveri diavoli – possano per davvero crescere al massimo delle proprie individualità; ma occorrerebbe la modestia di limitarsi a svolgere onestamente i propri compiti storici: che sono pochi ma difficili. Invece l’attualità ci dice che abbiamo imboccato altre strade, improntate alla finzione e all’equivoco.
Attenzione, quindi, bambini (e ragazzi, genitori, insegnanti, direttori, ispettori ed esperti): sono iniziate le scuole. E son colme d’insidie.
