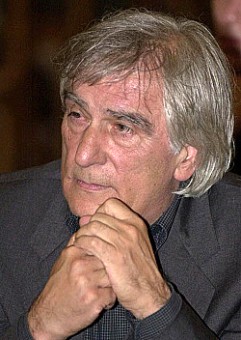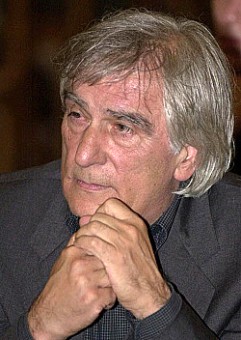 Il mio primo incontro con Bepi De Marzi risale a molti anni fa. Avevo seguito un concerto con i suoi «Crodaioli» nel salone della SES a Locarno. Molte cose mi avevano colpito e commosso. Ricordo ancora con commozione il canto L’aqua zè morta, potente e rabbioso, e nel contempo di grande poesia.
Il mio primo incontro con Bepi De Marzi risale a molti anni fa. Avevo seguito un concerto con i suoi «Crodaioli» nel salone della SES a Locarno. Molte cose mi avevano colpito e commosso. Ricordo ancora con commozione il canto L’aqua zè morta, potente e rabbioso, e nel contempo di grande poesia.
Poi, tanti anni dopo e in una circostanza molto triste, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di parlargli e di mantenere un legame, seppur solo epistolare (l’epistola elettronica). Quando ho aperto questo Cose di scuola ho mandato una comunicazione ai miei contatti. Lui mi rispose a stretto giro di posta elettronica: «Potrei collaborare, magari rispondendo a qualche tua domanda sulla mia esperienza di insegnante». Le mie domande sono andate oltre le sue esperienze di scuola. Ma, insomma, eccoci qua.
Voglio cominciare questa chiacchierata da un dettaglio divertente. Introducendo il canto «La sagra» (dove gò visto la mè Maria), raccontò di una sua visita a un asilo infantile in qualche paesino dalle sue parti. Parlò di una bambina di tre o quattro anni, col moccio ciondolante, che si chiamava già Samantha… Maestro, perché Maria è meglio di Samantha?
Il nome dato dai genitori si porta per tutta la vita e riesce perfino a segnarla, a condizionarla, in bene o in male. Ho in mente tanti “Christian” che poi non hanno nemmeno il coraggio di scristianizzarsi; penso alle Deborah che devono aggiungere “si scrive con l’acca!”. Ci sono le piccole Katiuscie che a scuola precisano stanche “con la cappa e con la i”. E i poveri Igor? i Patrik? La figlia di una mia dolcissima amica si chiama Michelle; ha dodici anni e da quando era alla scuola materna continua a ripetere “si scrive come Michele ma con due elle”.
Dopo il ’68 si è cominciato a credere che a scuola era più importante saper fare e saper essere che sapere e basta. Era una battaglia giusta contro lo sterile nozionismo, per lo più usato come arma impropria per la selezione sociale. Però oggi si comincia a dire che le nozioni, se non le hai, sei un ignorante. A quasi cinquant’anni di distanza la scuola, e non solo quella dell’obbligo, ha preso derive tecnocratiche. A farne le spese sono innanzitutto talune discipline «inutili», vale a dire del tutto inservibili sul piano della spendibilità immediata. Penso, in particolare, alla Storia – la storia da insegnare nel solco dell’eredità di Fernand Braudel e di Jacques Le Goff. È importante studiare la storia?
Come viene proposta a scuola è proprio inutile. L’insegnante dovrebbe dire: “Io sono la storia e vi racconto il mio ieri: la mia famiglia, i miei studi, le mie fatiche, le mie felicità, i miei desideri realizzati o tralasciati”. E spaziare progressivamente lungo il tempo. Conosco un professore di Storia dell’Arte che in una celebre Università veneta spiega come si deve “leggere” un quadro proiettando la sua faccia, cominciando a ridere del naso, delle rughe, dei capelli tinti. “Contiamo i peli della barba”, esordisce. E gli allievi non lo abbandonano più.
Ma veniamo alla musica, il suo mestiere. Perché far musica assieme è importante, al di là del fatto artistico in sé e dell’insito divertimento?
Divertimento? Neanche far bene l’amore deve essere solo divertimento! “Il genio è una lunga fatica”, diceva Mozart. Chi dice “mi diverto” è uno che non sa cosa sia lo studio, il lavoro. Tutto, sempre, deve essere impegno e partecipazione cosciente. Far musica insieme, suonando o cantando, è come lavorare collettivamente a una costruzione. Poi si insinua il tarlo dell’esibizione, del mostrarsi, del farsi ascoltare. E il lavoro diventa ansia, competizione. Fino alla cattiveria della rivalità. Organizzare i bambini, gli adolescenti per mostrarli in gruppi corali è un’operazione discutibile. E si crede di invogliarli alla musica obbligandoli a cantare storie, opere, che niente hanno a che fare con la loro età.
A una mamma che gli diceva: “Il mio bambino ha solo nove anni e suona il Chiaro di luna di Beethoven”, il grande pianista Arthur Rubinstein ha risposto: “Provo pena per il suo bambino, ma anche per Beethoven”.
Il pedagogista francese Philippe Meirieu ha scritto: «Alla domanda: “Quale mondo lasceremo ai nostri figli?” – quesito che resta attuale come mai – è oggi urgente aggiungerne un’altra: “Che figli lasceremo al mondo?”». Allora, Maestro: come dovrebbero essere i figli che lasceremo al futuro?
Non dovrebbero somigliare troppo a noi. A noi che non leggiamo più, ma che scriviamo e scriviamo per pubblicare a nostre spese ciò che nessuno legge. A noi che non sappiamo più ascoltare nemmeno la musica, ma che ci crediamo compositori mettendo insieme tre o quattro note con i programmi e i suoni freddi del computer. A noi che per cantare in coro facciamo grottescamente cabaret con mossette e deambulazioni da orsi ammaestrati. A noi che perdiamo i giorni nelle rivendicazioni di autonomia, di indipendenza, magari con l’inutile e puntiglioso sostegno del dialetto. Noi che abbiamo distrutto l’ambiente con i capannoni e le costruzioni assurde, anche di qualche chiesa impraticabile o di qualche strampalata struttura alberghiera in montagna; noi che vogliamo lavorare poche ore al giorno per poi annoiarci nel cosiddetto tempo libero che diventa incomunicabilità o trama e ordito del pettegolezzo.
Ho letto che ha lasciato Arzignano, il paese dove è nato e ha sempre vissuto, perché si è lasciato prendere dal leghismo imperante. Ma dove andrà, in questa Europa percorsa da fremiti sempre più populisti, banali, xenofobi, paurosi, ripiegati su se stessi nel difendere le proprie miserie?
Per ora abito a Vicenza, in un quartiere di periferia che pare un bosco. Confesso di non essere mai stato legato a un solo luogo. Come, nonostante qualcuno mi creda un sentimentale, non sono né nostalgico e nemmeno attaccato alle tradizioni. Come dice Olmi di se stesso, “sono un uomo di sentimenti”. Ma anche di passioni. La vergogna di questo tempo è il nazionalismo. E i fanatismi religiosi sono un altro drammatico pericolo per l’umanità.
Si dice che questo è un mondo forgiato dalle diverse globalizzazioni, dalla finanza arrogante, dalle incertezze per il futuro. E se fosse anche un mondo figlio di un’educazione pressappochista e mollacciona? Costruire e mantenere la democrazia è un percorso faticoso.
La democrazia, quasi ovunque, è al limite dell’illusione. In Italia, con questo ducetto toscano onnipresente e becero, con la montante xenofobia attizzata dalla Lega sottobraccio ai neofascisti, poi con la sotterranea e torva presenza condizionante del potentissimo pregiudicato, ci crediamo liberi. Possiamo chiamarlo il regime dei miliardari? delle banche?
Il mondo la conosce soprattutto come autore della splendida «Signore delle cime», un canto che, secondo me, si sta però banalizzando e svuotando della sua forza artistica. Colpa della ridondanza e del “pensiero” unico: ormai è diventato un must in talune circostanze, un po’ come l’«Ave Maria» di Schubert o le marce nuziali di Mendelssohn e Wagner. Personalmente trovo tante altre sue composizioni di una forza incredibile. E mi appassionano il suo impegno civile, il suo amore per Mario Rigoni Stern, per Padre Turoldo e per le cose semplici.
Beh, non posso dire di accontentarmi delle cose semplici. Amo le melodie tonali, comprensibili; ma ai miei allievi di Conservatorio ho insegnato le fughe, i contrappunti, le costruzioni polifoniche, le grandi forme musicali, pur esprimendomi poi nel minimalismo dei canti di ispirazione popolare, nei Salmi o nei mottetti per la liturgia. Ho studiato la dodecafonia tanto da considerarla lo sberleffo di una persona solitaria e geniale. Ma c’è qualcuno che la sta scoprendo adesso e ci si crogiola dentro. Mi indispongono tante espressioni pseudoartistiche, specialmente nella pittura e nella scultura. Il grande Cioran ha detto che “non si può amare ciò che non si comprende”. Il massimo della mia passione musicale moderna sta nelle Metamorfosi di Strauss, la disperazione di un genio davanti alle distruzioni della guerra.
Ma si stava parlando di Signore delle cime e degli altri canti. Li ha mai contati?
Forse ne ho composti più di centocinquanta. Sinceramente, non lo so. Ma, è vero, nella mia piccola storia c’è soprattutto Signore delle cime. L’ho ascoltato in questi giorni in una versione rock che mi ha stupito, affascinato, perfino commosso. Dobbiamo rinnovarci continuamente, ma dentro la certezza della sincerità, soprattutto nell’ebbrezza della poesia. Ho avuto la fortuna di avere dei meravigliosi amici e maestri. Nella vita ho obbedito solo a tre persone: mia mamma, mio papà e il maestro Scimone suonando l’organo e il clavicembalo nei Solisti Veneti. Sono credente, ma sono anche dolcemente anticlericale: la gerarchia ecclesiastica mi sorprende per il nulla che autorappresenta, per l’infantilismo dei paludamenti, per la teatralità delle liturgie infarcite di filastrocche e di pessima musica: perché la nuova musica della Chiesa cattolica è vergognosa. Pur nella malinconia che domina il mio carattere, mi confesso dolcemente ironico e teneramente anarchico.
Giuseppe De Marzi, detto Bepi, musicista, è nato ad Arzignano, nella Valle del Chiampo, dove ha abitato fino al 2011, prima di trasferirsi a Vicenza.
Ha insegnato Educazione Musicale a Valdagno, in una scuola media a tempo pieno. Maestro di Organo e Composizione organistica nell’Istituto Comunale “Canneti” di Vicenza, sezione staccata del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, ha insegnato anche nei Seminari Diocesani di Vicenza, chiamato da monsignor Ernesto Dalla Libera.
A Vicenza ha fondato e diretto per qualche anno il Coro Polifonico “Nicolò Vicentino”.
Poi ha scelto definitivamente l’insegnamento nel Conservatorio “Pollini” di Padova diretto da Claudio Scimone. E subito, lo stesso celebre maestro padovano, lo ha voluto come clavicembalista e organista nei prestigiosi Solisti Veneti.
La notorietà del musicista vicentino è dovuta soprattutto alla fondazione e alla direzione, tuttora vivace e sempre innovativa, del gruppo corale maschile “I Crodaioli” di Arzignano, con il quale ha proposto, attraverso le Edizioni Curci di Milano, più di cento composizioni – parole e musica – di ispirazione popolare, prima fra tutte “Signore delle cime”, canto diffuso nel mondo, tradotto in varie lingue, elaborato anche in versioni sinfoniche perfino in Giappone. Recentemente, il maestro Scimone ha chiesto a De Marzi di realizzarne una fantasia per archi da proporre nei concerti dei Solisti Veneti con il titolo “Trasparenze su Signore delle cime”. Con l’amico poeta Carlo Geminiani, il popolare Bepi ha composto una decina di canti entrati nella tradizione alpina, e basti ricordare “Joska la rossa”, “L’ultima notte”, “Il ritorno”, “Monte Pasubio”. Con un altro grande amico, Mario Rigoni Stern, ha composto il canto “Volano le bianche” che ricorda la guerra sull’Ortigara.
Nel 1970, padre David Maria Turoldo ha chiesto a De Marzi di affiancare il giovane intellettuale e musicista Ismaele Passoni nella composizione musicale di Salmi, Inni e Cantici che aveva realizzato stroficamente per il rinnovamento della liturgia, composizioni che la Chiesa non ha accettato proprio per la loro intensità poetica e per l’emozionata cantabilità.
De Marzi ha pubblicato con la casa Musicale Carrara di Bergamo molta musica didattica per la Scuola Materna e Elementare, oltre ai Canti per il Battesimo, la Cresima e il Matrimonio con testi del poeta Giovanni Costantini. Fecondo scrittore, soprattutto con interventi giornalistici nel Giornale di Vicenza, si produce in conferenze con argomenti musicali e di costume. La mamma milanese e il papà veneto gli hanno trasmesso l’instancabilità nel lavoro, l’irrefrenabile fantasia, l’inquietudine nella fede, l’indipendenza e la sottile ironia nei rapporti sociali che Bepi manifesta anche in una malcelata malinconia.