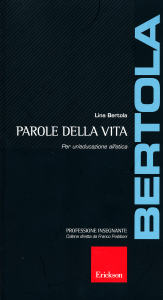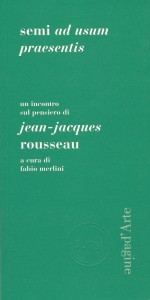La campagna in vista della votazione sull’iniziativa «Aiutiamo le scuole comunali», iniziata in primavera, ha moltiplicato a dismisura gli interventi sulla stampa. Dal fronte del sì e da quello del no giungono motivazioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi che vanno ad arricchire la già nutrita serie dei colori dell’iride. Non ho naturalmente letto e ascoltato tutto ciò che è stato scritto e detto. Sono stato costretto a una selezione, perché, a dispetto dell’essere in pensione, non posso mica passare le giornate a leggere di tutto e di più sulla scuola ticinese e i suoi dintorni.
Ma, qua e là, ho colto qualche sparata degna di citazione. Eccone tre che mi hanno colpito per l’originalità della traiettoria.
- Per replicare a chi afferma che se quest’iniziativa fosse accolta dal popolo il margine decisionale dei comuni si avvicinerebbe allo zero, qualcuno ha affermato che «La scuola comunale rimane ai comuni per quanto riguarda la scelta dei docenti, del direttore, dell’edilizia e tante altre cose; e soprattutto la vigilanza. Però è importante che su tutto il territorio cantonale tutti abbiano le medesime opportunità». Quando si dice l’autonomia – e senza tornare al merito delle ormai famose «pari opportunità», che son diventate il classico nebbione che nasconde e confonde tutto. L’autonomia: babbo Stato impone ai comuni auto costose e non necessariamente adeguate a ogni particolare territorio. Naturalmente il Comune paga una sostanziosa parte del costo (e non è un leasing). Poi può scegliere il colore dell’auto e chi la guida. Addirittura ha l’autonomia di verificare che l’auto funzioni come si deve. Per finire può (eh eh!) finanche costruire una bella autorimessa, possibilmente Minergie.
- «Con più la classe è numerosa, più il maestro è costretto a fare delle lezioni frontali, delle lezioni cattedratiche». Questa l’ha detta un caro amico e ormai ex collega, che conosce bene le esperienze di Don Lorenzo Milani, tanto per citarne uno tutt’altro che a caso. Un Maestro che non la pensava proprio così, anzi. Si vede che il caro amico e ormai ex collega è ancora attratto dal magister, sul modello universitario; l’unica alternativa possibile sarebbero classi sufficientemente piccole, affinché sia possibile dare “lezioni private”. Tertium non datur.
- Della terza chicca ho perso l’autore e il giornale che l’ha ospitata. Riassumo a memoria: l’opinionista di turno è d’accordo che si diminuisca il numero di allievi per classe. Ma ritiene che tra 25 e 15, 16 o 20 non cambi gran che. Bisognerebbe fare classi veramente piccole, di otto o dieci allievi. Vabbe’, pian piano torneremo al precettore di aristocratica memoria.
Un’interessante intervista al ministro dell’educazione
Ma torniamo alle cose serie. Manuele Bertoli, che da presidente del Partito socialista era tra i promotori dell’iniziativa e che da Direttore del DECS aveva proposto un compromesso al Parlamento, oggi, da Presidente del Consiglio di Stato, si ritrova a sostenere il punto di vista della maggioranza governativa, come noto contrario all’iniziativa. E lo sta facendo con grande correttezza: tanto di cappello. L’11 settembre ha rilasciato una lunga intervista al Corriere del Ticino, pubblicata col titolo «Scuola, oggi sono tenuto a dire no». Non entro nuovamente nel merito dei soliti capitoli trattati dall’iniziativa, ma voglio sottolineare una sua affermazione significativa, importante e fuori dal coro.
Domanda del giornalista: «È vero che portare a 20 allievi l’asticella potrebbe generare l’effetto perverso dell’aumento delle pluriclassi?».
Risposta del ministro Bertoli: «Lo abbiamo segnalato nel documento consegnato alla Commissione scolastica sugli effetti quantitativi che dava conto dei costi dell’iniziativa. È vero che in alcune zone il numero di pluriclassi potrebbe aumentare perché non sarebbe data la possibilità di fare monoclassi da 22 o 23 allievi e quindi si andrebbero a comporre sezioni con più classi al loro interno. Bisogna però non drammatizzare troppo il tema, le pluriclassi non sono necessariamente un male. Alcuni sostengono addirittura che sono utili nella misura in cui chi è più debole può, quando segue la classe più avanzata, ascoltare e ripetere quanto fatto l’anno prima e chi è più forte, nella classe meno avanzata, può già sentire cosa farà l’anno successivo. Comunque l’iniziativa porta ad un aumento delle pluriclassi, anche se la situazione è molto differenziata sul territorio».
Era ora che qualcuno lo dicesse, non fosse che per il grande rispetto verso i tanti maestri che insegnano bene e da anni nelle pluriclassi [1]. Ma è ora e tempo di finirla con la storiella che le pluriclassi siano una sorta di male necessario allorché, per far funzionare le alchimie numeriche e nell’impossibilità di poter istituire le tanto agognate monoclassi, si è costretti a mettere insieme allievi di classi diverse. Prendendo a prestito un recente tormentone di Celentano – mi si passi la citazione bislacca – la pluriclasse è rock, mentre la monoclasse è lenta.
Non è questa la sede per sintetizzare i tanti vantaggi della pluriclasse e il primato educativo della massima eterogeneità. Chi è interessato ad approfondire il tema può rivolgersi all’ampia letteratura in materia. Se si vuol trovare qualche spunto, magari leggermente provocatorio, si può dare un’occhiata al capitolo che Philippe Meirieu dedica all’eterogeneità nel suo libro L’école ou la guerre civile, che può essere consultato e scaricato qui: Pour un nouveau contrat entre la société et son école: “vive l’école obligatoire”! (da pagina 108).
L’omologazione è nemica dello sviluppo, della crescita e della creatività
La monoclasse è parente stretta di quella classe che si è stabilizzata nel XIX secolo, basata essenzialmente sul corso ex cathedra, e nasconde in modo subdolo la selezione delle future élites attraverso la legittimazione degli status socio-economici e culturali di partenza. Se è questa la scuola che si vuole, lo si dica con chiarezza. In caso contrario occorrono «delle riforme di carattere più pedagogico» per la scuola dell’obbligo (Manuele Bertoli, nella medesima intervista citata), per staccarsi esplicitamente e senza alibi quantitativi dall’organizzazione del lavoro quotidiano degli insegnanti che ruota attorno a lezioni uguali per tutti, esercizi uguali per tutti, tempi uguali per tutti e valutazioni uguali per tutti da effettuarsi nei medesimi momenti per tutti – col servizio di sostegno pedagogico a inseguire i danni provocati da questa maniera di affrontare la scuola dell’obbligo, senza mai arrivarne a capo.
Sarò vecchio, ma resto vicino alle finalità che il nostro Parlamento ha definito per la scuola dell’obbligo: formare cittadini. Cioè educare e istruire, perché non esiste un concetto di cittadino ignorante, mentre è facile allevare idioti specializzati, vale a dire uomini e donne super-specialisti nella loro disciplina, che non sanno assolutamente nulla delle discipline altrui.
Nell’ultimo decennio la scuola è divenuta sempre più utilitaristica. Cioè a dire: si è votata anno dopo anno alle conoscenze sterili e specialistiche (pardon, oggi le chiamano competenze).
Una scuola siffatta ha bisogno di strutture coerenti. Oddio: da sempre la scuola tende a omologare i gruppi, come avevo scritto in un articolo «Fuori dall’aula» del 2009, prendendo spunto da un’estemporanea proposta che voleva reintrodurre la separazione dei sessi nella formazione delle classi: Classi maschili e femminili nella scuola media? Così come, in due altre puntate della mia rubrica sul Corriere del Ticino, mi ero occupato dell’omologazione delle classi (I ghetti del XXI secolo) e dell’individualizzazione esasperata dell’insegnamento (Nel grande emporio della formazione).
I vantaggi della pluriclasse
Detto questo, parliamo un poco delle pluriclassi, con un plauso al ministro Manuele Bertoli, che, seppur timidamente (le pluriclassi non sono necessariamente un male), ha avuto il coraggio di dire quel che sarebbe stato preferibile sentire, da sempre e non solo da ieri, da ispettori, direttori e funzionari del Dipartimento. In questo Cantone le pluriclassi sono normalmente istituite quando non è possibile fare altrimenti, vale a dire quando i numeri non permettono l’istituzione delle tanto bramate monoclassi, quasi che il mettere insieme allievi più o meno della stessa età risolvesse motuproprio il problema dell’insuccesso scolastico.
Dovremmo chiederci, per cominciare, se vi sono dati chiari che indichino se vi sono significative differenze tra le competenze che si acquisiscono in una monoclasse rispetto alla pluriclasse. Nel contempo: da una trentina d’anni si ripete che, mono o pluri che sia la classe, è fondamentale differenziare l’insegnamento, badando bene al fatto che differenziare non è l’equivalente di individualizzare. Anche in questo caso l’insegnante è la trave portante della scuola: il maestro che non sa o non vuole differenziare il suo insegnamento, optando per troppe chiacchiere cattedratiche ed esercizi uguali per tutti, sarà ancor più in difficoltà in una pluriclasse. Ma se non sa o non vuole, non è al suo posto.
Vi sono sedi scolastiche che non conoscono le monoclassi, perché i numeri non l’hanno mai permesso. Però anche in questi casi ogni tanto non mancano le soluzioni perverse o, quantomeno, poco ragionevoli. Ho incontrato a fine agosto una bravissima maestra che lavora in una di queste piccole sedi. Mi ha detto che quest’anno le è stata assegnata una 1ª/2ª/3ª di 24 allievi, mentre la sua collega avrà una 4ª/5ª di 16 allievi. In quella sede ci sono dunque 40 allievi. Non sarebbe stato più logico istituire due pluriclassi di 20 allievi? O, meglio ancora, non sarebbe stato più razionale istituire un’unica sezione di cinque classi e 40 allievi affidata a due docenti a tempo pieno, quasi certamente con la presenza di un docente d’appoggio? Per dirne una, un’organizzazione siffatta avrebbe offerto la possibilità di far variare il numero di allievi a dipendenza dell’attività da svolgere. Per esemplificare, con un caso semplice semplice, e farmi capire: mentre 20 allievi sono in palestra con il docente speciale, due maestre possono occuparsi di 20 allievi. Le combinazioni sono naturalmente infinite.
In altri anni c’era stata la moda dei consorzi. Mi viene in mente il caso della Vallemaggia. Negli anni ’70 si era costruito e istituito il Centro Scolastico Bassa Vallemaggia, azzerando con un colpo di spugna le scuole di nove comuni (Avegno, Gordevio, Aurigeno, Moghegno, Maggia, Lodano, Coglio, Giumaglio e Someo). Il nuovo centro sembra una scuola di città. Ha la palestra e le sue brave monoclassi. Costa un sacco di soldi, costringe un gran numero di bambini e ragazzetti a trasferte giornaliere coi bus. I villaggi non hanno più la loro scuola (uh, le pluriclassi…) e la nuova scuola assomiglia a tutte le altre. Cosa ne abbia guadagnato la Valle in termini di educazione e istruzione non si sa.
 Le scuolette di paese. Anni fa avevo avuto occasione di visitare una scuola a Ginevra, «La Barigoule», nel quartiere di Malagnou, a quei tempi diretta da un bravissimo Jean-Claude Brès [2]. Ricordo un piccolo edificio a due piani, su una collinetta, attorniato da palazzi che fanno sembrare «La Barigoule» a una specie di isola in mezzo all’oceano (la foto mostra una ristrutturazione recente; io parlo di oltre vent’anni fa). È una scuola che ha scelto L’école active, malgrado i locali esigui, i banchi e il mobilio raffazzonati (forse scarti di scuole pubbliche rammodernate). Ma vi si respirava un’aria entusiasmante e vivace, generatrice di educazione, sostenuta da un gruppo di insegnanti appassionati e ben consapevoli del loro ruolo. Alle monoclassi e al mobilio scintillante e moderno avevano preferito la forza delle idee e del rigore.
Le scuolette di paese. Anni fa avevo avuto occasione di visitare una scuola a Ginevra, «La Barigoule», nel quartiere di Malagnou, a quei tempi diretta da un bravissimo Jean-Claude Brès [2]. Ricordo un piccolo edificio a due piani, su una collinetta, attorniato da palazzi che fanno sembrare «La Barigoule» a una specie di isola in mezzo all’oceano (la foto mostra una ristrutturazione recente; io parlo di oltre vent’anni fa). È una scuola che ha scelto L’école active, malgrado i locali esigui, i banchi e il mobilio raffazzonati (forse scarti di scuole pubbliche rammodernate). Ma vi si respirava un’aria entusiasmante e vivace, generatrice di educazione, sostenuta da un gruppo di insegnanti appassionati e ben consapevoli del loro ruolo. Alle monoclassi e al mobilio scintillante e moderno avevano preferito la forza delle idee e del rigore.
Célestin Freinet (1896-1966) ha spesso operato con pluriclassi piuttosto numerose. In quei primi decenni del ’900 i dibattiti attorno all’educazione come strada di progresso e di emancipazione politica e civica sono intensi. Accanto alla scuola «ufficiale», che classifica gli allievi e seleziona le élite, crescono e si diffondono movimenti che approfondiscono la cooperazione tra allievi, la corrispondenza scolastica, la differenziazione come forma di rispetto dei ritmi di ognuno, il rigore della conoscenza. Lo stesso Freinet si butta nell’esperienza dell’Educazione nuova, entra in contatto con John Dewey, Adolphe Ferrière, Ovide Decroly, Roger Cousinet.
Chissà: forse le scuole ispirate dai modelli dell’educazione nuova non sono mai riuscite a offuscare la vecchia scuola «ufficiale» proprio perché i suoi principi e le sue finalità tendono per davvero all’emancipazione. Quell’altra scuola, ancor molto legata nella sua organizzazione e nelle sue strutture a quella dei suoi albori (XVIII e XIX secolo), ha saputo superare anche il ’68 e arrivare sin qua, pimpante e cinica, pronta ad affrontare le prossime riforme gattopardesche: tanto ci sarà sempre qualche nuovo gruppo sociale da bocciare ed escludere. C’è sempre bisogno di braccia che, soprattutto, stiano zitte.
Mi fermo qui, per oggi. Sono convinto che la pluriclasse, combinata col lavoro in équipe, offrirebbe tante formidabili opportunità per migliorare la scuola dell’obbligo. La ricerca affannosa dell’omogeneità – per età, per sesso, per quoziente intellettivo, per segno astrologico, per scelta religiosa… – impone di volta in volta aggiustamenti costosi. La strada affinché ogni cittadino possa dire, con l’Alfieri (e con Piero Gobetti), di non aver niente a che fare con gli schiavi è ancora lunghissima.
Poi ci sarebbero altre innovazioni per rendere la scuola più coerente col mondo che la circonda. Ma di ciò parlerò forse in altra occasione.
[1] Per intenderci: quando parlo di pluriclasse intendo ogni sezione formata da allievi che frequentano classi diverse: dai classici 1ª/2ª e 3ª/4ª/5ª alle tante combinazioni possibili, non escluse le sezioni di otto classi, ancora esistente in qualche scuoletta discosta fino a 40 o 50 anni fa (dalla 1ª elementare alla 3ª maggiore, senza saltare nessuno).
[2] En 1972, Claude Ferrière, Robert Hacco, Michael Huberman, Laurie Lamartine et Freddy Stauffer fondent une association dans le but de promouvoir la pédagogie active à Genève. Face à la difficulté d’introduire une rénovation rapide au sein de l’instruction publique, ils décident de créer une école privée. Ils font appel pour cela à différentes personnes déjà engagées dans des démarches de pédagogie active dont Jean-Claude Brès et Ariane Ferrière. (École active de Malagnou).