«Allenare i bambini non significa puntare alla vittoria. Prima devono imparare a giocare bene». Così parlò Claudio Mezzadri, grande sportivo che, a suo tempo, ha scalato le classifiche del tennis che conta. Lo ha detto durante una serata pubblica organizzata dalla Federazione Ticinese Calcio a fine novembre, sul tema «Genitori e sport», di cui ha ampiamente riferito La Regione. E ha aggiunto: «Mio papà mi ha insegnato cosa significa fare sport. Parlandomi di rispetto dell’avversario, spirito di sacrificio, imparare dalle sconfitte». Gli ha fatto eco Pierluigi Tami, allenatore della nazionale U21: «Giocare bene è importante: solamente così si raggiungono buoni risultati». È bello che simili precetti pedagogici vengano proprio dal mondo dello sport, che per sua natura è basato sulla competizione. E sarebbe ancor più bello se anche la scuola dell’obbligo basasse il suo intervento quotidiano su questa massima. Imparare bene: solamente così si raggiungono buoni risultati.
Invece a scuola è la valutazione a farla da padrona, quasi sempre insensibile alle tante diversità cognitive e culturali che si ritrovano in ogni classe. Prendiamo la prima elementare. Da noi inizia a sei anni, ma la differenza di età tra i diversi allievi può essere di quasi un anno: tanta, quando si è così piccoli. Le ricerche dicono che è verso i sei anni che un bambino è pronto per imparare a leggere e a scrivere. Se lo dicono le statistiche, significa che sarà pronto circa il 70%. E l’altro 30%? Diciamo che, teoricamente, metà avrà forse già iniziato a muovere agevolmente i primi passi tra lettere, sillabe, parole e frasi, mentre l’altra metà proprio non ne ha ancora i mezzi, che arriveranno, soprattutto se convenientemente stimolati. Così in ogni prima elementare di venti allievi potrebbero essercene due o tre che non possono ancora imparare a leggere e scrivere, e non è neanche detto che siano proprio i più piccolini. L’insegnante accorto terrà conto di questa immaturità, cercherà di sviluppare al massimo le capacità del momento e, soprattutto, incoraggerà l’allievo e rassicurerà i genitori, facendosene un baffo di studi e statistiche. Ma più spesso non è così. Capita invero che dopo neanche un mese di scuola il genitore si senta dire che il proprio figliolo è in difficoltà, che non ce la fa a tenere il passo: si può immaginare la situazione. Per non parlare della scuola media, dove il trascorrere degli anni scolastici è scandito dai test.
Fosse per me abolirei ogni forma di valutazione che serva a mettere in fila i bravi e i meno bravi, quelli favoriti dalla sorte e i soliti scalognati. Se la scuola dell’obbligo dura nove anni – saranno undici con HarmoS – si faccia in modo che ogni allievo giunga al traguardo munito delle competenze ritenute fondamentali, perché per la selezione e le specializzazioni c’è tutto il tempo dopo. Le pari opportunità impongono alla scuola pubblica la diversità degli sforzi disponibili, come si fa nel campo della sanità, della giustizia e del lavoro sociale.
Hanno scritto i ragazzi della scuola di Barbiana, quelli di don Milani: «Al tornitore non si permette di consegnare solo i pezzi che son riusciti. Altrimenti non farebbe nulla per farli riuscire tutti. Voi [maestri] invece sapete di poter scartare i pezzi a vostro piacimento. Perciò vi contentate di controllare quello che riesce da sé per cause estranee alla scuola.» Primo imparare bene, insomma. E vediamo di non aggiungere sofferenze a sofferenze.
Il gatto ha ancora gli stivali?
SCUOLA TICINESE, nel suo numero 313 di novembre-dicembre 2012, ha dedicato ampio spazio al convegno «Il gatto ha ancora gli stivali?» del 25 agosto 2012 al Teatro di Locarno.
Note attorno al convegno «Il gatto ha ancora gli stivali?», di Adolfo Tomasini
Si è svolto lo scorso martedì 28 agosto, al Teatro di Locarno, il convegno «Il gatto ha ancora gli stivali? – Perché leggere i classici a scuola, oggi e domani», organizzato dall’Ufficio delle scuole comunali del DECS e dal Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento della SUPSI, in collaborazione con la Direzione delle scuole comunali di Locarno, il Centro di Didattica dell’Italiano e delle Lingue nella Scuola (DILS) del DFA e il Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica, sezione Ticino (GISCEL-TI). Aperto con il saluto del direttore della SUPSI, prof. ing. Franco Gervasoni, e conclusosi con una riflessione del Consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore del DECS, il convegno ha riunito sull’arco dell’intera giornata circa 500 persone, tra insegnanti delle scuole comunali, studenti del DFA, autorità scolastiche, bibliotecari e altri.
Il convegno ha rappresentato un evento piuttosto inconsueto, soprattutto di questi tempi così frenetici, globalizzati, tecnocratici, con le pressioni ormai quotidiane che giungono dai settori più disparati e che vorrebbero una scuola sempre più efficiente, rapida e, soprattutto, facilmente spendibile nel mondo del lavoro. L’anomalia – che era stata una scelta consapevole – risiede in diversi argomenti.

Manifestamente contro tanta letteratura per ragazzi caratterizzata da prodotti prettamente commerciali, che vendono molto ma che presentano contenuti insulsi e forme linguistiche mediocri o anche peggio, si è scelta una riflessione sui classici, quelli della mia infanzia e di tante generazioni prima della mia, e sui classici di oggi e di domani, una serie di testi che, come hanno annotato Antonella Castelli e Orazio Dotta nella «Guida ai classici della letteratura per l’infanzia[1]», rappresenta «un sottile filo di continuità che si dipana tra ieri e oggi e collega il patrimonio dei classici ai libri contemporanei. Un filo di continuità che nonostante la trasformazione della narrativa recente, attenta ai cambiamenti dell’immaginario, rimanda ai grandi simboli fissati dai classici che ritornano e si trasformano».
Contro numerosi tecnicismi che si sono purtroppo impadroniti del potere dentro tante, troppe aule scolastiche, il convegno ha proposto una riflessione originale e lontana da certe mode di oggi, spesso tese a facilitare e banalizzare, col rischio – come hanno osservato taglienti Simone Fornara e Mario Gamba – di far crescere l’antitesi della teoria di Vygotskij: la zona di regresso prossimale, al posto di quella di sviluppo. L’idea era quindi di andare alla riscoperta dei classici della letteratura per l’infanzia suggerendo un più ampio spettro di approcci, oltre una certa tradizione un po’ ottusa che lega la lettura unicamente all’insegnamento dell’italiano.
Che cosa sono i classici?
Andare invece Alla ricerca di un tesoro perduto, i classici per ragazzi, per citare il titolo della relazione di Pino Boero[2], significa ad esempio incontrare l’India coloniale di Kim, imbattersi nell’Ultimo dei Mohicani in guerra contro i colonizzatori francesi e britannici dell’America settentrionale, duellare accanto ai Tre moschettieri nella Francia del XVII secolo, sotto il regno di Luigi XIII; mentre Ivanhoe ci riporterà indietro di qualche secolo ancora, nella leggendaria Inghilterra dei castelli e dei cavalieri “senza macchia e senza paura”, ma di una lealtà esemplare. «Faccio un esempio fra i mille possibili», ha osservato Boero. «Quando nel 1907 Ferenc Molnár pubblicò a puntate I ragazzi della via Pál, il sovrano di un Impero già in crisi non apprezzò il “parlamentarismo” del romanzo, né gradì probabilmente l’amore per la patria e l’esaltazione dell’eroismo nazionale ungherese. Ciononostante il successo fu immediato e nessun potere riuscì a impedirlo, il libro continuò il suo percorso trionfale (traduzioni in trentacinque lingue, milioni di copie vendute), a differenza dell’autore ebreo e borghese che già dagli anni Venti, lasciando prima il suo paese poi l’Europa, intuì la catastrofe che avrebbe toccato l’Ungheria: l’antisemitismo prima, il comunismo dopo, al punto che ai tempi dell’Unione Sovietica venne definito “cosmopolita borghese che ha sacrificato il talento per il successo nei paesi capitalistici”… Insomma se il libro non poteva essere vietato, era censurato il suo autore; eppure il giovane lettore non era toccato da queste vicende e il senso del libro, al di là delle contingenze storiche, stava (e sta) tutto nell’eternità dell’eroismo, nel debole che sconfigge il forte, nel dramma conclusivo che “trasforma in realtà ciò che nasce come finzione”[3]».
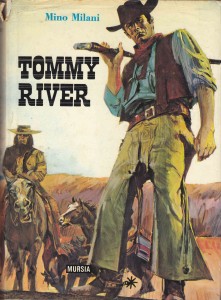 Ripercorrendo le diverse tappe del convegno, è apparsa evidente la forza direi multi-disciplinare dei classici, che spaziano ben oltre il fatto letterario in sé. Legare quasi per via naturale la lettura dei classici all’insegnamento della lingua italiana sembra quasi una banalità: attraverso i classici è possibile percorrere, quasi senza accorgersene, tanti aspetti della nostra Cultura, di natura storica, filosofica, religiosa, naturalistica, sociologica, geografica e tanto altro ancora. Tuttavia è doveroso riservare la giusta attenzione anche agli aspetti strettamente linguistici e letterari di cui i classici sono portatori, perché sarebbe reato grave disattendere tale tensione. Laddove tante attuali proposte di lettura per l’infanzia sono sciatte nella forma e nei contenuti, i classici si stagliano sul panorama delle letture come opere cólte, per quel che raccontano e per come lo raccontano. La loro lingua non ha paura di sfidare il lettore e di chiedere la sua collaborazione lungo il cammino del racconto: non ci sono timori dettati da quel falso rispetto per bambini e ragazzi, ai quali sembrerebbe, secondo certe tesi ancora così attuali, che tutto debba essere facilitato, con un approccio didascalico che rasenta il disprezzo del lettore. Insomma: C’era una volta e adesso non c’è più, anche con riferimento al linguaggio dei classici per bambini come modello di lingua e di italiano, tema sviluppato durante il convegno da Dario Corno[4], che ha annotato: «Un testo letterario viene solitamente considerato classico per una pluralità di ragioni. Normalmente queste ragioni riguardano la sua struttura narrativa, la sua storia e il cumulo di immagini, temi e motivi che lo innervano dalla prima all’ultima parola. Ma c’è, soprattutto nella nostra cultura, nella cultura italofona, una ragione in più per cui un testo può essere definito classico e questa ragione riguarda la lingua in cui è scritto. Si tratta di una considerazione che vale soprattutto per quei testi che chiamiamo “classici per l’infanzia” dato che è nell’infanzia che si apprende linguaggio, che si vengono a conoscere le parole e che si affinano i propri rapporti con la comunicazione verbale».
Ripercorrendo le diverse tappe del convegno, è apparsa evidente la forza direi multi-disciplinare dei classici, che spaziano ben oltre il fatto letterario in sé. Legare quasi per via naturale la lettura dei classici all’insegnamento della lingua italiana sembra quasi una banalità: attraverso i classici è possibile percorrere, quasi senza accorgersene, tanti aspetti della nostra Cultura, di natura storica, filosofica, religiosa, naturalistica, sociologica, geografica e tanto altro ancora. Tuttavia è doveroso riservare la giusta attenzione anche agli aspetti strettamente linguistici e letterari di cui i classici sono portatori, perché sarebbe reato grave disattendere tale tensione. Laddove tante attuali proposte di lettura per l’infanzia sono sciatte nella forma e nei contenuti, i classici si stagliano sul panorama delle letture come opere cólte, per quel che raccontano e per come lo raccontano. La loro lingua non ha paura di sfidare il lettore e di chiedere la sua collaborazione lungo il cammino del racconto: non ci sono timori dettati da quel falso rispetto per bambini e ragazzi, ai quali sembrerebbe, secondo certe tesi ancora così attuali, che tutto debba essere facilitato, con un approccio didascalico che rasenta il disprezzo del lettore. Insomma: C’era una volta e adesso non c’è più, anche con riferimento al linguaggio dei classici per bambini come modello di lingua e di italiano, tema sviluppato durante il convegno da Dario Corno[4], che ha annotato: «Un testo letterario viene solitamente considerato classico per una pluralità di ragioni. Normalmente queste ragioni riguardano la sua struttura narrativa, la sua storia e il cumulo di immagini, temi e motivi che lo innervano dalla prima all’ultima parola. Ma c’è, soprattutto nella nostra cultura, nella cultura italofona, una ragione in più per cui un testo può essere definito classico e questa ragione riguarda la lingua in cui è scritto. Si tratta di una considerazione che vale soprattutto per quei testi che chiamiamo “classici per l’infanzia” dato che è nell’infanzia che si apprende linguaggio, che si vengono a conoscere le parole e che si affinano i propri rapporti con la comunicazione verbale».
I classici: non solo storie accattivanti
Perché I sussurri delle storie portano anche il vento della Storia, come si è ben manifestato nella riflessione di Walter Fochesato[5]. A chi si rivolgono i classici se, per dirla con Italo Calvino, continuano a parlare anche alle nuove generazioni, perché non hanno finito di dire ciò che hanno da dire? A questo riguardo Fochesato ha proposto diversi esempi: «Pensiamo a Piccole donne (Alcott, 1868). Qui le sorelle, coraggiose e intraprendenti, proclamano il loro diritto a progettare la propria esistenza di ragazze e di donne, ma ciò inizialmente accade perché il padre – il pastore March – non c’è, si è arruolato come volontario con i nordisti nella guerra di Secessione […]. Fra “strada” e “Storia” ecco Senza famiglia di Hector Malot (1878), una sorta di feuilleton a misura d’infanzia, ma anche di viaggio didattico attraverso la Francia dove – in filigrana – possiamo leggere il problema dei piccoli suonatori ambulanti, in genere di origine italiana; e il maestro Vitali si veste appunto come i banditi e i pastori di tante oleografiche convenzioni destinate a durare nel tempo».
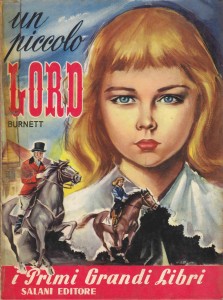 Le storie, dunque, fanno giungere fino a noi le Voci del passato e propongono spesso dei modelli etici: si pensi a romanzi come il già citato I ragazzi di via Pál, oppure a Robin Hood, Oliver Twist, Heidi, … Con una sorta di furore iconoclasta, dagli anni ’70 in qua abbiamo mandato al simbolico rogo tante opere d’arte, spesso ritenute, a torto o a ragione, espressioni di certa borghesia bacchettona, moralista e un po’ insolente. Naturalmente c’erano educatori che usavano i classici come armi improprie, un po’ modelli immutabili da riprodurre acriticamente e un altro po’ precetti da seguire con devozione, per evitare l’inferno dell’aldilà. Di fronte a situazioni molto attuali di banalizzazione, di populismo, di grettezza, di chiusura, di intolleranza, tutti, sin dalla più tenera età, hanno il diritto di accostarsi al mondo con la più grande capacità possibile di leggere l’ambiente circostante in tutta la sua complessità. Lo sviluppo di una tensione etica che caratterizzi ogni cittadino di oggi e di domani non può più essere procrastinata. A un sistema di valori sacrificato, forse giustamente, sull’altare della speranza per una democrazia migliore, la generazione dei sessantenni di oggi non ha saputo opporne un altro che fosse davvero in grado di richiamare e porre l’accento sui principali elementi costitutivi di una moderna democrazia liberale. In questo senso la rilettura dei classici può riservare piacevoli sorprese, anche, o forse soprattutto, grazie ai tanti fili tematici del pensiero e del vivere civile che continuano a percorrere la storia senza soluzione di continuità. «La difficoltà odierna a incontrare la voce del classico, la sua opera e la sua “lezione” – ha detto il filosofo Fabio Merlini[6] – è certamente anche una conseguenza del nostro attuale rapporto con il passato, ossia della forma assunta dall’atto del ricordare esperienze, eventi e insegnamenti provenienti dal passato[7]. Non esiterei ad affermare che questa forma prende l’aspetto del sospetto, nella migliore delle ipotesi, e dell’oblio nella peggiore. Siamo irretiti in un presente che anche quando vive la crisi, la profonda crisi dei suoi assetti istituzionali, delle sue modalità riproduttive, dei suoi contenuti di verità, rimane fermo sulle sue posizioni. Privilegia sempre una lettura per cui le turbolenze che intervengono a sconquassare la continuità pacifica di pratiche, di costumi e di malcostumi sono interpretate come accadimenti congiunturali. Tutto deve comunque poter ricominciare come prima: se c’è memoria per un simile presente è sempre e solo memoria di sé, della propria identità – una memoria cortissima. E non potrebbe essere altrimenti, se tale identità è fuori discussione. La sua incontestabilità è proprio ciò che fa da ostacolo alla memoria d’altro – le voci e le lezioni dal passato. Ma è anche ciò che blocca il pensiero stesso del futuro come attesa d’altro».
Le storie, dunque, fanno giungere fino a noi le Voci del passato e propongono spesso dei modelli etici: si pensi a romanzi come il già citato I ragazzi di via Pál, oppure a Robin Hood, Oliver Twist, Heidi, … Con una sorta di furore iconoclasta, dagli anni ’70 in qua abbiamo mandato al simbolico rogo tante opere d’arte, spesso ritenute, a torto o a ragione, espressioni di certa borghesia bacchettona, moralista e un po’ insolente. Naturalmente c’erano educatori che usavano i classici come armi improprie, un po’ modelli immutabili da riprodurre acriticamente e un altro po’ precetti da seguire con devozione, per evitare l’inferno dell’aldilà. Di fronte a situazioni molto attuali di banalizzazione, di populismo, di grettezza, di chiusura, di intolleranza, tutti, sin dalla più tenera età, hanno il diritto di accostarsi al mondo con la più grande capacità possibile di leggere l’ambiente circostante in tutta la sua complessità. Lo sviluppo di una tensione etica che caratterizzi ogni cittadino di oggi e di domani non può più essere procrastinata. A un sistema di valori sacrificato, forse giustamente, sull’altare della speranza per una democrazia migliore, la generazione dei sessantenni di oggi non ha saputo opporne un altro che fosse davvero in grado di richiamare e porre l’accento sui principali elementi costitutivi di una moderna democrazia liberale. In questo senso la rilettura dei classici può riservare piacevoli sorprese, anche, o forse soprattutto, grazie ai tanti fili tematici del pensiero e del vivere civile che continuano a percorrere la storia senza soluzione di continuità. «La difficoltà odierna a incontrare la voce del classico, la sua opera e la sua “lezione” – ha detto il filosofo Fabio Merlini[6] – è certamente anche una conseguenza del nostro attuale rapporto con il passato, ossia della forma assunta dall’atto del ricordare esperienze, eventi e insegnamenti provenienti dal passato[7]. Non esiterei ad affermare che questa forma prende l’aspetto del sospetto, nella migliore delle ipotesi, e dell’oblio nella peggiore. Siamo irretiti in un presente che anche quando vive la crisi, la profonda crisi dei suoi assetti istituzionali, delle sue modalità riproduttive, dei suoi contenuti di verità, rimane fermo sulle sue posizioni. Privilegia sempre una lettura per cui le turbolenze che intervengono a sconquassare la continuità pacifica di pratiche, di costumi e di malcostumi sono interpretate come accadimenti congiunturali. Tutto deve comunque poter ricominciare come prima: se c’è memoria per un simile presente è sempre e solo memoria di sé, della propria identità – una memoria cortissima. E non potrebbe essere altrimenti, se tale identità è fuori discussione. La sua incontestabilità è proprio ciò che fa da ostacolo alla memoria d’altro – le voci e le lezioni dal passato. Ma è anche ciò che blocca il pensiero stesso del futuro come attesa d’altro».
Sarà vero?
Tra i diversi spunti di approfondimento e riflessione proposti ai relatori invitati al convegno, uno toccava un aspetto particolare: possono i classici per l’infanzia fungere da strumenti di legame generazionale e di identità? A questo interrogativo un po’ sibillino ha cercato di rispondere Renato Martinoni[8], con la sua relazione Viva i balocci, abbasso Larin Metica!, un titolo che richiama naturalmente Le avventure di Pinocchio. Martinoni non ha lesinato perplessità e scetticismi, sin dalla definizione di classico, esprimendo forti dubbi che i classici possano contribuire a creare identità e a legare tra loro le generazioni, già per il fatto che «i miei libri non sono quelli di mia figlia». «Sono più pessimista che ottimista», ha concluso. «Capisco – e sostengo – l’impegno della scuola, anche se poi troppo spesso alla scuola vengono delegati compiti che spetterebbero alla famiglia. Ma credo che anche il forzare le cose sia controproduttivo: c’è sempre il rischio che una generazione imponga delle letture a un’altra generazione, pur non potendone condividere le sensibilità o i punti di vista. Certo, la scuola ha il compito di mettere in dialogo le generazioni. Anche perché la scuola è il luogo dove si fa jogging mnemonico, per dirla ancora con Umberto Eco, che tra l’altro ha anche opportunamente ricordato che (cito) “imparare a memoria la Cavallina Storna è una forma di assicurazione sull’Alzheimer”[9]. Mi piace invece citare nuovamente Umberto Eco che, richiesto di un consiglio, suggerisce a uno studente di leggere il Saggio sull’intelletto umano di John Locke: dicendogli che quella lettura gli servirà tanto se scriverà una tesi di filosofia, all’università, così come se andrà a fare il venditore di macchine usate. Perché, dice Eco, la lettura dei classici serve a conoscere uomini che vale la pena di conoscere. “Leggere un classico”, conclude l’autore del Nome della rosa, “è come psicanalizzare la nostra cultura attuale, si trovano tracce, ricordi, schemi, scene primarie, ecc.”. Insomma: leggere un classico è tornare alle radici[10] e riflettere dentro sé stessi. È questa, forse, una strada da seguire da parte di chi cerca di costruire legami generazionali o di identità fra giovani e meno giovani. Anche se temo, lo avrete capito da un po’, che i classici intergenerazionali non esistono, o esistono sempre meno. E che sia meglio lasciare ad ogni generazione i suoi classici, destinati poi a declassarsi».
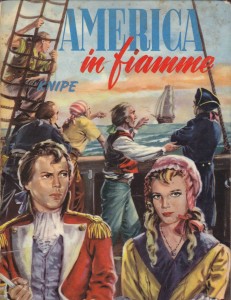 A tanto pessimismo hanno fatto da contraltare Simone Fornara e Mario Gamba[11], trattando del dovere di scrivere ed educare nel mercato editoriale del terzo millennio, un mercato purtroppo orientato verso un bambino/adolescente visto come un piccolo consumatore, ciò che genera una letteratura, spesso edita su precisa ordinazione, piegata alle urgenze mercantili dell’editoria: «Una “letteratura” che coglie con sensibilità imprenditoriale le mode e i successi del momento nel tentativo di replicarli, e produce lavori fabbricati in serie, pianificandoli con precisione, affidandoli (commissionandoli) ad autori facilmente sostituibili che riproducono temi e personaggi, inserendoli su trame intercambiabili. Si confezionano così libri tutti uguali, caratterizzati da “una scrittura finto-spontanea (graficamente resa con caratteri corsivi, cambi di font, maiuscole ed esclamazioni)” e accompagnata da “disegnini finto-infantili che spezzano il ritmo di ogni pagina e la fanno sembrare più leggera e più buffa”[12]. L’ovvio risultato è una letteratura che svaga ma non richiede sforzo intellettuale né stimola lo spirito critico nel bimbo». L’accusa è naturalmente pesante, tanto più che non sempre l’educatore, sia esso insegnante o genitore, è in grado di orientarsi al meglio nel momento delle sue scelte, confrontato con gli scaffali delle librerie e dei supermercati ampiamente colonizzati da prodotti librari che devono produrre ricavi sonanti. Così Fornara e Gamba, messa sul banco degli accusati questa produzione, hanno affrontato un’interessante requisitoria, attraverso un’accurata presentazione di esempi e indizi: nell’evidenza che tanti indizi fanno una prova.
A tanto pessimismo hanno fatto da contraltare Simone Fornara e Mario Gamba[11], trattando del dovere di scrivere ed educare nel mercato editoriale del terzo millennio, un mercato purtroppo orientato verso un bambino/adolescente visto come un piccolo consumatore, ciò che genera una letteratura, spesso edita su precisa ordinazione, piegata alle urgenze mercantili dell’editoria: «Una “letteratura” che coglie con sensibilità imprenditoriale le mode e i successi del momento nel tentativo di replicarli, e produce lavori fabbricati in serie, pianificandoli con precisione, affidandoli (commissionandoli) ad autori facilmente sostituibili che riproducono temi e personaggi, inserendoli su trame intercambiabili. Si confezionano così libri tutti uguali, caratterizzati da “una scrittura finto-spontanea (graficamente resa con caratteri corsivi, cambi di font, maiuscole ed esclamazioni)” e accompagnata da “disegnini finto-infantili che spezzano il ritmo di ogni pagina e la fanno sembrare più leggera e più buffa”[12]. L’ovvio risultato è una letteratura che svaga ma non richiede sforzo intellettuale né stimola lo spirito critico nel bimbo». L’accusa è naturalmente pesante, tanto più che non sempre l’educatore, sia esso insegnante o genitore, è in grado di orientarsi al meglio nel momento delle sue scelte, confrontato con gli scaffali delle librerie e dei supermercati ampiamente colonizzati da prodotti librari che devono produrre ricavi sonanti. Così Fornara e Gamba, messa sul banco degli accusati questa produzione, hanno affrontato un’interessante requisitoria, attraverso un’accurata presentazione di esempi e indizi: nell’evidenza che tanti indizi fanno una prova.
La loro conclusione è tuttavia ottimista: «affinché il gatto continui a calzare gli stivali, e non semplicemente ad avere o metterli o infilarli, lo scrittore oggi deve essere pronto a combattere una dura battaglia, sopportando anche qualche sconfitta e l’onta di scelte ingiustificabili, rinunciando magari anche all’idea di vendere migliaia e migliaia di copie. Ma il valore educativo della lettura non può soccombere di fronte al miraggio delle vendite: il lavoro dello scrittore per ragazzi (e forse dello scrittore in generale) è diventato una sorta di missione, un tentativo ostinato (per dirla con il Calvino delle Lezioni americane) di contrastare “l’espandersi della peste del linguaggio”, cercando di opporre a essa, come degli anticorpi, “l’unica difesa che riusciamo a concepire: un’idea della letteratura”[13] Nessun dubbio: si tratta di una conclusione che suonerà risibile, o addirittura ridicola. Ma è una conclusione che intende opporsi alla banalizzazione, all’appiattimento e alle strategie di chi si ostina a voler allevare “piccoli cretini che devono diventare soltanto dei cretini adulti”[14]».
Un futuro di speranze, a qualche condizione
In opposizione al consumo frenetico di storie e parole e immagini, e all’abitudine del tutto e subito, della lettura piegata surrettiziamente alla necessità di insegnare a leggere e scrivere, ecco che i classici offrono un supporto didattico di estrema potenza, alla portata di chiunque abbia a che fare con l’educazione dei più piccoli. Per quel che ricordo, ho conosciuto Pinocchio attraverso la voce del mio maestro di scuola elementare, e tante fiabe – ricordo bene Il brutto anatroccolo e Il lupo e i sette capretti – per la voce di mia madre, oppure il Barbablù di Perrault in un’edizione molto gotica su un disco in vinile (azzurro!) che girava per casa.
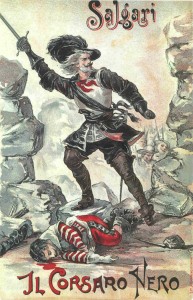 Oggi più di ieri, la lettura ad alta voce resta una pietra miliare dell’Educazione, non solo linguistica. Leggere ad alta voce è opera di educazione linguistica, è momento etico e morale, è cultura. Ed è emozioni. Le fiabe, le favole e i romanzi sono come la musica. Non saranno la sinfonia mahleriana o il poema sinfonico di Liszt, lo scherzo o la ninna nanna di Chopin, il preludio di Bach: ma le storie che racconteremo ai nostri figli e ai nostri allievi forniranno loro un bagaglio straordinario di conoscenze, di emozioni e di modelli linguistici. Volete mettere la storia di Pollicino o di Hänsel e Gretel raccontata dalla mamma o dal papà?
Oggi più di ieri, la lettura ad alta voce resta una pietra miliare dell’Educazione, non solo linguistica. Leggere ad alta voce è opera di educazione linguistica, è momento etico e morale, è cultura. Ed è emozioni. Le fiabe, le favole e i romanzi sono come la musica. Non saranno la sinfonia mahleriana o il poema sinfonico di Liszt, lo scherzo o la ninna nanna di Chopin, il preludio di Bach: ma le storie che racconteremo ai nostri figli e ai nostri allievi forniranno loro un bagaglio straordinario di conoscenze, di emozioni e di modelli linguistici. Volete mettere la storia di Pollicino o di Hänsel e Gretel raccontata dalla mamma o dal papà?
Poi, col crescere delle capacità, bambini e ragazzi inizieranno da soli ad assaporare il piacere faticoso della lettura per conto proprio. Ma anche in questo caso è necessario essere oculati: tra quelli che Castelli e Dotta chiamano I classici del futuro ci sono testi alla portata delle competenze linguistiche e culturali dei nostri ragazzi in età di scuola elementare. È bene però essere sempre attenti. Geronimo Stilton non è da demonizzare, ma nemmeno da santificare. Un maestro mi raccontava di averlo dovuto proibire nella sua classe, perché l’annusare le puzze era diventato il gioco del giorno, ben oltre l’esercizio della lettura e delle storie raccontate, già di per sé non particolarmente sontuose. Come a dire: leggere i classici ci serve non tanto per annusare “puzze”, ma perché i bambini imparino nuove parole, più lingua, e rafforzino il loro diritto ad avere un immaginario (e non solo a consumarne uno che è già bell’e pronto, perché pensato facile facile dall’industria culturale a loro diretta). Insomma: più parole, meno puzze.
Ha detto Fabio Merlini, citando Nietzsche: «“Fretta generale”, “crescente velocità” e “cessare di ogni contemplatività”: sono i tre aspetti principali del declino, pensando al quale Nietzsche ha potuto non solo immaginare, in un futuro prossimo, il tramonto dell’attività della lettura e della scrittura. Ma ha potuto anche identificare la modernità politica ed economica come epoca della secolarizzazione radicale, dell’interesse immediato, della coscienza circoscritta alla superficie delle cose: “mai il mondo è stato più mondo”. La condanna all’attualità è allora rincorsa del tempo che allontana da sé, caduta nell’inessenziale. È vita cui manca valore. Vita priva di cultura».
In fin dei conti, sono ancora attuali i classici? Il convegno sembra aver risposto di sì, con molti distinguo e rafforzando l’idea che cresce la responsabilità del Maestro nello sceglierli. Ha scritto Luca Cignetti, docente-ricercatore al DFA[15]: «Il convegno locarnese non è valso solo a ricordarci quello che, in fondo, i teorici del racconto e i pedagogisti ci ripetono da sempre: è servito a trasmetterci la fiducia che tutto questo possa finalmente trasferirsi in una pratica didattica e pedagogica quotidiana. Sono stati i docenti, presenti e futuri, che hanno gremito il teatro a tenere accesa questa speranza. Il loro entusiasmo e la loro partecipazione valgono come la promessa di voler seminare ancora a lungo, nelle classi e nelle sezioni del Cantone, manciate di fagioli magici, e naturalmente di continuare a coltivare ancora la proverbiale astuzia dell’ingegnoso felino. Perché la sopravvivenza del nostro eroe e dei suoi stivali incantati non è mai stata davvero messa in discussione: i gatti hanno sette vite, anche quando abitano nelle fiabe».
“Il gatto ha ancora gli stivali?”: esposizione di classici per l’infanzia
di Antonella Castelli (Co-curatrice della mostra “Il gatto ha ancora gli stivali?”)
Preparare una mostra dedicata ai classici era una proposta molto stimolante, una vera sfida che ci ha subito entusiasmati non senza suscitare qualche perplessità.
Occorreva porsi alcune importanti domande: quali sono i classici della letteratura per l’infanzia? Quali titoli e quali autori potremmo includere in un elenco di classici per ragazzi? Quali le qualità per cui definiamo “classico” un testo?
Parlando di classico nella letteratura per ragazzi, non si può far altro che restare fedeli a una concezione che valuti fondamentali gli stessi requisiti dei classici in generale: l’eccellenza della qualità formale – la cura, la ricerca espressiva dell’autore – e la ricchezza e profondità di contenuto del testo letterario.
Ma mentre le parole sulla pagina rimangono sempre uguali, il mondo e il lettore cambiano. Cambiano le modalità di percezione, le valenze culturali, cambia l’immaginario. I dialoghi hanno preso il posto delle lunghe descrizioni. Lo stile, i tempi della narrazione non sono più quelli di una volta: la sinteticità, la rapidità delle immagini si sono in qualche modo trasferite nella scrittura, oggi altamente influenzata dalla comunicazione visiva. Una delle ragioni per cui i nostri ragazzi difficilmente leggono ciò che ha tanto appassionato le generazioni precedenti, è proprio la differenza del ritmo narrativo tra i testi del passato e quelli della narrativa contemporanea.
Il bambino oggi si abitua a una rapidissima serie di emozioni che a poco a poco condizionano tutte le sue scelte. È necessaria una grande esperienza di lettura per superare codici stilistici e culturali desueti, e affrontare questi testi del passato così diversi dalla narrativa contemporanea.
Che senso ha allora scegliere delle storie apparentemente tanto lontane per contesto, gusti, linguaggio?
Calvino ha scritto che “i classici sono quei libri che non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire”. Se queste grandi storie continuano a parlare ai piccoli lettori generazione dopo generazione, uno dei motivi risiede nell’universalità dei temi che esse affrontano. I classici sono delle grandi metafore che parlano direttamente al lettore, sanno essere contemporanei perché sono uno sconfinato serbatoio di simboli di immensa suggestione (Beseghi).
Secondo Faeti i classici hanno assunto valore di paradigma e grazie ad essi, è possibile scoprire ambienti, atmosfere, personaggi e valori oggi dimenticati o perduti, eppure ancora così significativi per la vita dell’uomo.
Giorgia Grilli parla di “inattuale pedagogico”: sarebbe cioè fondamentale tener presente l’inattuale, individuare, recuperare quelle caratteristiche che hanno reso tali i classici (che sono appunto inattuali) a differenza di quei prodotti che durano solo una stagione per soddisfare, poiché novità, i gusti spesso effimeri del presente.
Una piccola mostra sui classici poteva quindi avere un senso.
Oggi la si può guardare con gli occhi un po’ nostalgici di chi sicuramente non ha dimenticato certe sue letture di gioventù; può forse essere d’aiuto a quei docenti che desiderano perfezionare la scelta delle letture in classe o approfondire alcuni argomenti particolari; può servire ad alcune biblioteche per completare le proprie collezioni; può essere anche solo una curiosità.
Poiché non esiste un vero e proprio canone, stilare un elenco di classici non è stato facile: il rischio di dimenticare autori o titoli importanti era grande.
La scelta è quindi puramente soggettiva e sicuramente incompleta. Nel limite del possibile, dà la precedenza a quelle opere che si pensa possano coinvolgere anche dei ragazzini della scuola elementare.
L’esposizione intende offrire una panoramica generale delle numerose pubblicazioni oggi in commercio, spaziando tra le varie collane presenti, note e meno note, per mostrare come e che cosa è cambiato in questo particolare settore dell’editoria per ragazzi, per scoprire il senso degli innumerevoli rifacimenti.
In questi ultimi anni non c’è casa editrice che non abbia sfornato una nuova collana di classici, compresi quelli che da tempo erano fuori catalogo, riproponendoli in nuove versioni integrali o con copertine di pregio.
Ad aver contribuito a questo revival collettivo sono soprattutto le recenti traduzioni.
Le traduzioni dell’epoca, grazie alle quali i lettori di lingua italiana hanno potuto conoscere i testi classici, “non funzionano più”. Oggi è possibile proporre ai ragazzi questo genere di lettura grazie a nuovi ottimi traduttori, spesso anch’essi autori di libri per ragazzi, che con indubbia abilità hanno saputo coniugare la levità stilistica con la qualità letteraria, nel rispetto del testo originale.
Un ruolo determinante spetta anche alle illustrazioni: spesso affidate ad artisti di grande valore, esse arricchiscono, incuriosiscono e rendono più accattivanti le ristampe delle numerose case editrici.
Inoltre, in alcune collane sono state aggiunte delle introduzioni o delle postfazioni, a volte curate da famosi scrittori per l’infanzia e indirizzate proprio ai giovani lettori, un ulteriore contributo per aiutarli a scoprire l’attualità di questi testi.
La mostra è suddivisa in quattro categorie: i classici, i classici del futuro, la mitologia e le fiabe classiche.
Per classici del futuro s’intendono quei libri che dalla seconda metà del secolo scorso hanno caratterizzato la letteratura per l’infanzia, opere di scrittori ormai conosciuti internazionalmente che hanno radicalmente rinnovato il panorama letterario. In una mostra dedicata ai classici non si poteva, infatti, non accennare alla presenza di chi sembra aver ricevuto il testimone: Rodari, Dahl, Lindgren, Piumini, Nöstlinger, Pitzorno, ecc.
La sezione dedicata alla mitologia ha uno scopo puramente rappresentativo: si tratta di un breve accenno concernente questo genere letterario per ricordare che ogni grande cultura ha le sue origini nella mitologia, sede delle preistorie di tutta la letteratura.
Le fiabe, custodi dei grandi archetipi del nostro immaginario, fonte di ispirazione per le storie di ieri e di oggi, sono lì per “marcare presenza”.
Infine, il catalogo che accompagna la mostra vuol essere un aiuto supplementare. In esso le voci si susseguono in singole schede, in ordine alfabetico per autore e titolo; sono indicati il titolo originale, la data della prima edizione originale, la lingua originale e l’edizione presente nella mostra, della quale vengono riportati il nome del traduttore, eventualmente dell’illustratore e l’incipit.
Desidero terminare questa breve presentazione con un mio suggerimento personale: per introdurre gli allievi al mondo dei classici e suscitare la passione per le narrazioni di grande respiro, il primo passo dovrebbe sempre essere la lettura ad alta voce. Da parte dell’insegnante, del genitore, del nonno o del bibliotecario, la lettura ad alta voce è sicuramente il modo più efficace per suscitare la passione per la lettura e permette di avvicinare anche quei testi che risultano troppo difficili per una lettura individuale.
Ci auguriamo che questo nostro contributo possa risvegliare il desiderio di scoprire o riscoprire libri, autori e personaggi suggestivi e inesauribili; in tal caso il nostro lavoro non sarà stato vano.
La mostra è a disposizione degli istituti scolastici, le biblioteche o altre istituzioni interessate. Oltre ai 170 volumi, la mostra comprende il catalogo, curato da Antonella Castelli e Orazio Dotta, edito dal Centro didattico cantonale; un cavalletto con testo esplicativo; alcuni cartelloni decorativi tratti dal catalogo. La mostra potrà essere prenotata contattando il Centro didattico cantonale (viale S. Franscini 32, 6500 Bellinzona, telefono +41 91 814 63 11, decscdc@ti.ch).
[1] Antonella Castelli e Orazio Dotta, Guida ai classici della letteratura per l’infanzia, Centro didattico cantonale, Bellinzona, 2012
[2] Pino Boero, professore ordinario di Letteratura per l’infanzia, Prorettore alla formazione, Università di Genova.
[3] Giampaolo Visetti, I ragazzi di via Pál traditi dal Novecento in “la Repubblica”, 13 maggio 2007.
[4] Dario Corno, ricercatore in Linguistica Italiana presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi del Piemonte Orientale.
[5] Walter Fochesato, direzione della rivista «Andersen».
[6] Fabio Merlini, Direttore regionale dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale. Presidente della Fondazione Eranos.
[7] cfr. F. Papi, “Per una ontologia del ricordare”, in Iride, n° 14, 1995.
[8] Renato Martinoni, professore di Letteratura italiana all’Università di San Gallo.
[9] Umberto Eco, Ricordate tutti i sette nani?, in La bustina di Minerva, Milano, Bompiani, 1999, p. 188.
[10] Umberto Eco, Elogio dei classici, in La bustina di Minerva, cit., p. 243.
[11] Simone Fornara, docente-ricercatore in didattica dell’italiano presso il DFA/SUPSI, e Mario Gamba, docente di filosofia presso il liceo scientifico G. Galilei di Borgomanero, sono autori di diversi libri rivolti ai ragazzi.
[12] Grilli G. (2012), Libri nella giungla. Orientarsi nell’editoria per ragazzi, Carocci, Roma (p. 11).
[13] Calvino I. (1993), Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano (pp. 66-67).
[14] Denti R. (2012), I bambini leggono, Il Castoro, Milano (p. 169).
[15] Corriere del Ticino del 21.09.2012).
L’educazione dei figli alla corte di Re Soldo
Anch’io, come molti concittadini, in questi giorni sono alle prese con la votazione popolare di fine novembre. In particolare mi sono spuntati tanti dubbi sull’iniziativa delle famiglie promossa dall’UDC. Ormai ho imparato che non c’è da fidarsi delle argomentazioni dei favorevoli e dei contrari. Troppe volte, in passato, non ce l’hanno raccontata per intero – e mi son fatto raggirare. Cosa dicono i favorevoli all’iniziativa? Ad esempio che avere figli è una grande responsabilità, che dà molte soddisfazioni, ma richiede anche molto lavoro e sacrifici. E il Consiglio federale, che è contrario? Scrive che «Oggi le famiglie con figli sono trattate in modo equo sul piano fiscale, indipendentemente dal modo in cui accudiscono i figli. Se l’iniziativa fosse accettata, (…) si privilegerebbe il modello di famiglia tradizionale». Va da sé che quando, con una certa sufficienza, si cita la famiglia tradizionale, si fa l’occhiolino alle donne, come a suggerire con malcelato sarcasmo: «Non vorrete mica tornare a far le casalinghe, ora che si è aperto anche per voi il mondo del lavoro retribuito!» Spesso indegnamente.
Nel fascicolo ufficiale che dovrebbe illustrare i termini della questione, compare un’unica volta la parola «educazione». La scrive il Consiglio federale: «Esistono pareri diversi sull’educazione ottimale dei bambini». Ma dài? La parola «economia» e i suoi derivati sono invece presenti sette volte, e a quanto sembra i pareri sono univoci.
Conosco qualche coppia di professionisti che lavorano entrambi. Per lo più riescono anche a occuparsi bene dei figli, che, quando tornano a casa da scuola, trovano qualcuno che li accoglie e si occupa di loro. A volte c’è anche chi fa il bucato, stira, rammenda e tiene pulita la casa. Conosco invece tante altre coppie che lavorano ambedue, non tanto per scelta, ma per imposizione economica: arrivare a fine mese senza affogare. E allora per tirar su i figli ci si arrangia come viene, qualche santo provvederà.
Sarei curioso di sapere quanti sono i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie che al loro arrivo a casa, dopo una giornata di scuola, sanno prepararsi la merenda da soli e mettersi a svolgere i compiti scolastici, invece che andar per cortili o attaccarsi a mamma TV o papà internet. Non so, in altre parole, cos’abbia in mente il Consiglio federale quando pensa a un modello di famiglia «non tradizionale». Di certo i servizi para-scolastici – asili-nido, mense, doposcuola – non sono in grado di sostituirsi all’ambiente domestico, magari moderno, non certo affollato. È scorretto fingere che tra il ragazzo che si ferma al doposcuola e il suo coetaneo che rientra a casa ed è accolto da qualcuno – fosse pure la ragazza alla pari, che magari gli chiede com’è andata la giornata – non vi sia una voragine educativa. Non si dimentichi che l’organizzazione scolastica odierna ha funzionato bene per decenni perché poteva interagire con la bistrattata «famiglia tradizionale», che, ad esempio, offriva ai figli uno spazio sereno per svolgere i compiti a casa, così frequenti e onerosi a partire dalla prima media, quando i ragazzi son poco più che decenni.
Si abbia almeno il coraggio, per coerenza, di mandare al macero anche il «modello di scuola tradizionale» e di inventarne uno capace di sottomettersi ai diktat dell’economia e della finanza. Mi sembra invece che si stia operando un massacro educativo di cui, prima o poi, qualcuno dovrà pur rendere conto.
L’ampio dibattito è come l’araba fenice
La disinvoltura con cui il parlamento ha sepolto la proposta di diminuzione del numero di allievi per classe nelle scuole elementari, contenuta nell’iniziativa «Aiutiamo le scuole comunali», la dice lunga della serietà che caratterizza il dibattito sulla nostra scuola, un dibattito che tutti invocano, richiamando tanti bei princìpi, ma che in realtà è del tutto inesistente. Quello del numero ideale di allievi per insegnare bene è un tema ricorrente. Puntuale come la grippe, la proposta fa capolino con regolarità da almeno cinquant’anni, neanche fosse il toccasana di tutti i grattacapi. Personalmente non la penso così. Sta di fatto che i socialisti han sempre sostenuto la proposta dell’iniziativa, in mezzo al silenzio colpevole delle altre forze politiche. È ovvio che se per anni si tace, diventa difficile opporsi con qualche ragione fondata. La mia impressione è che molti siano contrari, ma non sanno perché. Così, in quattro e quattr’otto, il Gran consiglio ha inventato sui due piedi una misura che è ancor più discriminatoria della diminuzione lineare del numero di allievi per classe. Tant’è. Questo è quel che il Paese è in grado di produrre oggi a livello di dibattito sulla scuola di tutti, come se i problemi fossero solo la dimensione delle classi, le mense e il doposcuola, gli asili nido, i direttori da estendere a tutti gli istituti e il salmo svizzero.
Negli ultimi cinquant’anni la scuola dell’obbligo ha perso per strada i suoi principi fondatori, che avevano al centro l’educazione di futuri cittadini democratici e istruiti per vivere e gestire un paese libero. La scuola di oggi, messa assai spesso sotto pressione da tanti apprendisti stregoni, si è imbottita di educazioni e istruzioni, col risultato che non è più in grado di soddisfare le esigenze primarie del Paese – tanto che, per metterci una pezza con l’illusione di risolvere un problema, è già stata depositata una nuova iniziativa-cerotto («Educhiamo i giovani alla cittadinanza»). Quel ch’è certo è che, negli ultimi anni, si sono rafforzati l’insegnamento delle seconde lingue, i servizi parascolastici e tante nuove «educazioni», in una farraginosa accozzaglia di obiettivi che poco o nulla hanno a che fare con una scuola che vorrebbe insegnare ai cittadini di domani a «realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà»: senza arrivarne a una.
Sarebbe ora di uscire con piena coscienza dal particulare per aprire un dibattito serio sulla scuola. La scuola non è in grado di rispondere con concretezza e rigore a tutte le richieste che le piovono addosso, e non lo saprà fare neanche dimezzando il numero di allievi per classe. È dunque urgente aggiornarne le finalità e i contenuti, passando oltre l’ipocrita etica dei princìpi e aderendo invece all’etica della responsabilità. Ha scritto Adolfo Scotto di Luzio, docente di storia della pedagogia all’università di Bergamo (La scuola che vorrei, 2013): «La scuola va liberata di funzioni e di pesi che non le competono e messa al servizio di un progetto di sviluppo della nazione. Per fare questo è però necessario avere un’idea del paese, della sua storia, delle sue tradizioni culturali e sociali e del modo in cui è possibile rinnovarle. La scuola ha bisogno di questo. Non di tecniche e di burocrazia, ma di una rinnovata intesa su ciò che è degno di essere conservato e tramandato alle generazioni che verranno.» Eccolo, l’ampio dibattito di cui abbiamo bisogno.
Non accorciamo il liceo, ma cinquemila studenti son troppi
La sparata estiva del consigliere di stato Beltraminelli, che ha proposto di tagliare un anno di liceo per risparmiare un po’ di denari, ha generato diverse reazioni, ma pare che nessuno l’abbia presa troppo sul serio. Con l’ignoranza che si espande a macchia d’olio, non è proprio il caso di ridurre ai nostri giovani la possibilità di studiare. Se, però, ci si prende la briga di andare al di là della fanfaronata, perché di certo il direttore del DSS non è andato oltre i proverbiali tre calcoli della serva, qualche riflessione sulla scuola media superiore, e sul liceo in particolare, possiamo ben farcela. Poniamoci qualche domanda, a partire dal fatto che il liceo è nato come scuola di cultura generale destinato a chi è intenzionato a intraprendere studi universitari. In altri anni, grazie ai conti in banca di papà, chi poteva schivava la scuola maggiore, frequentava il ginnasio e finiva al liceo di Lugano o in qualche esclusivo istituto privato. Era l’era pre-democratizzazione degli studi.
Oggi il liceo è diventato una scuola multifunzionale, un coperchio buono per tante pentole, un po’ come quei coltellini svizzeri che comprano i turisti, affollati di aggeggi che non s’useranno mai. Oggi al liceo non s’iscrivono solo i giovani che hanno in testa le sale operatorie, le aule giudiziarie, i piani alti della finanza e dell’economia, i misteri della filologia, della cosmologia o della genetica. No, il liceo serve anche per fare il maestro, tanto per dire. Con tutto il rispetto dovuto a professioni dall’elevata richiesta etica e formativa, ma dal basso salario, non me la sento di sdoganare un liceo che, un colpo al cerchio e un altro alla botte, si è gonfiato come la famosa rana della favola di Fedro. Tant’è che tanti brontolano. Il vero spreco sono le centinaia di allievi che, anno dopo anno, vengono scartati in prima e in seconda.
Ho conservato un articolo di qualche anno fa: «Prima liceo da incubo per uno studente su quattro», titolava Ticinonline nel luglio del 2010. Eppure questi «uno su quattro» s’erano iscritti perché avevano i numeri convalidati dalla scuola media. Vien da dire che o la scuola media o il liceo (o tutt’e due) non sanno insegnare, oppure che valutano a casaccio. Malgrado questo sterminio istituzionale, che si ripete anno dopo anno, il numero di studenti non tende a diminuire. Si tenga però conto che il meccanismo che s’ingrana al termine della scuola media è perfido: circa la metà dei quindicenni – quindicenni! – è costretta a scegliere una formazione professionale, perché solo chi raggiunge i criteri per l’accesso automatico alle scuole medie superiori può concedersi il lusso di rinviare decisioni fondamentali, magari rinunciando a tanti sogni. Così non deve stupire che molti di loro entrino al liceo, magari solo perché non sanno ancora che pesci pigliare: ma vi sono forse altre alternative?
Qui sì, ci sono margini di risparmio, e non solo finanziario. Forse converrebbe ripensare da cima a fondo la scuola dell’obbligo: perché il Paese ha sempre più bisogno di cittadini cólti e critici. Forse servirebbe una scuola media che insegni con maggior rigore, prima di investire dispendiose e inutili risorse nella valutazione. Forse sarebbe utile una scuola di cultura accanto e al posto di un liceo di massa ormai ridotto a ruolo di filtro socio-economico. Perché cinquemila allievi che frequentano la scuola media superiore sono una democratizzazione falsa, che costa un sacco di soldi e crea frustrazioni evitabili.
