«Giunta a metà del tempo massimo per la raccolta delle sottoscrizioni, l’iniziativa popolare “Aiutiamo le scuole comunali. Per il futuro dei nostri ragazzi” ha superato le 3’500 firme»: lo riferisce La Regione del 3 ottobre. Ma dov’è la notizia? Non può meravigliare che la raccolta di firme per «aiutare le scuole comunali» prosegua liscia come l’olio. Il segreto della riuscita sta nell’ovvietà delle proposte. E già oggi si può supporre che alla fine il parlamento, dopo qualche scaramuccia di facciata e le scontate sparate delle sue frange più populiste, approverà gran parte di quelle idee, tutt’al più con taluni sacrifici/rinunce imposti dalle finanze sempre sinistrate. Sono ormai anni che i principali temi che costituiscono il corpo dell’iniziativa sono evocati quali condizioni irrinunciabili per far funzionare bene e in maniera efficace le scuole comunali. La riuscita dell’iniziativa, poi, sarà agevolata dalla grande diversità degli oggetti indicati, che comprendono un po’ di tutto e un po’ di più, tanto da ricordarmi una votazione federale di tanti anni fa: avevo detto di sì al casco obbligatorio per i ciclomotoristi e mi ero ritrovato legato come un salame al sedile della mia auto. Per dire che, in pratica, ogni persona che ha a che fare, direttamente o indirettamente, con questo settore scolastico troverà certamente almeno un argomento da sostenere con la propria firma.
Quanto alla convinzione che le nuove norme miglioreranno notevolmente le scuole comunali – sono parole di chi ha lanciato l’iniziativa, avverbio compreso – ho forti dubbi, al di là dell’apprezzabile tentativo di suggerire alcuni accorgimenti, volti a un’applicazione differenziata e conforme alle necessità specifiche di alcune proposte. Intanto l’iniziativa prospetta riforme direttamente legate alla scuola e ai suoi tradizionali scopi, accanto a numerosi cambiamenti che hanno un sapore più sociale. Prendiamo il vetusto argomento del numero di allievi per classe, che l’iniziativa propone di ridurre energicamente, senza tanti se e ma. Nessuno è mai riuscito a stabilire quale sia l’equo numero di allievi da affidare a un maestro. Tutt’al più si possono sparare delle cifre a naso. Ma l’equità numerica di una classe dipende soprattutto dalle caratteristiche individuali di ogni allievo e dalla natura degli obiettivi che si perseguono. Definire un numero tot di allievi per ogni classe da Airolo a Chiasso a prescindere dalle differenze che sussistono da una sede scolastica all’altra – e posso assicurare che tali diversità possono essere molto marcate anche a pochi chilometri di distanza – è un po’ come decidere che tutti dobbiamo pagare le stesse imposte: cioè un’ingiustizia.
È innegabile che l’iniziativa «Per il futuro dei nostri ragazzi» ha tanti pregi, tra cui quello di aprire (forse) un dibattito su questa prima tappa della scuola dell’obbligo. Ma i problemi posti oggi dall’educazione non possono essere risolti col pensiero magico, con i tanti «Sarebbe sufficiente che…» di cui noi tutti siamo depositari. Resto convinto che le proposte di Raoul Ghisletta e cofirmatari riceveranno un consenso molto ampio. Alcune cose miglioreranno; altre resteranno al palo e così, prima o poi, lanceremo altre iniziative, in attesa che ci si confronti seriamente su quelle che dovrebbero essere le reali e realistiche finalità della scuola in un’epoca storica così confusa e squilibrata, che vede bambini, ragazzi e giovani tramutati in oggetti economici di grande rilevanza, con tutte le perverse conseguenze che ne derivano. Ha scritto di recente il pedagogista francese Philippe Meirieu: «Alla domanda: “Quale mondo lasceremo ai nostri figli?” – quesito che resta attuale come mai – è oggi urgente aggiungerne un’altra: “Che figli lasceremo al mondo?”». Persiste in me una vivace inquietudine: che questa scuola, dopo il massiccio e costoso maquillage, continuerà a premiare chi già è favorito – mi riferisco sia agli allievi che ai singoli istituti comunali – mentre i soliti noti continueranno a pagare lo scotto di un sistema ripiegato su se stesso e sui problemi del presente. Forse, invece, servono grandi visioni per il futuro.
Servono fondamenta solide per edificare la casa poliglotta
Ogni tanto bisognerebbe avere il coraggio di indignarsi. Come quando si incespica casualmente in un articoletto che parla dell’ennesima fregola per il plurilinguismo a scuola: «Occorre una progetto di riforma globale dell’insegnamento delle lingue a tutti i livelli della scolarità, dall’inizio della scolarizzazione fino ai 18 anni», ho letto nel giugno scorso su questo giornale. Toh, mi sono detto, ci risiamo. Poi sono sobbalzato sulla sedia quando ho visto qual era il pulpito: «Ne è convinta la Commissione scolastica del Gran Consiglio che ha presentato una mozione chiedendo al Governo di agire in questo senso». La mozione è lunga e articolata e affronta il capitolo del plurilinguismo partendo dalla scuola dell’infanzia per spingersi su su fino alle scuole post-obbligatorie. L’atto parlamentare è sottoscritto da ben tredici deputati, che rappresentano pressoché tutti i partiti del nostro Parlamento; qualcuno di loro proviene addirittura dal mondo della scuola e dovrebbe dunque conoscerne pregi, difetti e rogne. Da qui la conclusione che non serve scandalizzarsi. Ma almeno si può dissentire.
Da diversi anni si levano con regolarità gli allarmi per lo stato pietoso della lingua italiana nel nostro cantone. Inutile citare gli appelli che giungono da tante parti e i suggerimenti di più d’un gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento stesso. Nel contempo il Ticino non perde occasione per alzare la voce in difesa dell’italiano: ma che serve valicare le Alpi con atteggiamenti tra il vittimistico e il battagliero, se poi l’italiano non lo si difende laddove è lingua nazionale? A ogni buon conto, al di là di tante enunciazioni e dei migliori propositi, non si intravedono progetti incisivi per dare una scossa all’insegnamento dell’italiano. Sembra addirittura che nel recente passato siano entrati all’Alta Scuola Pedagogica studenti con l’italiano claudicante. Non ci si dovrebbe scordare che per imparare una seconda lingua è necessario saperne una a menadito. Per noi l’assoluta padronanza dell’italiano è la condizione irrinunciabile per pensare (possibilmente bene…) e per accostarsi alle seconde, terze e quarte lingue. In mancanza di ciò si è esclusi in partenza. Tanti allievi, in sostanza, continueranno a ingrossare la già ampia schiera di chi giunge al termine dell’obbligo scolastico tra mille difficoltà. Perché il bello delle altre lingue è che fungono facilmente da setaccio della riuscita scolastica: non è un caso che, accanto alla matematica, nei livelli differenziati della scuola media c’è sempre una seconda lingua. Tedesco e francese, indubbiamente, massacrano un sacco di studenti e li mandano a fare l’apprendista senza troppi giri di parole.
Quanto all’insegnamento di quella disciplina che va sotto il nome di «Italiano», sarebbe opportuno e urgente un chiarimento: posto che dietro ogni valutazione ci dev’essere un insegnamento, bisognerebbe capire cosa descrive la nota di italiano. Il piano di formazione della scuola media è ricco e articolato; esso prevede l’insegnamento letterario, la pratica costante della scrittura, l’apprendimento grammaticale. Non è però chiaro cosa influisca maggiormente sulla nota finale e come sia suddiviso il tempo dedicato all’insegnamento. L’impressione – solo una vaga sensazione – è che la letteratura e la grammatica abbiano un peso specifico di rilievo, mentre le abilità linguistiche seguano un percorso più indipendente e, soprattutto, spesso estraneo ai curricoli scolastici. Forse converrebbe un chiarimento, per far sì che le (in)capacità linguistiche non possano nascondersi tra le pieghe dei fenomeni letterari e della grammatica: perché una cosa è l’abilità di restituire qualche nozione di storia della letteratura o qualche regoletta grammaticale; e un’altra il sapersi esprimere correttamente in buon italiano. È norma secolare quella per cui chi parla e scrive bene di solito pensa bene, che tra lingua e pensiero vi è un filo diretto e che ricchezza lessicale e apprendimento si arricchiscono reciprocamente.
Classi maschili e femminili nella scuola media?
Classi separate per sesso, almeno nella scuola media. È quanto chiedono alcuni parlamentari della Lega, primo firmatario Bignasca il Giovane; meglio: chiedono di analizzare la possibilità di introdurre questo modello di apartheid scolastica, basato sulla “tesi educativa” – molto semplice, specificano – secondo cui «maschi e femmine sono talmente diversi fisicamente e psicologicamente che sarebbe un errore pretendere che imparino le stesse cose alla stessa età». La parola chiave è “talmente”. L’atto parlamentare evoca il parere di eminenti professori di didattica e pedagogia, butta là un po’ di numeri, qualche scuola del mondo anglosassone, un caso emblematico e l’inevitabile lieto fine: il livello di apprendimento è migliore. Eccola qua, la soluzione di un problema vecchio almeno quanto la scuola. Le classi maschili e femminili sono state una realtà per molti anni, almeno laddove era possibile. Asilo a parte, ho frequentato una classe mista solo a partire dalla terza ginnasio. Non credo che si trattasse di una decisione di natura pedagogica, ma solo della manifestazione concreta di un mondo piuttosto bacchettone; anche alla messa dei ragazzi della domenica alle nove noi dovevamo sederci di qua, le ragazze di là. È vero che la scuola ha spesso avuto il vezzo di escogitare qualche criterio ipoteticamente utile per facilitare l’apprendimento e la gestione delle classi. Il grande pedagogista svizzero Adolphe Ferrière (1879-1960), a un certo punto della sua carriera di studioso, aveva approfondito la possibilità di istituire le classi in base al segno zodiacale. Meno originale, invece, l’idea di dividere gli allievi in base al rendimento scolastico. È un uovo di Colombo (pedagogico) abbastanza ricorrente nelle discussioni tra insegnanti esasperati, che peraltro si avvicina ai famosi «livelli» della nostra scuola media – non mi pare con chissà quale profitto. Qualche anno fa, forse nel 2004, il governo britannico si era addirittura impossessato della brillante idea di raggruppare gli allievi in base al quoziente intellettivo, nell’intento di migliorare le prestazioni scolastiche di ognuno: non so che fine abbia fatto quella pensata, ma non risulta che la scuola inglese sia ultimamente assurta agli onori per il suo sistema scolastico all’avanguardia.
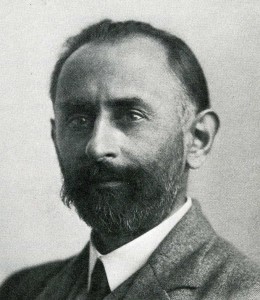
Personalmente, a dire il vero, ritengo che le classi migliori siano quelle più eterogenee. Più differenze ci sono, più ci sono possibilità di arricchirsi e di imparare nuove cose. Fosse per me introdurrei le pluriclassi nella scuola elementare e toglierei i livelli alla scuola media, accompagnando la misura con qualche modifica strutturale. Ma è chiaramente una posizione in controtendenza rispetto a chi è alla perenne ricerca di qualche trucchetto (semplice, per carità; e soprattutto a costo zero) che dovrebbe semplificare un compito che è tutto fuorché facile. Così si continua imperterriti a funzionare sul dogma dell’omologazione dei gruppi: non potendosi accontentare dell’età, si vorrebbero aggiungere, qua e là, altre combinazioni, come quella – appunto – del sesso. Ci si scorda però, o almeno si finge, che gran parte delle classi scolastiche hanno già subito una severa selezione economica e culturale, che sfugge al controllo della nomenklatura governativa e parlamentare. Città, borghi, paesi e quartieri hanno caratteristiche proprie: non si abita casualmente a Origlio o nel quartiere Semine di Bellinzona, tanto per fare un esempio. E allora sarebbero utili delle misure di accompagnamento più mirate e diversificate, per affrontare i veri problemi di ogni sede scolastica, perché non è vero che è la stessa cosa insegnare in una qualsiasi sede del cantone: alcune sono, diciamo così, più facili di altre, anche grazie alle stesse regole che determinano il numero di allievi per classe o l’attribuzione di operatori del sostegno pedagogico. Addirittura sono uguali gli stipendi degli insegnanti. Le regole del gioco, insomma, sono le stesse da Airolo a Chiasso, a tutto vantaggio di chi i vantaggi li ha già nel pedigree. Lasciamo dunque perdere maschi e femmine, e vediamo di occuparci di cose più serie.
Le scuole comunali si profilano
L’Ufficio delle scuole comunali del DECS ha diffuso in gennaio il «Profilo professionale di riferimento per i docenti delle scuole comunali», una descrizione accurata delle competenze e dei comportamenti attesi dai docenti e riferiti al lavoro in sezione con gli alunni, alla preparazione, alla formazione, alla vita di istituto, alle relazioni con i colleghi, le autorità, i genitori, la comunità locale. Composto da sessanta competenze suddivise in sette aree, che vanno dalle competenze di base alla programmazione, dalla valutazione alla vita d’istituto, il documento è il frutto di un lavoro di riflessione che il Collegio degli ispettori ha riservato alla figura e al mandato dei docenti di scuola dell’infanzia ed elementare, cercando gli elementi che ne caratterizzano la professione, identificandoli, precisandoli, esplicitandoli e organizzandoli in un testo organico. Come detto, il «Profilo» è stato trasmesso ai diretti interessati – insegnanti, uffici dipartimentali, direttori e ispettori – nonché alle autorità comunali, alle associazioni magistrali e alla conferenza cantonale dei genitori. Forte di una risoluzione dipartimentale (del marzo dell’anno scorso) secondo cui esso rappresenta un punto di riferimento centrale per lo sviluppo della politica scolastica comunale e cantonale, l’Ufficio delle scuole comunali ha iniziato a promuovere contatti e incontri con tutti i possibili interessati, affinché entro la fine del prossimo anno scolastico sia possibile la messa a punto della sua versione definitiva, che sarà oggetto di approvazione da parte del Dipartimento e che, dunque, diventerà la Magna carta delle scuole comunali, nell’intento di oltrepassare i grandi enunciati di principio che fondano tutti i sistemi scolastici e, in fin dei conti, per illustrarne la giusta applicazione. In quest’epoca dominata da copiose contraddizioni e da un’abissale confusione, l’intento dei nostri ispettori è ammirevole: mettere un po’ di ordine nei compiti della scuola è un atto dovuto, affinché tutti gli attori coinvolti – dai genitori alle autorità comunali, dai docenti ai direttori agli stessi ispettori – sappiano quali sono le effettive spettanze delle scuole comunali; meglio ancora: che sia chiaro quali impegni non possono toccare alle maestre e ai maestri, come ad esempio surrogare psicoterapeuti, psichiatri, consulenti familiari e assistenti sociali per fronteggiare “patate bollenti” di cui ben altri professionisti si dovrebbero occupare.
Nondimeno bisogna pur dire che, nel suo complesso, la versione attuale del documento non è esente da alcune ridondanze e da qualche specialismo di troppo. Sarà dunque utile lavorare sodo nei prossimi mesi affinché la versione ultima che sarà convalidata dal DECS riesca a tratteggiare un profilo esaustivo che, nel contempo, non lasci adito a equivoco alcuno: una fatica di non poco conto, se solo si considera che l’insegnante ideale non è solo il frutto di un complesso di conoscenze professionali via via arricchite dall’esperienza. Far scuola giorno dopo giorno a una classe di bambini o ragazzi, educandoli e insegnando loro «a scrivere, leggere e far di conto», per riassumerla con uno slogan ancora attuale, significa svolgere un’attività sempre in bilico tra professionismo e artigianato, di solito per alcuni anni a contatto quotidiano con individui che, nella loro irripetibilità, richiedono uno sforzo e un’originalità pedagogica che soverchiano i contenuti di ogni manuale di pedagogia o di scienze dell’educazione. Se – come recitano le prime competenze che s’incontrano nel «Profilo» – l’insegnante deve possedere una buona cultura umanistica e generale e deve padroneggiare una lingua (italiana!) ricca e articolata, allora significa che ci si prefigge un modello umanista, che mette in risalto un insegnante erede della storia della scuola e della pedagogia, un Maestro ben lontano da tante correnti ingegneristiche dei nostri tempi. Sarà dura, ma è questa la strada da percorrere per garantire un futuro di eccellenza a livello educativo e di apprendimenti.
HarmoS: accordi, disaccordi e indifferenza
Quasi mezza Svizzera ci applaude. L’altra metà non si sa. Ci voleva la ratifica di dieci cantoni per far decollare HarmoS, l’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria e il Gran Consiglio ticinese, appunto, ha dato il suo placet il 17 febbraio. La raccolta di firme per sottoporre il voto del parlamento al popolo, lanciata dal «Noce» del sindaco di Bellinzona insieme ai giovani UDC e al sindacato studenti e apprendisti, è stato sepolto da una sonora risata: un migliaio le firme raccolte, contro le settemila richieste, senza che la piazza riuscisse minimamente a scaldarsi. Ora, dunque, in quattro cantoni svizzero-tedeschi, in quattro cantoni romandi, in Vallese e in Ticino l’accordo, che prima o poi dovrà pur diventare nazionale, entrerà nella sua fase operativa, anche se sul lungo termine è difficile ipotizzare come sarà possibile mettere d’accordo tutti i ventisei cantoni e semi-cantoni senza troppo stemperare i contenuti dell’intesa. Al momento attuale già tre cantoni e mezzo l’hanno respinta in votazione popolare; si voterà invece a Berna e a Zugo, mentre a Friborgo il termine per la raccolta delle firme è scaduto nei giorni scorsi. Mancano comunque all’appello in nove, tra cantoni e semi-cantoni: come si vede, per intanto imperversa il disaccordo. Viene poi da sorridere a immaginare cosa farà la Confederazione quando tutti si saranno espressi e sarà chiara la geografia degli integrati e degli autonomisti: perché è giusto ricordare che la Berna federale potrà obbligare i cantoni riottosi ad aderire alle convenzioni intercantonali, anche se occorrerà far sì che la nuova zuppa di Kappel non risulti indigesta e annacquata, rischiando di vanificare l’ambizioso patto.
Fino ad oggi HarmoS non ha infiammato più di tanto noi ticinesi. Già dai blocchi di partenza abbiamo ottenuto qualche favore, come la possibilità di mantenere la nostra scuola elementare di cinque anni e la media di quattro. L’altra Svizzera italiana, quella grigionese, si è già tirata fuori, a rimorchio del suo cantone, che ha bocciato l’accordo in votazione popolare a fine novembre. Per chi ha aderito ad HarmoS ci sono per ora solo due paletti ben chiari: che la scuola dell’obbligo durerà due anni in più e che la data di riferimento per il debutto sarà il 31 luglio per tutti (o, almeno, per chi avrà deciso di far parte dell’Elvezia armonizzata). Si tratterà ora di capire in che misura il nostro cantone, che in pratica è anche regione linguistica a sé stante, sarà in grado di seguire i dettami di HarmoS senza uscirne con le ossa rotte e magari guadagnando in qualità. Dietro l’angolo ci sono la definizione di un piano di studio e gli standard nazionali di formazione. A differenza delle altre regioni linguistiche noi non dovremo andare alla ricerca di nuovi accordi e di altri compromessi in vista del piano di studio: si può immaginare che ci terremo i nostri programmi e amen. Con la trasformazione della scuola dell’infanzia da facoltativa a obbligatoria, sarà tuttavia interessante capire da una parte come il carattere vincolante dell’inizio a quattro anni sarà interpretato e attuato; dall’altra come gli attuali «Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia» si integreranno a pieno titolo nel piano di studio ticinese, affinché l’obbligatorietà votata dal parlamento sia poi in grado di convincere anche quelle famiglie che storcono il naso nel vedersi i figli sottratti precocemente dallo Stato.
Quanto agli standard nazionali di formazione per la scolarità obbligatoria, che riguardano sia le competenze da acquisire (standard di prestazione), che i contenuti di alcuni settori della formazione, si sa che già ora sono in atto degli scontri accaniti tra le due altre aree linguistiche, ognuna delle quali seriamente intenzionata a promuovere la proprie scelte precedenti. Come si posizionerà il Ticino tra questi due fuochi incrociati è difficile prevederlo, cullando però la speranza che i nuovi modelli nazionali rappresentino degli strumenti per pilotare il miglioramento costante della scuola e non si limitino a legittimare i risultati esistenti, che – PISA insegna – non sempre hanno destato entusiasmo.
