Un libro singolare raccoglie opinioni diverse attorno alla missione dell’insegnamento
Di questi tempi dire che destra e sinistra sono schematismi superati è assolutamente politically correct. L’affermazione è certamente giusta se l’applichiamo ai partiti tradizionali, alle prese con la moltitudine di problemi richiesti dalla quotidiana convivenza nell’ambito dello Stato, ma mantiene intatto il suo significato tradizionale quando il dibattito verte su un tema preciso, come è certamente quello della missione della scuola. Una riprova viene proprio da questo «Deux voix pour une école»: il ministro delegato all’insegnamento scolastico francese Xavier Darcos e il noto studioso di scienze dell’educazione Philippe Meirieu, sollecitati dalla giornalista di Le Figaro Marielle Court, si lanciano in un lungo e appassionante dibattito sulla scuola, oggi al centro di molte preoccupazioni.
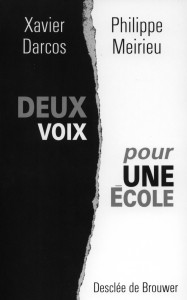 Il libro ha visto la luce in maniera per lo meno bizzarra: il 15 settembre dell’anno scorso era partito un grande dibattito nazionale sull’educazione, voluto dal primo ministro Jean-Pierre Raffarin, per far fronte alle gravi tensioni che caratterizzano la scuola francese ormai da qualche anno. Così il ministro delegato e l’illustre ricercatore, che già in precedenza si erano scontrati pubblicamente su molti dei maggiori media nazionali, si trovano discretamente per alcuni pomeriggi negli uffici della casa editrice e danno vita a questo contraddittorio, la cui uscita nelle librerie era prevista per metà ottobre, con un titolo diverso («Libres propos sur l’école»). Ma il 12 settembre – due giorni prima dell’apertura del dibattito nazionale – Le Monde dà notizia che il libro è stato censurato: «Dominique Ambiel, consigliere per la comunicazione del ministro Raffarin, ha fatto pressioni sul ministro delegato all’insegnamento scolastico affinché la sua conversazione con il pedagogista Philippe Meirieu non appaia». In altre parole: caro Darcos, o blocchi il libro o lasci il ministero. Meirieu, dal canto suo, reagisce pubblicizzando la sua parte del testo, ma non se la prende con Darcos, che giudica leale e coraggioso.
Il libro ha visto la luce in maniera per lo meno bizzarra: il 15 settembre dell’anno scorso era partito un grande dibattito nazionale sull’educazione, voluto dal primo ministro Jean-Pierre Raffarin, per far fronte alle gravi tensioni che caratterizzano la scuola francese ormai da qualche anno. Così il ministro delegato e l’illustre ricercatore, che già in precedenza si erano scontrati pubblicamente su molti dei maggiori media nazionali, si trovano discretamente per alcuni pomeriggi negli uffici della casa editrice e danno vita a questo contraddittorio, la cui uscita nelle librerie era prevista per metà ottobre, con un titolo diverso («Libres propos sur l’école»). Ma il 12 settembre – due giorni prima dell’apertura del dibattito nazionale – Le Monde dà notizia che il libro è stato censurato: «Dominique Ambiel, consigliere per la comunicazione del ministro Raffarin, ha fatto pressioni sul ministro delegato all’insegnamento scolastico affinché la sua conversazione con il pedagogista Philippe Meirieu non appaia». In altre parole: caro Darcos, o blocchi il libro o lasci il ministero. Meirieu, dal canto suo, reagisce pubblicizzando la sua parte del testo, ma non se la prende con Darcos, che giudica leale e coraggioso.
Strano destino quello di un dibattito nazionale voluto dalle più alte cariche dello Stato, che debutta con una censura: ma tant’è, dopo vari tira e molla il volume va finalmente in libreria, con un titolo nuovo ed esemplare: sì, perché i mondi che si incontrano sono davvero diversi, sono sul serio di destra e di sinistra. A destra il ministro, che preconizza la restaurazione dell’Autorità del maestro e della Scuola, anche se “l’ascensore della promozione sociale”, nel mondo globalizzato, non funziona più e genera frustrazione e amarezza negli insegnanti (e non solo). A sinistra lo studioso, che crede nella forza liberatrice della cultura e del sapere, e si impegna per il riscatto degli umili attraverso la scelta di educare (oltre il “semplice” diritto di avere un’educazione). Non mancano, beninteso, i punti di convergenza, in un dialogo tra due profondi conoscitori del sistema scolastico: il libro ha una sua universalità, anche se in tutta evidenza gli esempi e tante riflessioni si basano sulla realtà francese. Ma il dibattito resta franco e civile, al di là delle intense contrapposizioni e dei momenti anche duri e polemici.
La conclusione non può che trovarsi su due sponde diverse, seppure convergenti: per Meirieu “… in una democrazia il ministero dell’educazione nazionale dovrebbe essere il ministero dell’Utopia – l’utopia fondatrice di ogni speranza, quella di una cultura emancipatrice di tutti gli uomini”. Gli fa eco Darcos: “Il sapere, lo zoccolo d’una vita, si fabbrica a Scuola. Solo a Scuola, mentre tutto, attorno ad essa, ne nega il valore, a profitto dell’apparire, della comunicazione, dello spettacolo, dell’estetica del clip, dell’effimero, del litigio”. Resta la grande divisione: cultura per tutti o solo per taluni?
Insomma, un gran bel dibattito, civile nei toni e profondo nei punti di vista: Voltaire contro Rousseau, Darcos contro Meirieu, due voci per una scuola, al di là dei soliti problemi di bilancio, ma al cuore della scuola repubblicana.
Recensione pubblicata sul Corriere del Ticino del 21 gennaio 2004
