Una polemica stucchevole imperversa da giorni a proposito del diario scolastico quale presunto strumento di indottrinamento. Un polverone che sa di tristemente elettorale
La polemica attorno all’Agenda della Svizzera italiana continua a tener banco. Il consueto diario scolastico per la scuola media, edito dal Dipartimento dell’Educazione e da quello della Socialità e della Sanità, ha come fil rouge per il 2023-24 Lo sguardo altrui: istruzioni per l’uso. Accanto ad alcune schede che informano e aiutano a riflettere, ci sono dieci storie raccontate, ognuna, con due disegni e un breve dialogo: dieci piccole storie per parlare di malintesi e pregiudizi, di come ci si sente e di come si vorrebbe essere. Nulla che sia fuori dall’ordinario, come dev’essere nello spirito di uno strumento di lavoro che accompagnerà allieve e allievi lungo tutto l’incombente anno scolastico.
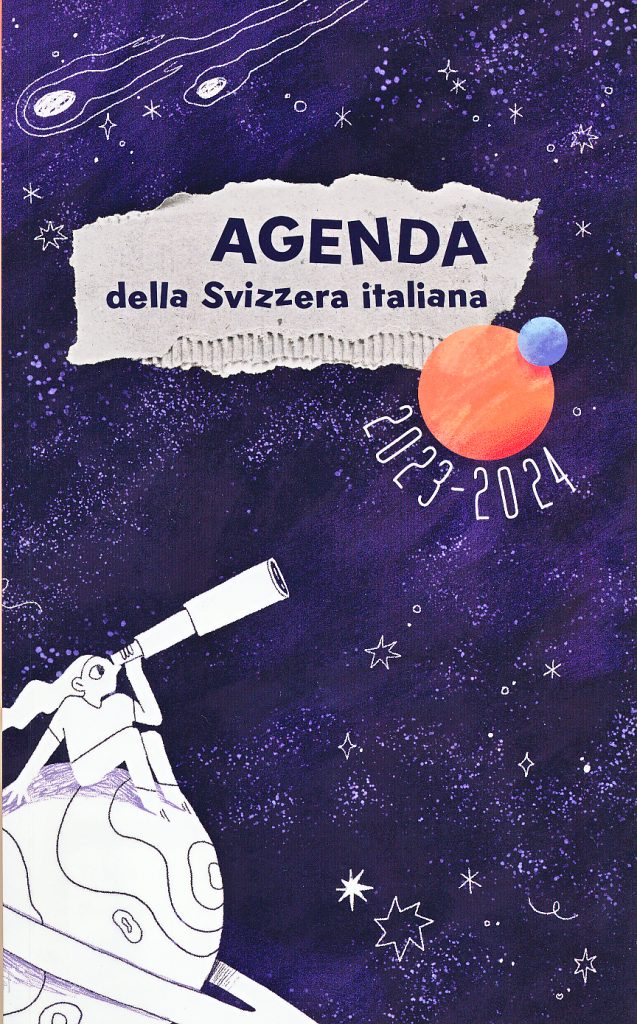
Siamo in un ambito complementare ai contenuti disciplinari della scuola. Nell’agenda, per intenderci, non vi sono valutazioni, esercizi, compiti a casa e giudizi di valore. Tutt’al più ci sono degli spunti per riflettere o discuterne. È così da tanti anni, non solo dall’arrivo dei “rossi” al DECS – come insinuano i Torquemada nostrani – e senza scordare che la direzione socialista del Dipartimento dell’educazione, dopo decenni di gestione PLRT, non fu per nulla un golpe.
Eppure quest’anno si è scatenato il putiferio. Tra le dieci piccole storie, il vicesindaco di Locarno ne ha scovata una che gli è andata di traverso e che ha voluto condividere urbi et orbi: Giuseppe Cotti boccia l’agenda scolastica: “Banalizza la diversità di genere”. Non si contano gli interventi che intasano il Ticino massmediatico (e social) ormai da una decina di giorni e che hanno acceso i pruriti di una pedagogia codina. Ci vuole però una buona dose di malignità per leggere in quei brevi dialoghi dei pensieri chissà quali intenti di indottrinamento, tesi a far sì che i nostri adolescenti abbraccino, affascinati!, il cosiddetto terzo sesso, che ha peraltro una gamma di coniugazioni assai variegata.
Qualche esempio di tanto sdegno è forse utile annotarlo: «Con il pretesto dell’inclusione, della lotta al bullismo e alla discriminazione, nonché della tutela delle minoranze, ai ragazzi viene insegnata l’ideologia secondo cui maschio o femmina sono sensazioni interiori o percezioni, proprio come si legge nell’agenda che sarà presto distribuita agli scolari ticinesi» (Helvethica Ticino). Oppure: «La scuola rossa colpisce ancora: propaganda gender nell’agenda ufficiale del DECS. Inaccettabile il tentativo del Cantone di lavare il cervello ai bambini fin dalle elementari con l’ideologia ‘‘arcobaleno’’» (Lorenzo Quadri, Consigliere nazionale Lega, sul Corriere del Ticino). E ancora: «Si cerca di far passare che essere fluidi, dubbiosi sul proprio sesso – quando biologicamente e di fatto, o si è maschi o femmine [tertium non datur, secondo lorsignori] – siano scelte di tendenza e accattivanti. Ogni individuo è libero di sentirsi maschio, femmina e magari in futuro anche cane, gatto o canarino, ma non deve essere la scuola a promuovere e a mostrare come normale, delle anomalie comportamentali che toccano un’estrema minoranza della popolazione» (Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC, su laRegione).
Suvvia, sarebbe fantastico se con dieci righe e due disegni fosse possibile – per usare un verbo un po’ sguaiato – indottrinare i nostri ragazzi alle leggi della matematica e delle scienze naturali, a insegnare in fretta e a un alto livello l’italiano e le altre lingue, insieme alle loro culture di riferimento, a conoscere e amare il variegato patrimonio delle arti. A meno che non si creda per davvero che sia possibile inventarsi un gender prêt-à-porter, così come si sceglie una t-shirt o un taglio di capelli.
Due parole, infine, devono essere spese sulla distribuzione dell’agenda in quinta elementare. Da un lato si dovrebbe rammentare che questo diario fa parte del materiale dell’ultimo anno della scuola primaria da quando è stata istituita la scuola media: era parso, ad alcuni insegnanti degli anni ’70, che poteva essere utile imparare a usare questo strumento, che nel precedente ginnasio mieteva tante vittime già al primo anno, quando il passaggio dal maestro al professore poneva molti problemi di organizzazione della settimana e della gestione di compiti a casa e test annunciati. Nel frattempo l’agenda si è evoluta nei suoi contenuti, pensando però, giustamente, agli alunni della scuola media. Sulla diffusione automatica dell’agenda già in 5ª, quindi, si potrebbe anche discutere, ma non certo per entrare nel merito delle farneticazioni sulle sue nefaste influenze.
Non può che essere giudicata preoccupante la scelta di alcuni Municipi di non distribuire l’agenda, come deciso a Tresa, Lugano, Massagno, Mendrisio e altri comuni. Ma, fortunatamente, c’è chi rimette i puntini sulle i, in attesa che il Cantone intervenga con la necessaria severità per ricordare che la direzione generale della scuola spetta al Consiglio di Stato e non certo ai singoli municipi. Bene ha fatto, quindi, la sindaca di Castello, Alessia Ponti: «Non sta ai Municipi ergersi a paladini della moralità», ha commentato sul CdT di ieri. «I nostri bambini hanno affrontato temi anche molto più delicati, come la guerra in Ucraina. Tutto sta a come viene trattato l’argomento, ma è proprio del ruolo del docente saper usare le parole e la delicatezza giuste. E i nostri docenti si sono dimostrati molto tranquilli e consapevoli a tal riguardo».
Parole sante.
Scritto per Naufraghi/e

