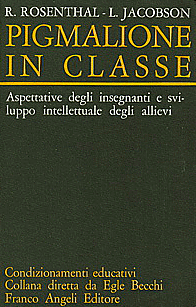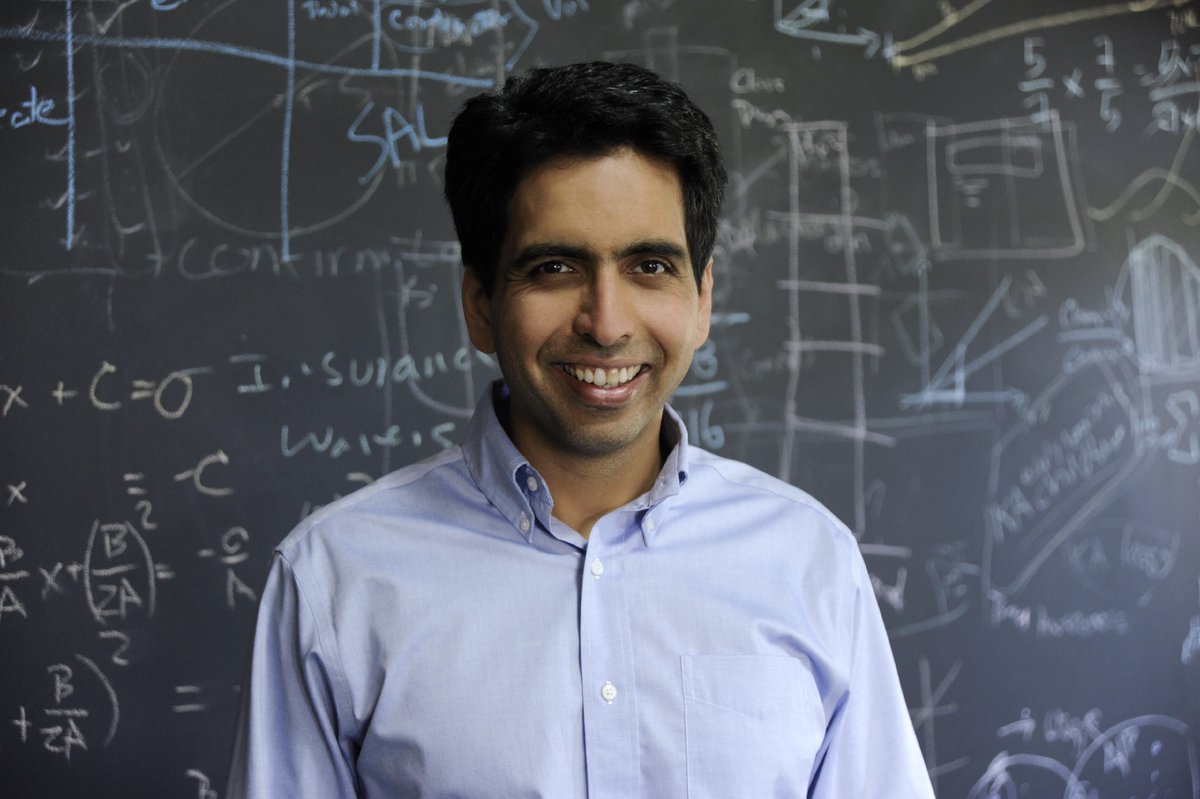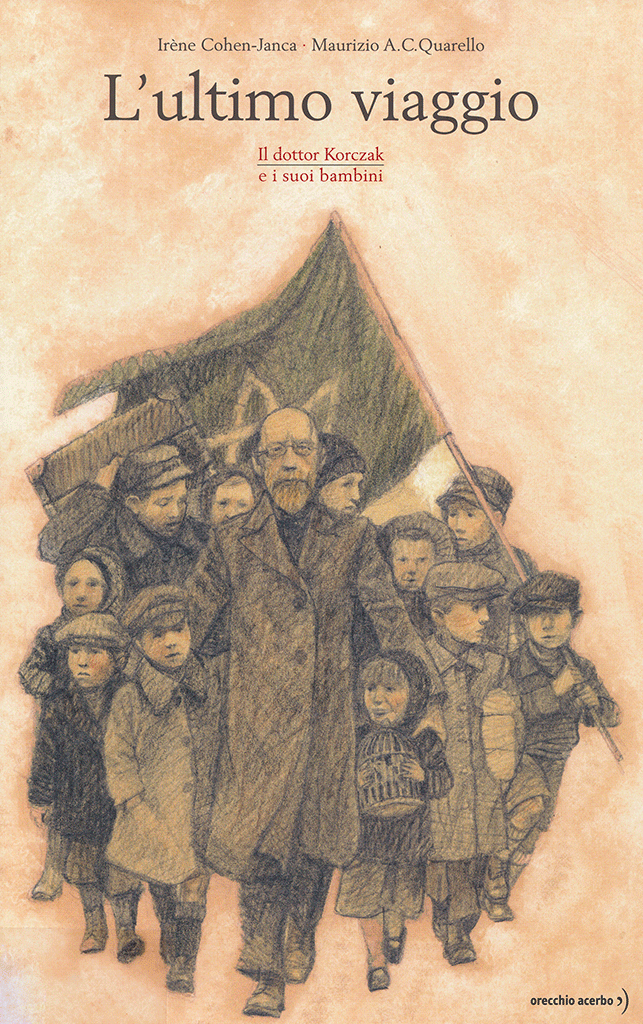Nel suo numero del 2 aprile il domenicale Il caffè ha pubblicato un’inchiesta abbastanza esaustiva sugli umori del Paese nei confronti del progetto La scuola che verrà, di cui ho più volte parlato in questo sito sin dalla sua prima presentazione, nel dicembre del 2014.
 L’ampio servizio si apre con una sintesi critica dell’inchiesta, firmata dal giornalista Clemente Mazzetta: «Ecco quale scuola vogliamo nel futuro». Poco sotto, arriva il commento del direttore del DECS Manuele Bertoli: «Investire nella scuola è investire nella società».
L’ampio servizio si apre con una sintesi critica dell’inchiesta, firmata dal giornalista Clemente Mazzetta: «Ecco quale scuola vogliamo nel futuro». Poco sotto, arriva il commento del direttore del DECS Manuele Bertoli: «Investire nella scuola è investire nella società».
L’intero servizio, naturalmente, lo si può consultare nel sito del domenicale: http://www.caffe.ch/.
Come mi era già successo altre volte, anche in questo frangente sono stato interpellato dal giornalista, che ha pubblicato l’intervista col titolo generale Rigozzi e Tomasini sulla “scuola che verrà”. Ex direttori scolastici a confronto. Naturalmente è stato impossibile, per il giornalista, riportare per intero la nostra chiacchierata (mezz’oretta nel pomeriggio del 22 marzo). Così voglio concedermi il gioco di completare o commentare quell’intervista, distinguendo le domande del giornalista, le mie risposte e i miei commenti successivi.
È una battaglia da combattere ma evitando scontri partitici
«La scuola dell’obbligo ha bisogno di serenità. E deve essere sganciata dal continuo richiamo al mondo del lavoro. Anche perché non sappiamo quali potranno essere le competenze che fra 15 anni saranno richieste dalla società», sostiene Adolfo Tomasini, ex direttore della scuola elementare di Locarno.
Il Corriere del Ticino del 10 febbraio scorso aveva pubblicato una lunga intervista al prof. Emanuele Caranzano, direttore del Dipartimento tecnologie innovative alla SUPSI, dove tra l’altro si leggeva che «il 65% di coloro che oggi hanno 12 anni faranno dei lavori che oggi non esistono. In altre parole, tra 10 anni più della metà dei lavori saranno attività che ancora non ci sono». Si provi allora a immaginare queste percentuali ipotetiche se le volessimo applicare a quei bimbi che hanno iniziato la scuola dell’obbligo nel settembre scorso, a quattro anni, e che i vent’anni li compiranno nel 2028 o giù di lì.
Che impressione ha avuto leggendo la riforma della scuola?
Che pone degli obiettivi condivisibili. L’abolizione dei livelli e della media per l’accesso al liceo, il tutto all’interno di una scuola di qualità è una battaglia che si deve fare. Ma con intelligenza, evitando lo scontro ideologico e partitico.
Come ho scritto più e più volte, all’origine del progetto La scuola che verrà c’è una scelta schiettamente e fatalmente ideologica, che condivido. Ancora di recente ho scritto che «nessuno ha il coraggio di porre l’unica domanda fondamentale, che impone una risposta serena e trasparente: che scuola vogliamo? Una scuola per la democrazia e il Paese oppure al servizio dell’economia? In altre parole, desideriamo educare cittadini o selezionare e formare lavoratori?» (Una scelta per la scuola del Paese che verrà, Corriere del Ticino del 22.12.2016). Va da sé che io pendo con forza per una scuola dell’obbligo che educa cittadini democratici.
La riforma promuove una scuola equa e inclusiva. È sostenibile?
Sì, ma bisogna capirci bene sul termine inclusività.
Rimando al mio scritto «L’inclusione tra sogni e realtà», del 5 ottobre 2014.
L’obiettivo egualitaristico della riforma è forse troppo… egualitario?
Macché. Se per pari opportunità si intende che tutti possono andare a scuola, questa pari opportunità non significa niente. Anche l’ultima analisi statistica de “La scuola a tutto campo” (Supsi, 2015) ha ricordato come la condizione socioeconomica di appartenenza dei ragazzi resti una variabile importante nel fallimento scolastico. E se esiste ancora questa situazione, ha ragione Bertoli: qualcosa bisogna fare.
Nel merito è favorevole all’abolizione dei livelli?
Senza dubbio. Creano una divisione fittizia.
Tra l’altro parliamo di ragazzine e ragazzini di 12/13 anni.
Favorevole anche all’abolizione della media del 4.65?
Sì. È una media inventata. La prova che non serve a nulla è data dal fatto che oggi il 30% dei ragazzi che entrano nel liceo viene bocciato. Occorre invece mettere il ragazzo nella condizione di fare delle scelte consapevoli.
Nell’introduzione al servizio, Clemente Mazzetta ha ripreso una mia domanda, naturalmente retorica, che rimanda proprio a questa necessità di togliere di mezzo i livelli. Scrive: «Del resto come rispondere all’interrogativo dell’ex direttore della scuola media [comunale, in verità] di Locarno Adolfo Tomasini (vedi intervista a lato) quando chiede di spiegargli “come fa uno a diventare ingegnere Supsi (cosa possibile partendo dall’apprendistato), dopo aver mancato la possibilità di iscriversi al liceo per non aver raggiunto il fatidico 4.65?” Per dire che ’sto 4.65, che è tutto fuorché una media matematica, dice solo che in quel momento lì quel/la giovane aveva un rendimento scolastico di poco superiore al quattro e mezzo.
Quando leggo che bisognerebbe innalzare la soglia del 4.65 per l’accesso alla scuola media superiore mi vengono i brividi, perché è un salto indietro pauroso: quella sarebbe una scuola per la pura e semplice crescita economica, a vantaggio di pochi, mica per il consolidamento della democrazia. Peggio dell’attuale, dunque.
La riforma non prevede troppi compiti per i docenti?
Forse sì. Ma non è questo il problema più importante. Del resto non ci sono soluzioni magiche.
Il compito primario dei docenti è quello di insegnare. Per insegnare bisogna conoscere bene ciò che si insegna (competenze disciplinari) e come si insegna (competenze professionali). Insegnare significa, grosso modo, “lasciare un segno”. L’insegnante professionalmente irreprensibile è quello che ‘non molla l’osso’, è quello che fa tutto il possibile per portare ogni allievo al limite massimo delle sue possibilità, senza perdere troppo tempo con esami e test reiterati (che, come già diceva Don Lorenzo Milani, è tempo rubato all’insegnamento).
La si smetta, insomma, con la storiella che l’egualitarismo porta automaticamente al livellamento delle menti, naturalmente verso il basso. La metafora trita e ritrita della siepe va bene solo per chi non sa o non vuole insegnare, cioè lasciare dei segni tangibili.
La ritiene una riforma economicamente sopportabile?
Non saprei. Ma mi urta questa concezione che vede ogni cambiamento come fonte di spesa, forse bisognerebbe verificare se si impiegano bene ora le risorse disponibili. Piuttosto il problema è di sostenibilità politica della riforma. Il Plrt si è pronunciato chiedendo un innalzamento dei livelli, più selezione. La Lega, con Lorenzo Quadri ha sostenuto che quello che si insegna a scuola deve essere deciso dal mercato, non da pedagogisti.
Il riferimento preciso torna alla campagna elettorale per il rinnovo dei poteri cantonali del 2011. Lorenzo Quadri, sul Mattino del 20 marzo, scrisse: «La scuola non potrà esimersi da un riorientamento nell’ottica di quelle che sono le richieste del mercato del lavoro. È evidente che le professioni “d’ufficio” sono sature. Mancano risorse nell’artigianato, nell’edilizia, nel sociosanitario. Altra misura necessaria: si metta il numero chiuso alle formazioni “letterarie” ed “artistiche” prive di sbocchi professionali».
Ma così la scuola dell’obbligo dovrebbe formare lavoratori non cittadini?
Sono convinto che in molti Paesi europei c’è una scuola per la crescita economica e non per il rafforzamento della democrazia. Ma non è con il corso di civica che risolviamo il senso civico dei cittadini.
Ha scritto la filosofa americana Martha C. Nussbaum: «Le nazioni sono sempre più attratte dall’idea del profitto; esse e i loro sistemi scolastici stanno accantonando, in maniera del tutto scriteriata, quei saperi che sono indispensabili a mantenere viva la democrazia. Se questa tendenza si protrarrà, i paesi di tutto il mondo ben presto produrranno generazioni di docili macchine anziché cittadini a pieno titolo, in grado di pensare da sé, criticare la tradizione e comprendere il significato delle sofferenze e delle esigenze delle altre persone. Il futuro delle democrazie di tutto il mondo è appeso a un filo.
Quali sono questi cambiamenti radicali? Gli studi umanistici e artistici vengono ridimensionati, nell’istruzione primaria e secondaria come in quella universitaria, praticamente in ogni paese del mondo. Visti dai politici come fronzoli superflui, in un’epoca in cui le nazioni devono tagliare tutto ciò che pare non serva a restare competitivi sul mercato globale, essi stanno rapidamente sparendo dai programmi di studio, così come dalle teste e dai cuori di genitori e allievi. In realtà, anche quelli che potremmo definire come gli aspetti umanistici della scienza e della scienza sociale – l’aspetto creativo, inventivo, e quello di pensiero critico, rigoroso – stanno perdendo terreno, dal momento che i governi preferiscono inseguire il profitto a breve termine garantito dai saperi tecnico-scientifici più idonei a tale scopo». [Martha C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, 2011, Bologna: Il Mulino].
È un palliativo?
Peggio. Si illudono le persone. Così come si illudono i ragazzi nel dire loro che se imparano dieci lingue a scuola poi si troveranno bene.
Ho scritto più volte dell’impegno esagerato e un poco fuorviante legato alla politica di insegnamento delle lingue. Mi piace citare due scritti: I nostri figli sapranno tutti l’inglese: per dirsi cosa? (25.10.2006) e Mi ha piaciuto molto!… (06.10.2004).
Morale?
Qualcosa bisogna fare. Occorre ripensare la scuola. Ma il clima politico di questo momento non è certo il migliore; c’è il rischio di fare due passi indietro.