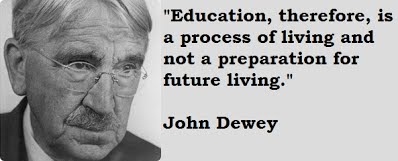
Il titolo di questo post fa l’occhiolino al fondamentale libro di John Dewey (1859-1952) Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education (1916, New York, The Macmillans Company), pubblicato per la prima volta in italiano nel 1949 dalla casa editrice La Nuova Italia, nella traduzione di Enzo Enriques Agnoletti e Paolo Paduano. Scriveva lo stesso Dewey nella prefazione, datata agosto 1915 (Columbia University, New York):
Le seguenti pagine contengono un tentativo di scoprire ed esporre le idee irnplicite in una società democratica e di applicare queste idee ai problemi del compito educativo. La discussione include un’indicazione degli scopi costruttivi e dei metodi dell’educazione pubblica osservati da questo punto di vista, e una valutazione critica delle teorie della conoscenza e dello sviluppo morale che erano state formulate in precedenti condizioni sociali, ma che ancora agiscono, in società nominalmente democratiche, per ostacolare l’adeguata realizzazione dell’ideale democratico.
Come apparirà dal libro stesso, la filosofia esposta in esso collega lo sviluppo della democrazia con quello del metodo sperimentale nelle scienze, con le idee evoluzionistiche nelle scienze biologiche, e con la riorganizzazione industriale allo scopo di far notare i cambiamenti che questi svolgimenti recano con sé nell’oggetto e nel metodo dell’educazione.
Mi è sembrato un spunto interessante – poco più di una citazione a mo’ di omaggio – per segnalare due libri di recente pubblicazione, dopo che, nel marzo dello scorso anno, avevo già segnalato la traduzione italiana di La Riposte. Écoles alternatives, neurosciences et bonnes vieilles méthodes : pour en finir avec les miroirs aux alouettes (Philippe Meirieu, 2018, Autrement Éditeur).
Nel frattempo sono apparsi due nuovi volumi di grande interesse. Il primo, ancora di Philippe Meirieu, ha per titolo Ce que l’école peut encore pour la démocratie. Deux ou trois choses que je sais (peut-être) de l’éducation et de la pédagogie, (2020, Autrement Éditeur).
Il secondo, di ENRICO BOTTERO, è Pedagogia cooperativa. Le pratiche Freinet per la scuola di oggi (2021, Armando Editore).
Nello stesso solco troviamo pure il seminario online organizzato il 14 aprile scorso dall’editore Armando: Incontro con Philippe Meirieu sul tema Quale educazione per affrontare le sfide del mondo attuale e preparare quello di domani (traduzione online di Enrico Bottero).
La registrazione dell’incontro è in YouTube (Incontro con Philippe Meirieu).




