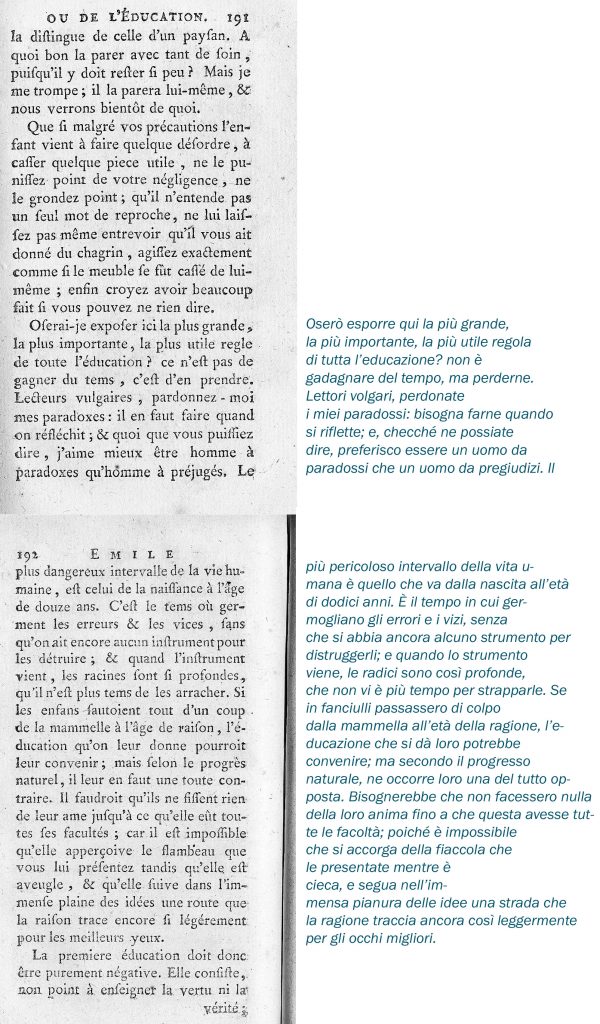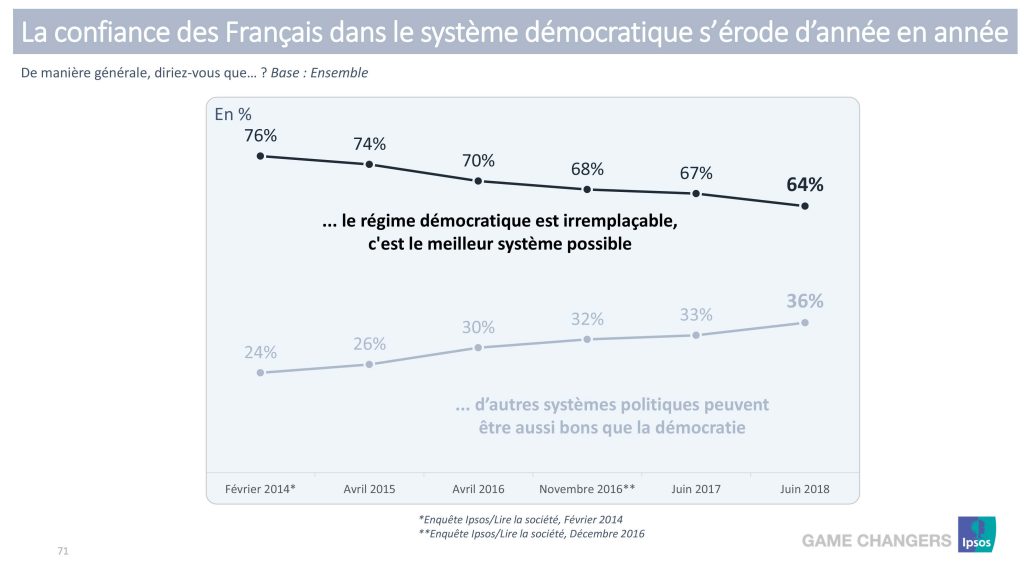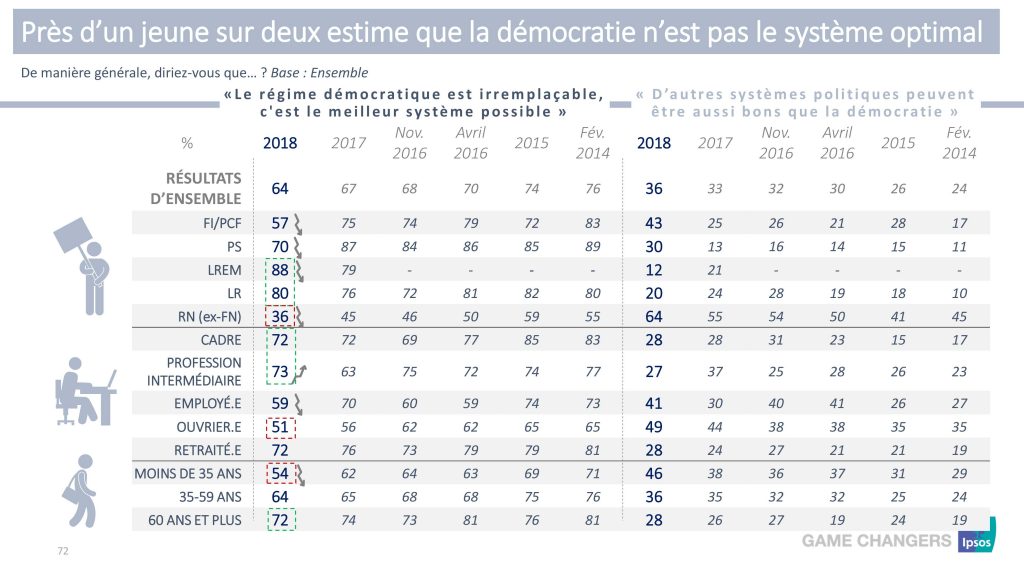Settecentrotrentaquattro.
Scritto così, in lettere, fa impressione. Sono i candidati che vorrebbero diventare parlamentari della nostra piccola Repubblica. Solo novanta, sparpagliati in una quindicina di liste, saranno eletti. Gli elettori, nel difficile momento della scelta, non potranno dire che mancavano le alternative. C’è da sperare che, da qui al 7 aprile, non si mettano tutti a scrivere su giornali e portali, tanto già oggi gli autori superano il numero dei lettori, con buona pace del dibattito. Anche nel caso delle elezioni, proprio come a scuola, ci saranno gli ultimi della classe, ma non è detto che siano davvero i peggiori. Gli elettori sono come i maestri, ognuno ha il suo metro per valutare. Così può succedere che gli ultimi siano i primi. E arrivare ultimo non è mai piacevole.
Quest’anno, al di là delle emergenze ambientali, che sono reali, va di moda il verde. Quasi un quarto delle liste si rifanno al verde. C’è l’imbarazzo della scelta: ci sono i verdi liberali e quelli del Ticino, oltre alla lega verde. Verde è il colore della Lega, e varie sfumature di verde attraversano, tanto o poco, i partiti borghesi, oltre ad alcune liste di sinistra in ordine sparso. Capita però che tutta questa sensibilità ecologica si fermi sulla soglia della scuola dell’obbligo. Non sarà un caso che Falò, il settimanale d’informazione della Rsi, si sia occupato recentemente di scuola media: «Pressione, ansia e stress è ciò che subiscono molti ragazzi delle scuole medie ticinesi. La causa? Il sistema dei livelli A e B, i corsi attitudinali e base». Aggiungerei: piani di studio tronfi e ingannevoli. È la logica conseguenza dell’idea che ci si fa oggi della scuola: bisogna premiare il merito sin dalla più tenera età, i migliori avanzino negli studi, gli altri che abbraccino un apprendistato, che – si dice – non è una formazione di serie B. Ancora Falò: «Chi ha una licenza con i livelli B, dopo la scuola dell’obbligo si trova di fronte molte porte chiuse, fra cui anche quelle dell’apprendistato». Non ci sono santi che tengono – strepitano i nuovi fondatori della scuola che verrà – ci si deve abituare sin da piccoli a sopravvivere e a competere, perché, là fuori, il mondo è una giungla. Poi ci si dimentica di aggiungere che nella giungla i predatori sono più dei predati, e i più fragili sono i primi a soccombere.

Da qualche anno c’è il dibattito sul lupo, che sta mettendo su famiglia in Ticino. Ovvio che tutti abbiano la loro idea, soprattutto perché la gran parte di quei tutti ha una conoscenza dei lupi simile a quella in meccanica quantistica o in geometria frattale. Nel contempo nessuno, nei consessi politici e sindacali, si occupa della predazione istituzionale che avviene in troppe aule scolastiche. Perché, citando Edgar Morin, non si è più in grado di resistere alla pressione del pensiero econocratico e tecnocratico, attraverso la difesa e la promozione della cultura, che esige il superamento della separazione fra scienze e cultura umanistica. Chi ha una concezione ecologica del mondo dovrebbe impegnarsi affinché dentro le aule scolastiche ognuno abbia il diritto di sbagliare, o di non capire immediatamente le cose, magari solo perché non ha avuto la fortuna di avere il grado di maturazione previsto dalla scienza statistica in quel preciso momento. O di essere nato senza la camicia. Intanto quei quattro gatti di lupi ticinesi sono degni di lunghi dibattiti, anche se, quando azzannano qualche pecora, lo Stato rimborsa i contadini.
Si può rivedere il servizio del settimanale d’informazione della Rsi: Livelli da stress, di Katia Ranzanici, 21.02.2019
La citazione esatta di Edgar Morin è questa: Si tratta evidentemente di resistere alla pressione del pensiero econocratico e tecnocratico, facendosi difensori e promotori della cultura, la quale esige il superamento della disgiunzione fra scienze e cultura umanistica.
EDGAR MORIN, Insegnare a vivere – Manifesto per cambiare l’educazione, 2015, Milano: Raffaello Cortina Editore | Titolo originale: «Enseigner à vivre», 2014