Sull’edizione uscita domenica 26 maggio, il settimanale ilCaffè ha dedicato il suo confronto al tema dei telefonini in mano ad allievi della e nella scuola dell’obbligo. Col titolo Spegnere i telefonini in aula? I diritti e doveri non bastano, Clemente Mazzetta ha così introdotto il confronto.
 Telefonini a scuola, sì o no? Una questione che da scolastica, educativa, comportamentale, si è fatta politica. Ed è uscita dall’ambito stretto delle discussioni familiari per sbarcare in parlamento, che dovrà decidere sulla mozione presentata da tre deputati che hanno posto la questione in termini ultimativi: proibire lo smartphone nelle scuole dell’obbligo, così come si è fatto in Francia e nel Canton Vaud. Quella del divieto totale è un’ opzione che il governo reputa eccessiva, perché “proibirne [l’uso] in modo assoluto significherebbe venire meno a un indispensabile compito educativo”.
Telefonini a scuola, sì o no? Una questione che da scolastica, educativa, comportamentale, si è fatta politica. Ed è uscita dall’ambito stretto delle discussioni familiari per sbarcare in parlamento, che dovrà decidere sulla mozione presentata da tre deputati che hanno posto la questione in termini ultimativi: proibire lo smartphone nelle scuole dell’obbligo, così come si è fatto in Francia e nel Canton Vaud. Quella del divieto totale è un’ opzione che il governo reputa eccessiva, perché “proibirne [l’uso] in modo assoluto significherebbe venire meno a un indispensabile compito educativo”.
Il Dipartimento educazione, cultura e sport ha comunque fornito alcune indicazioni: ovvero che i telefonini possono essere portati a scuola, ma devono restare spenti o in “modalità aereo”. Ovvero non connessi. Va da sé che non devono essere utilizzati durante le lezioni, che possono essere ritirati se usati in modo inappropriato, e il loro uso nel corso delle uscite didattiche deve essere stabilito dalla direzione scolastica.
Il tema dei telefonini, e delle valutazioni che seguiranno, evidenziano però ancora una volta come sulla scuola vengono scaricati nuovi compiti “educativi” a base di norme e regolamenti. Si confrontano sul tema un insegnante di oggi, Daniele Dell’Agnola, e un direttore didattico di ieri, Adolfo Tomasini.
Avevo già parlato di questa iniziativa giusto due anni fa (Vietare non serve a nulla, ma è un bell’alibi quando l’adulto non sa più che pesci pigliare), quando tre parlamentari – il popolare democratico Giorgio Fonio, il socialista Henrik Bang e la liberale Maristella Polli – avevano presentato la loro interrogazione.
Ora è giunto al Parlamento il parere del Consiglio di Stato. Ecco quindi le osservazioni che abbiamo messo a confronto, ognuno non sapendo chi fosse l’altro sottoposto a confronto.
L’analisi/1 – Ma non c’è bisogno di un divieto di Stato, basta quello scolastico
di Adolfo Tomasini
Capisco che il tema delle nuove tecnologie, e in particolare l’uso degli smartphone, interroghi e coinvolga anche il mondo della scuola, che fra i suoi compiti non ha solo quello di insegnare a leggere, scrivere e far di conto, ma, prima di tutto, quello di educare. Da qui a coinvolgere il Consiglio di Stato per stilare un regolamento che proibisca agli studenti l’uso del telefonino, o di altre diavolerie elettroniche, ce ne passa.
È la questione politica in sé che mi pare strana. Essere a scuola significa costruire delle competenze disciplinari assieme ad altre persone presenti in queste piccole comunità. Non si tratta dunque di decidere se vietare o consentire lo smartphone. A scuola si va per imparare e crescere culturalmente e socialmente. Ciò che ostacola il lavoro del maestro o dell’alunno va rimosso, senza se e senza ma. Il telefonino, per restare a questo esempio, deve restare muto durante il lavoro perché intralcia l’attività, non perché è proibito.
Tocca all’insegnante richiamare all’attenzione l’alunno che si distrae, che non sta attento, che non segue. È implicito nella sua funzione: non c’è bisogno del Consiglio di Stato. Come in passato non si potevano leggere giornaletti di nascosto, non si doveva usare il bigino, non si doveva disturbare, così oggi non si deve chattare, sbirciare le risposte sul telefonino, lasciarlo squillare. Basta l’autorevolezza del docente, che è più educativa di ogni regolamento. Analogamente, a chi i vuole proibire il telefonino per evitare forme di bullismo di ogni specie, dico che o i docenti hanno l’autorevolezza per impedire qualsiasi forma di prevaricazione, fisica o psicologica, oppure non sanno fare il loro lavoro. Se due ragazzi si picchiano nell’intervallo, per dirne una, non c’è bisogno di un regolamento per chiedere che il docente interrompa la zuffa. Così se si assiste all’uso improprio di un telefonino si intervenga. Tutto lì. L’educazione a scuola non può passare attraverso una serie sempre più affollata di norme sollecitate all’autorità superiore – un modo di fare, tra l’altro, che delegittima la scuola e gli insegnanti. Passa piuttosto da un dialogo fra la scuola e la famiglia, fra i docenti e i genitori, fra i maestri e gli allievi, anche per concordare in modo pragmatico l’uso del cellulare. In questo senso condivido l’indirizzo del Consiglio di Stato, che non vuole allinearsi a nuovi regolamenti, come in Francia o nel Canton Vaud, preferendo che siano i singoli istituti a regolare come meglio credono la libertà di decidere come comportarsi e di comunicare con chiarezza i diritti e i doveri di ognuno: allievi, genitori e insegnanti.
L’analisi/2 – La scuola è chiamata a evitare gli eccessi delle nuove tecnologie
di Daniele Dell’Agnola
Non è facile né scontato prendere posizione fra il divieto assoluto agli smartphone a scuola e l’apertura ad un suo uso fra le mura scolastiche, anche se regolamentato. Sarei contrario ad una proibizione totale, come è stato deciso in Francia. Ma osservare decine di ragazzi nei cortili, fermi, incollati ad uno schermo, mette tristezza: la scuola deve restare un luogo di socializzazione, di formazione della persona e non uno spazio per un uso inconsapevole di oggetti tecnologici. Dovrebbe fare una “resistenza” intelligente all’abuso.
Le nuove tecnologie, i telefonini fanno parte della vita degli adolescenti. E, considerato che la scuola ha anche una importante finalità educativa, occorre prenderne atto, occorre farci i conti. Magari, integrandoli nell’ambito didattico, per un uso critico, ragionato, di queste nuove tecnologie. Nel contempo dobbiamo essere consapevoli che permetterne un uso senza vincoli nel contesto scolastico significa ancora una volta far ricadere sui docenti una sfida altissima a cui non tutti sono pronti e preparati. Alla norma generale del DECS sull’uso dei cellulari, bisogna affiancare la sensibilizzazione, la formazione, il dialogo. Non bastano un quadro normativo e delle regole di comportamento: occorre che gli insegnanti siano anche rassicurati. Ovviamente siamo tutti favorevoli ad un’educazione verso le nuove tecnologie, perché i ragazzi devono essere capaci di orientarsi in quest’ambito, devono riuscire a distinguere il vero dal falso, le news autorevoli e le fakes, le bufale, devono essere consapevoli di cosa significa divulgare un’informazione.
Però attenti, perché gli insegnati hanno già tanti altri compiti: devono prestare attenzione alle forme di disagio, devono curare la disciplina che insegnano, osservare gli atteggiamenti in classe, entrare in relazione con gli alunni. Gli smartphone sono entrati nella “dimensione scuola” negli ultimi dieci anni, quindi non possiamo essere pronti a improvvisare. Che fare dunque? Penso che sarebbe opportuno mettere dei limiti. Fare un po’ di “resistenza”. Pensando ad esempio ad uscite senza l’uso del cellulare. Un’esperienza anche solo di una giornata per far capire ai ragazzi che si può vivere, camminare, comunicare anche senza telefonini. Ciò non esclude una riflessione su un loro utilizzo più consapevole, anche attraverso esperienze a contatto con le tecnologie: il cellulare potrebbe entrare anche nell’aula all’interno di un percorso intelligente di sensibilizzazione all’uso. E con una formazione adeguata degli insegnanti. Ricordiamoci che con le regole si fa esperienza. E si cresce.
Qui finisce il servizio “comparativo” de ilCaffè. Sono contento di aver scoperto stamattina che il mio “avversario” di idee era Daniele Dell’Agnola, insegnante e scrittore che stimo molto.
Copia della pagina del domenicale può essere scaricata qui.


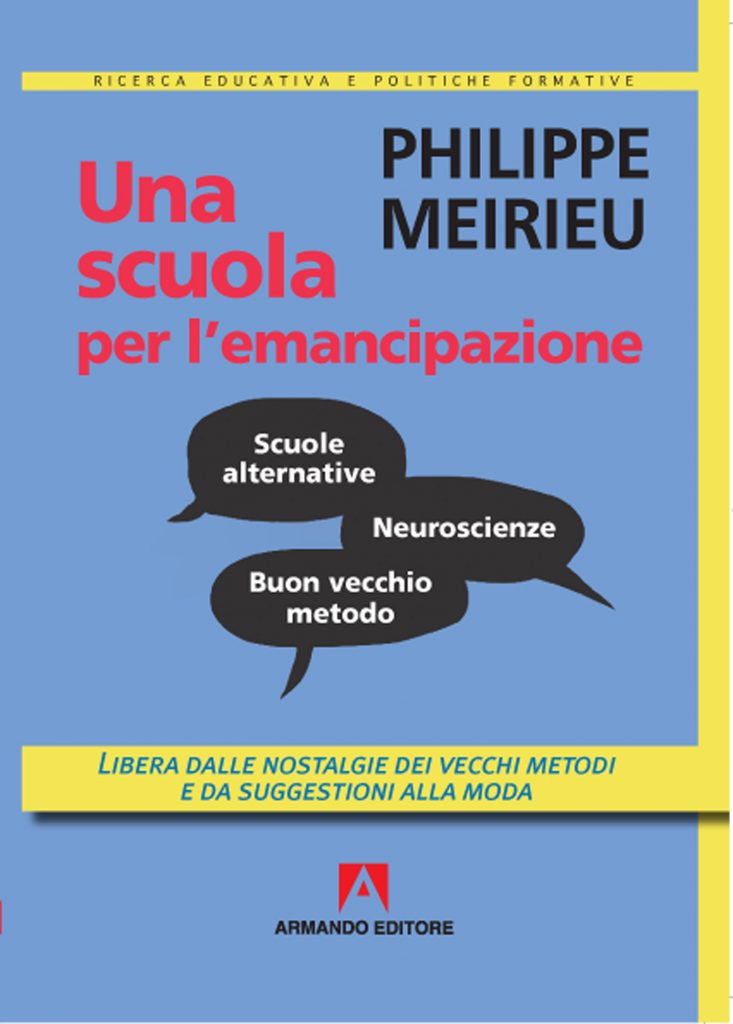
 Telefonini a scuola, sì o no? Una questione che da scolastica, educativa, comportamentale, si è fatta politica. Ed è uscita dall’ambito stretto delle discussioni familiari per sbarcare in parlamento, che dovrà decidere sulla mozione presentata da tre deputati che hanno posto la questione in termini ultimativi: proibire lo smartphone nelle scuole dell’obbligo, così come si è fatto in Francia e nel Canton Vaud. Quella del divieto totale è un’ opzione che il governo reputa eccessiva, perché “proibirne [l’uso] in modo assoluto significherebbe venire meno a un indispensabile compito educativo”.
Telefonini a scuola, sì o no? Una questione che da scolastica, educativa, comportamentale, si è fatta politica. Ed è uscita dall’ambito stretto delle discussioni familiari per sbarcare in parlamento, che dovrà decidere sulla mozione presentata da tre deputati che hanno posto la questione in termini ultimativi: proibire lo smartphone nelle scuole dell’obbligo, così come si è fatto in Francia e nel Canton Vaud. Quella del divieto totale è un’ opzione che il governo reputa eccessiva, perché “proibirne [l’uso] in modo assoluto significherebbe venire meno a un indispensabile compito educativo”.