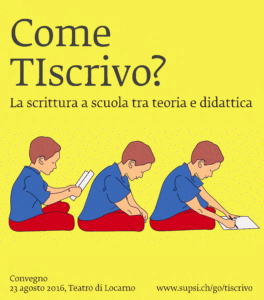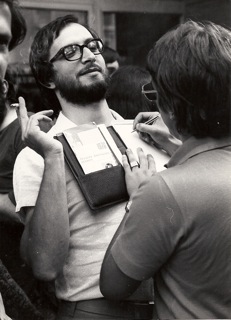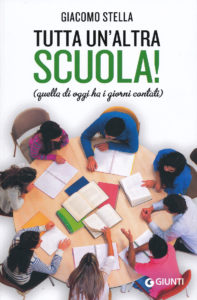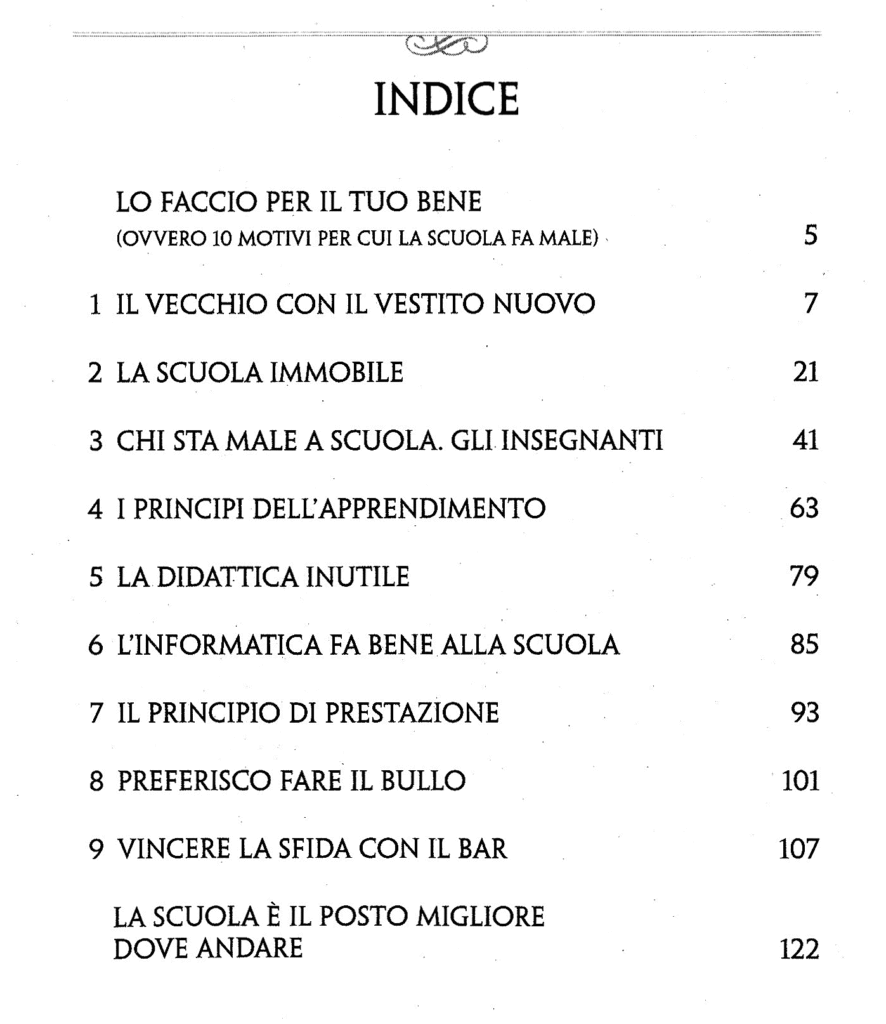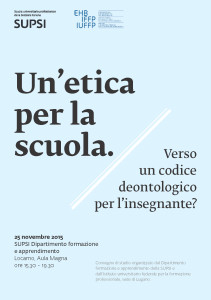Alcuni giorni fa, commentando le misure di sicurezza che hanno caratterizzato la 69ª edizione del Festival del Film di Locarno, avevo chiuso le mie brevi note con un’inquietudine (Non c’è nulla di semplice in quel che sta succedendo attorno a noi. E si rischiano le psicosi e la xenofobia al rialzo) e la speranza che, al rientro a scuola dopo le vacanze estive, nelle nostre aule ci sia chi offrirà ai suoi allievi l’opportunità di parlare della brutale attualità che distingue questi tempi e che ha affollato le cronache delle ultime settimane [Il festival del film di Locarno, l’attualità brutale e la forza educativa del dubbio].
L’edizione odierna del quotidiano francese «Le Monde» ha pubblicato un intrigante contributo di Philippe Meirieu, pedagogista e professore emerito in scienze dell’educazione all’università Lumière di Lione: «La démocratie est assignée à faire de l’éducation sa priorité». [Nel sito di Le Monde l’accesso all’articolo è protetto; lo si può tuttavia recuperare integralmente nel sito di Philippe Meirieu, oppure lo si può scaricare qui].
Meirieu inizia con un amaro riscontro: «I riti commerciali e i cliché mediatici che segnano tradizionalmente l’apertura di un nuovo anno scolastico rischiano, quest’anno, di sembrare particolarmente sfasati. In effetti non potremo fare a meno di una riflessione educativa sugli attentati dell’estate e sulla situazione del nostro paese».
Sono naturalmente d’accordo, perché invece, nel nostro di un paese, c’è una buona possibilità che si parli solo di HarmoS e dei nuovi piani di studio, quasi che non ci trovassimo al crocevia non solo geografico dell’Europa, e che alle nostre frontiere e nei nostri centri di accoglienza non fossero palpabili le tensioni alle quali non possiamo sfuggire: perché sinora non siamo stati al centro di attacchi terroristici, ma una giovane donna di Agno è comunque morta a Nizza, senza dimenticare i tre giovani ticinesi vittime di un attentato a Marrakech nell’aprile del 2011.
Ma forse c’è poco da fare, perché ci piace crogiolarci nel nostro essere un Sonderfall, almeno quando ci fa comodo.
Meirieu prosegue sulla necessità che nelle scuole, da settimana prossima, sia possibile «ascoltare le inquietudini e gli interrogativi degli allievi, permettere di esprimere a parole le loro domande, di confrontarsi serenamente, tra loro e con gli adulti: a questo scopo bisognerà realizzare dei rituali che permettano la nascita di parole rincuoranti, senza esitare a passare attraverso l’espressione scritta o grafica individuale, a servirsi della mediazione di una poesia o di un romanzo, a prendere esempi dalla storia (…). A sollecitare l’immaginazione degli allievi chiedendo loro di descrivere in che modo ognuno di loro e tutti insieme possono contribuire a far indietreggiare la barbarie».
A ben vedere c’è, in queste riflessioni per il rientro in aula dopo un’estate speciale, la visione di una scuola che persegue fino in fondo la sua capacità di educare i cittadini, ben oltre le tante spendibilità immediate e gli orpelli tecnocratici che stanno tramutando l’Istituzione scolastica in un volgare supermercato.

È davvero tutto da leggere, questo contributo di Philippe Meirieu, che invita la Scuola a «diventare deliberatamente uno spazio di decelerazione. Lungi dal premiare la risposta immediata, essa deve promuovere la riflessone critica. Deve imporre la distanza dalla pulsione e il distacco dalla reazione immediata, per sfruttare questo tempo per anticipare, scambiare, documentarsi, riflettere… in breve, per imparare a pensare. Ne siamo lontani, noi che corriamo sempre nei corridoi e talloniamo i programmi, che fuggiamo il silenzio come la peste, che correggiamo un compito per sempre, senza lasciare all’allievo la possibilità di approfittare dei nostri consigli per migliorare. Di fronte all’immediatezza del “tutto e subito” promosso sistematicamente dal macchinario pubblicitario e tecnologico, la Scuola deve svolgere intenzionalmente un ruolo termostatico. Né rifiuto brutale della reazione dell’allievo, né consenso demagogico della sua opinione: “Prendiamoci il tempo per pensarci”. È solo così che la Scuola contribuirà a insegnare a ragazzi e adolescenti a resistere a ogni sorta di seduzione».