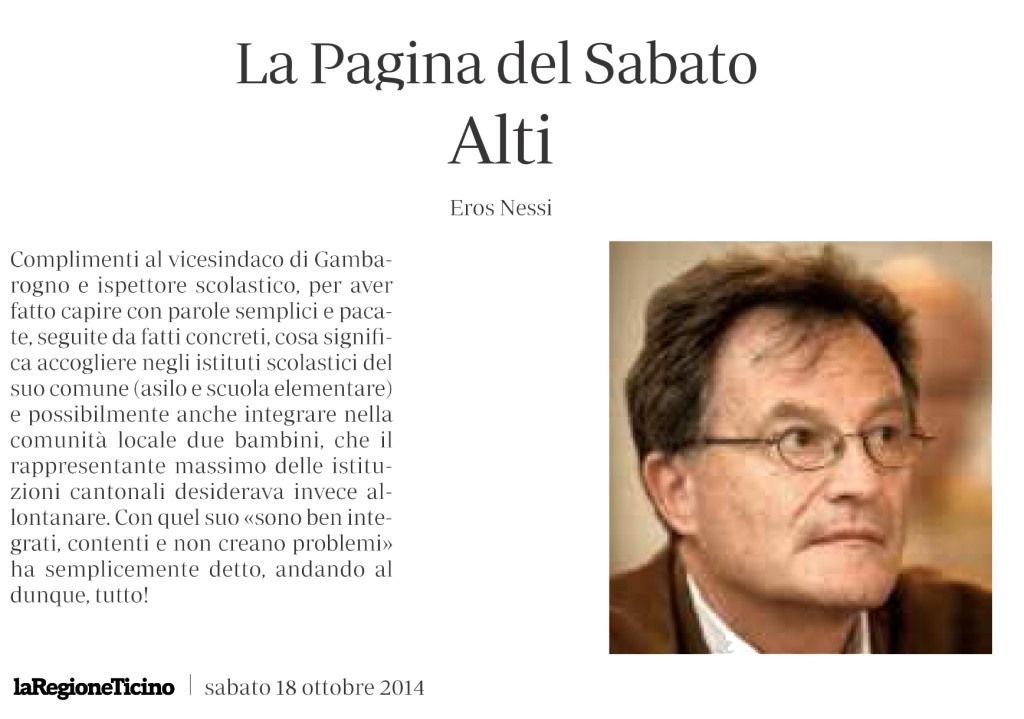Ripropongo oggi, con minuscole modifiche, un articolo che era uscito sul «Corriere del Ticino», nella mia rubrica Fuori dall’aula, il 7 novembre 2001, col titolo (redazionale) Se Halloween sostituisce il giorno dei morti.
Malgrado siano trascorsi tredici anni, mi pare che il contenuto mantenga il suo senso.
Credo che in tante aule scolastiche ci si ritaglino gli spazi, ipocriti e smaccatamente venali, per officiare Natale e carnevale, la festa della mamma e quella del papà. Magari, poi, si chiude un occhio sulla «Giornata della memoria», e ci si volta dall’altra parte in prossimità del giorno dei Morti. Perché in fondo a chi può mai interessare il passato? A che serve?
La scorsa settimana l’aula era chiusa, e siamo rimasti tutti fuori. C’erano le vacanze autunnali (detto dai laici), quelle dei Morti per i cattolici. Finché Ognissanti e il Giorno dei Morti son rimaste giornate del ricordo – giornate vissute – le aule non si chiudevano, non almeno per una settimana di fila. È solo da poco più di vent’anni che si lasciano a casa allievi e studenti a inizio novembre, per un calcolo molto fiscale d’adattamento del nuovo calendario alle esigenze del mercato. In altre parole: è dal 1978 che l’anno scolastico attacca a inizio settembre (e non più il 15), per guadagnare il sabato libero e permettere a insegnanti e discenti di sciamare liberamente, il sabato mattina, nelle tante biblioteche pubbliche a disposizione.
Oggi dei santi non è rimasto più nulla – neanche qualche brandello. Figuriamoci dei morti. Quello era l’unico rito che i bambini sapevano vivere sul filo delle radici, senza regali e senza festa: la camminata al cimitero dei padri si ricollegava tutto sommato alla consapevolezza della morte, e manteneva fresco un sentimento d’appartenenza a una famiglia, a un paese, a una nazione, a una cultura. Sembrava quasi di esistere ed essere importanti per questo.
Ora è Halloween. Dolcetto o scherzetto. Con una banalità, si sarebbe tentati di dire che si tratta dell’ennesimo cedimento all’imperialismo culturale made in U. S. A., come la Coca Cola. Invece non è propriamente così, anche se occorre pur riconoscere il peso risoluto dell’azione dei vari bottegai, che pur di vendere hanno importato anche questa, dopo la festa della mamma, quella degli innamorati, la festa della donna, quella del papà e via elencando. Ma il meccanismo di Halloween è gentilmente più sottile, poiché sostituisce la ricorrenza del giorno dei Morti – i propri morti – con gli estinti hollywoodiani: che ha a che fare mia nonna con le zucche intagliate e illuminate? E il bisnonno? Quali legami si possono scovare tra il lontano e mai conosciuto cugino, morto nel ’51 a soli tre anni, e gli impiccati e le streghe dei party (si chiamano così, of course) andati in onda in questo Ticino tra l’inizio e la fine di queste appena trascorse vacanze?
Dato che questa rubrica si perita di parlare di problemi educativi, a questo punto il lettore potrà chiedersi legittimamente cosa c’entrano Halloween e il giorno dei Morti con la scuola e i suoi scopi; e invece c’entrano, perché anche la scuola, non sapendo più, da almeno un trentennio, che pesci pigliare, si è messa, più o meno inconsapevolmente, a fare da cassa di risonanza a tutte queste baggianate. Dopo il docente che, beato lui, strutturava il programma di matematica sui Pokémon – visto alla TSI –, si potrebbe proporre alle sedi di scuola media di organizzare, l’ultimo giorno prima delle vacanze, qualche party in onore del dio halloween.
È inutile fare il solito predicozzo alle giovani generazioni: proprio perché non ho più vent’anni, mi mancano le occasioni di ritrovo con il mio gruppo, ma non ho più l’età per inventarne di nuove. L’importazione di Halloween in Europa non è certo una scelta dei sedicenni della Valle di Muggio; è invece la generazione dei loro padri che, a furia di politically correct, ha finito con immolarsi sull’altare del conformismo più torvo, aderendo in tutto e per tutto a quella che Ostellino, proprio sulle pagine di questo giornale, ha chiamato la filosofia del «né né»: né al cimitero il 2 novembre (con l’essenziale seguito di caldarroste all’osteria), né per le strade vestiti da scheletri (e poi tutti a ballare); né il comunismo, né il capitalismo; né il femminismo, né il maschilismo. Né né. Come dicevo in un precedente intervento: penso per me, mi occupo di me…
E la scuola? Che fa, dimmi, che fa? Il Maestro un po’ attempato – che da allievo leggeva anche lui il «Marco» di Bertolini e si esaltava ai racconti sulla Patria e sul servizio militare, e che nei ’70, divenuto insegnante di scuola elementare, faceva le ricerche sui partigiani – oggi ha aderito anche lui alla dottrina del «né né»: non è più di moda far politica a scuola, soprattutto da quando si è scoperto che chi a otto anni faceva le ricerche sui partigiani, oggi vota come minimo per Berlusconi. Il «né né», di conseguenza, rischia di confondersi sempre più con la nana dei francesi.
Ma che si vuole? Anche l’11 settembre, ormai, fa parte del passato. Come l’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria.