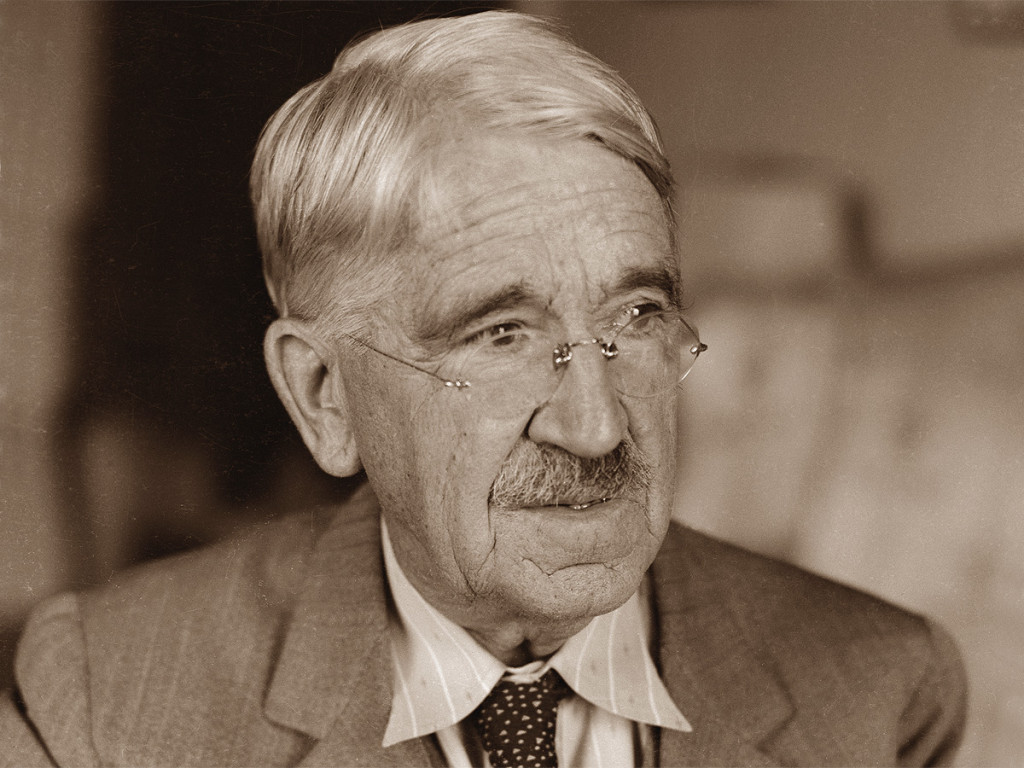Mi è capitato di incappare due volte di fila in conversazioni sull’insuccesso. Andrea Fazioli, l’autore del bel romanzo L’arte del fallimento, edito da Guanda, ha un blog che presenta regolarmente delle riflessioni sempre molto argute. A fine aprile ha proposto ai suoi lettori alcune considerazioni sul tema del fallimento e ha richiamato un altro pezzo pubblicato nel sito «Il Libraio», intitolato Sette lezioni di fallimento, ispirate da altrettanti autori: come fallire in maniera grandiosa; come accettare il fallimento; come rialzarsi dopo i fallimenti; come fare del fallimento un’arte; come fallire un’indagine; come trasformare il fallimento in eroismo; come ridere del fallimento. Per finire Fazioli ha aggiunto un’ottava lezione, ispirata a Butcher’s Crossing, romanzo dello scrittore statunitense John E. Williams.
Passano un paio di giorni ed ecco, sul Corriere della sera, un bel pezzo di Paolo Di Stefano, Il prof di Princeton pubblica il curriculum dei suoi migliori flop (se non si riesce ad accedere al corriere.it si trova l’articolo qui). Si parte dallo strillo di autore anonimo, che sarà svelato a fine articolo: «Il successo è il solo metro di giudizio di ciò che è buono o cattivo». Poi si passa a una frase di James Joyce, «il grande scrittore irlandese che non si preoccupò certo di essere letto da un gran numero di persone, visto che scrisse uno dei romanzi più ostici della letteratura, Ulisse, per non parlare di Finnegans Wake, esempio massimo di libro intraducibile». Il professor McHugh, personaggio joyciano, sentenziò: «Fummo sempre fedeli alle cause perse: il successo per noi è la morte dell’intelletto e della fantasia».
Ecco allora che Di Stefano racconta del professor Johannes Haushofer, un prof reale, stavolta, docente di psicologia e neurobiologia alla prestigiosa università di Princeton, già ricercatore a Oxford, a Harvard e a Zurigo: che ha narrato su Twitter il curriculum vitae dei suoi fallimenti.
 Ho già detto troppo: i due interventi, quello di Andrea Fazioli e quell’altro di Paolo Di Stefano, meritano di essere letti, senza altre mediazioni pericolosamente di parte. Per certi versi ricordano il famoso Sbagliando s’impara, nonché le storielle di Giuseppe Verdi, scartato dal conservatorio milanese che avrebbe poi preso il suo nome, o di Albert Einstein, rifiutato dal politecnico di Zurigo perché non riuscì a superare gli esami di ammissione.
Ho già detto troppo: i due interventi, quello di Andrea Fazioli e quell’altro di Paolo Di Stefano, meritano di essere letti, senza altre mediazioni pericolosamente di parte. Per certi versi ricordano il famoso Sbagliando s’impara, nonché le storielle di Giuseppe Verdi, scartato dal conservatorio milanese che avrebbe poi preso il suo nome, o di Albert Einstein, rifiutato dal politecnico di Zurigo perché non riuscì a superare gli esami di ammissione.
Le valutazioni e gli esami incessanti sono bestiacce. Come diceva Don Lorenzo Milani «Bocciare è come sparare in un cespuglio. Forse era un ragazzo, forse una lepre. Si vedrà a comodo». E aggiungeva: «La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde». In effetti la scuola, quella dell’obbligo e quella che segue subito dopo, è campione nel dividere i bianchi dai neri, il loglio dal grano, la lumaca dal ghepardo. Tanto per fare un esempio che non invecchierà mai, non è chiaro perché un bambino debba imparare a leggere e scrivere secondo l’età decretata dalla scienza statistica, così che se fai parte di quel 15% di statisticamente immaturi – immaturi al momento della valutazione – rischi il pollice verso: bocciato!
La storia delle pari opportunità andava bene giusto giusto 48 anni fa. Oggi è grottesco che quell’enunciato, che certo funzionava in quegli anni, sia cavalcato da chi le pari opportunità le osteggiò più che poté e da chi, invece, ne fece uno slogan senza aver capito bene di cosa si stesse parlando. Pari opportunità, mezzo secolo dopo, significa anche opporsi con fermezza all’inveterata indifferenza alle differenze.
 Ai nostri giorni, sciaguratamente, è molto di moda il pensiero riferito da Di Stefano come incipit del suo articolo. Che osserva: Potrebbe essere il motto di un dirigente marketing dei nostri giorni.
Ai nostri giorni, sciaguratamente, è molto di moda il pensiero riferito da Di Stefano come incipit del suo articolo. Che osserva: Potrebbe essere il motto di un dirigente marketing dei nostri giorni.
Mi vien da completare: un uomo qualunque, un politico di destra di sinistra o di centro, un insegnante, un dirigente scolastico o un sindacalista. Invece, sapete chi l’ha scritto?, ha chiesto Di Stefano in conclusione.
Chi è d’accordo con l’enunciato, soprattutto se poi scrive proclami, rilascia dichiarazioni ai massmedia e/o inoltra atti parlamentari per raddrizzare la scuola, vada a scoprire chi ne è l’autore.