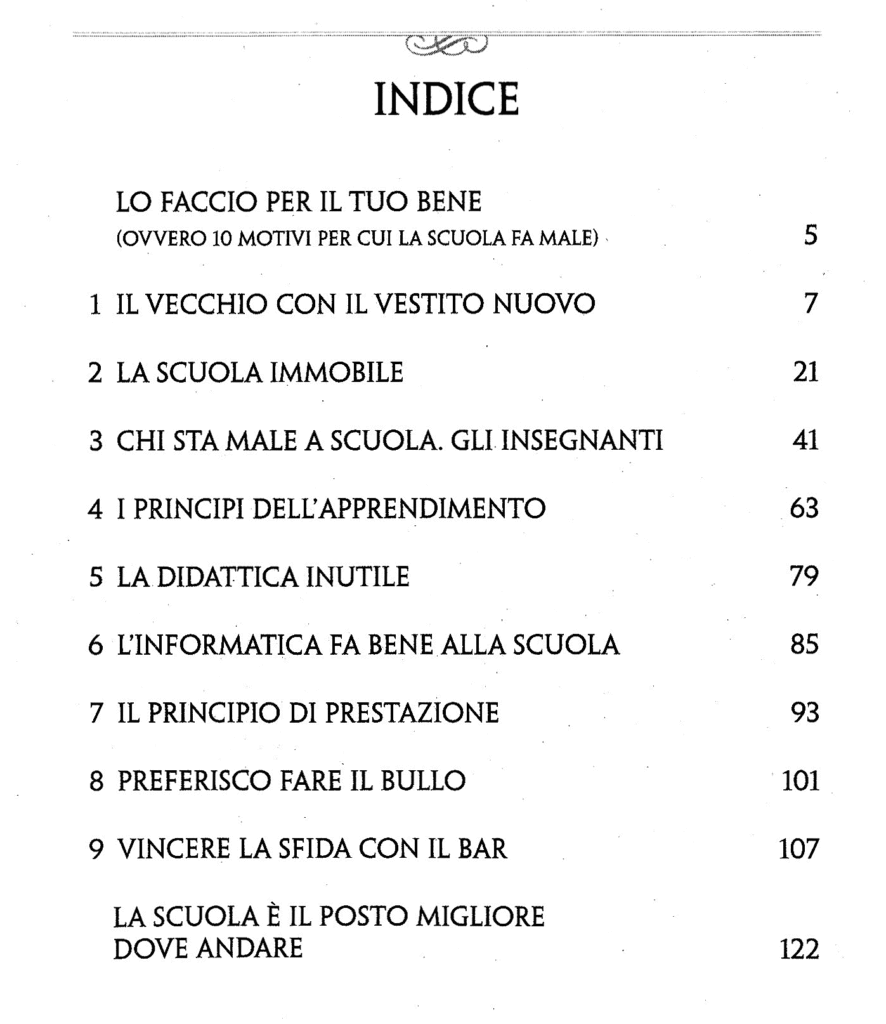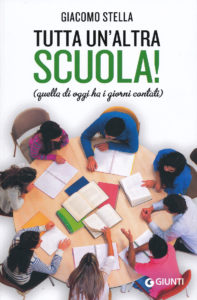 Nel mese di luglio il Corriere del Ticino ha dedicato quattro pagine ad alcune segnalazioni librarie da parte delle sue firme (le quattro puntate sono apparse il 7, il 12, il 14 e il 28 luglio). Ho avuto il piacere di poter proporre anch’io un libro, e – pensa te! – ho scelto un argomento scolastico: Tutta un’altra scuola! (quella di oggi ha i giorni contati) di GIACOMO STELLA (2016, Giunti Editore, p. 128, € 10).
Nel mese di luglio il Corriere del Ticino ha dedicato quattro pagine ad alcune segnalazioni librarie da parte delle sue firme (le quattro puntate sono apparse il 7, il 12, il 14 e il 28 luglio). Ho avuto il piacere di poter proporre anch’io un libro, e – pensa te! – ho scelto un argomento scolastico: Tutta un’altra scuola! (quella di oggi ha i giorni contati) di GIACOMO STELLA (2016, Giunti Editore, p. 128, € 10).
Che la scuola di oggi abbia i giorni contati non è ovviamente un dato certo. Ma questo pamphlet è una lettura assai tonica per tutti quelli che soffrono mal di pancia infiniti a contatto con «l’esperienza più importante della nostra vita»: una scuola vecchia con il vestito nuovo. Detto dei «10 motivi per cui la scuola fa male», l’autore spiega come e perché la scuola potrebbe essere un posto dove la paura non esiste, un luogo da cui guardare il mondo dei grandi non per distruggerlo, ma per cambiarlo. Tutto lì.
Trovo utile che sui temi della scuola, la scuola come istituzione, siano pubblicati di tanto in tanto libri per il grande pubblico, fuori da quel grande terreno troppo spesso recintato col filo spinato solitamente gestito dagli addetti ai lavori. Un esempio di due anni fa (che peraltro non mi aveva granché elettrizzato, malgrado il successo editoriale…) è L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, di Massimo Recalcati (2014, Einaudi).
Giacomo Stella è conosciuto in Italia e in Europa per i suoi studi sulla dislessia e, in genere, sui disturbi specifici di apprendimento. Ed è proprio osservando a scuola tanti allievi in difficoltà che è nata la sua riflessione, riassunta nel titolo di uno dei primi capitoli: «La cosa più grave che si può fare a scuola è sbagliare». Appunto.
Eccoli qua, allora, i «10 motivi per cui la scuola fa male (lo faccio per il tuo bene)»:
- Non riesci a imparare le tabelline? Devi ripassarle tutti i giorni e fare i calcoli senza la tavola pitagorica. Devi sforzarti, altrimenti non imparerai mai. È per il tuo bene!
- Sottolinea tutti i miei errori di ortografia in rosso. Ogni pagina sembra un campo di battaglia. «Correggi tutto e ricopia in bella grafia. È per il tuo bene!».
- Devi scrivere in corsivo. Mi rifiuto di leggere i tuoi temi se sono scritti in stampato, eppoi alle medie non si può scrivere in stampatello. Usare il computer? Troppo comodo ragazzo mio, bisogna esercitarsi per ottenere risultati. Lo dico per il tuo bene.
- Alle prove di verifica ho sempre tutto il compito come gli altri: fotocopie che non riesco a leggere con parti da completare. Se non riesco a finire la maestra mi fa stare in classe durante la ricreazione per terminare. Gli altri giocano e io scrivo. Perché? «Per il tuo bene!»
- L’inglese non lo capisco per niente. Le lettere non si leggono mai allo stesso modo. L’insegnante però dice che devo studiare perché l’inglese è importante eppoi lei non può fare differenze con gli altri. L’inglese è una lingua indispensabile per comunicare. Ma allora, se serve per comunicare, perché non posso impararlo solo all’orale? «È per il tuo bene!».
- Non hai risposto con sicurezza all’interrogazione, come al solito non hai studiato abbastanza. Eppoi mi chiedi di essere comprensiva con te, per le tue difficoltà. Cosa dovrei fare? Darti la sufficienza? No, non posso farlo, debbo darti un voto insufficiente, così la prossima volta studierai di più. Lo faccio per te, per il tuo bene!
- Non riesco a ricordare a memoria i verbi ma la prof dice che me li chiederà tutti i giorni. Lo fa per il mio bene.
- Ho ricevuto una nota perché non prendo appunti durante le lezioni. lo non riesco a scrivere e ascoltare. Ho chiesto di registrare la lezione, ma mi hanno detto che non si può, per la privacy.
- Leggere ad alta voce davanti a tutti, incespicandomi a ogni parola con il sottofondo delle risatine dei miei compagni. Perché? «Per il tuo bene».
- Non amo la scuola, detesto gli insegnanti e quando i miei genitori mi dicono di studiare mi chiudo in camera mia e ascolto la musica. Lo faccio per il mio bene.
Non si tratta, a ben vedere, di pratiche scolastiche che nuocciono solo a bambini e ragazzi affetti da disturbi particolari, ad esempio di natura neurologica. Sappiamo invece, e lo vediamo giornalmente, che tante abitudini così presenti tra le quattro mura dell’aula arrivano a produrre disagio e insuccesso scolastico per le cause più diverse, dalla plus-dotazione intellettuale alle differenze socio-culturali, passando naturalmente per tante tipologie di disturbi specifici dell’apprendimento.
Che poi la scuola di oggi abbia i giorni contati è ancor tutto da vedere. Come ho scritto più volte in queste Cose di scuola, bisognerebbe avere il coraggio intellettuale e politico di andare a toccare le strutture portanti della scuola stessa, che appare obsoleta a diversi livelli malgrado i continui cambiamenti interni, le riforme, le trasformazioni delle didattiche… Ma, ad esempio, non si è ancora in grado – in particolare nella scuola dell’obbligo – di superare il vetusto e iniquo dispositivo delle valutazioni reiterate, dei voti più o meno inappellabili, delle differenze enigmatiche tra un 4½ e un 5.
La lettura di questo Tutta un’altra scuola! è piacevole, disseminata di esempi riconoscibili da chiunque, senza far capo a tecnicismi utili solo a confondere le acque. E tra un tema e l’altro, sempre presi dalla quotidianità, Stella ci conduce per mano dal decalogo introduttivo a un dodecalogo di speranze, per descrivere tutta un’altra scuola, una scuola che è il posto migliore dove andare.
- Perché imparare è eccitante e farlo con i miei amici è bellissimo.
- Perché i docenti sono sempre disponibili e sorridenti. Puoi chiedergli qualunque cosa, non gli dai fastidio, si può anche scherzare con loro.
- Perché posso dire sempre quello che penso ed essere ascoltato dagli altri. Il docente difende la mia idea come quella di tutti gli altri.
- Perché le mie idee contano, sono importanti e ho imparato ad ascoltare anche quelle degli altri.
- Perché a scuola trovo sempre gli strumenti migliori e si possono vedere e provare sempre le ultime novità.
- Perché è un posto dove posso stare quanto voglio e trovare sempre qualcuno che mi ascolta e mi dà nuove idee.
- Perché è un posto dove posso scegliere di fare cose diverse: musica, cinema, teatro, sport.
- Perché non mi sento mai uno stupido, non ho più paura di sbagliare, sento che quello che faccio è sempre qualcosa di utile.
- Perché sto meglio a scuola che a casa da solo e non sempre i miei mi ascoltano.
- Perché rispettare le regole non ci pesa. Valgono per tutti e quindi siamo tutti uguali.
- Perché siamo tutti belli e brutti, bravi e un po’ stupidi, capaci e incapaci, ma stiamo bene insieme.
- Perché la mia scuola è un posto dove la paura non esiste. Siamo tutti insieme, stiamo bene e ci sentiamo sicuri. Guardiamo il mondo da lì, guardiamo il mondo dei grandi, non vogliamo distruggerlo, vogliamo cambiarlo.