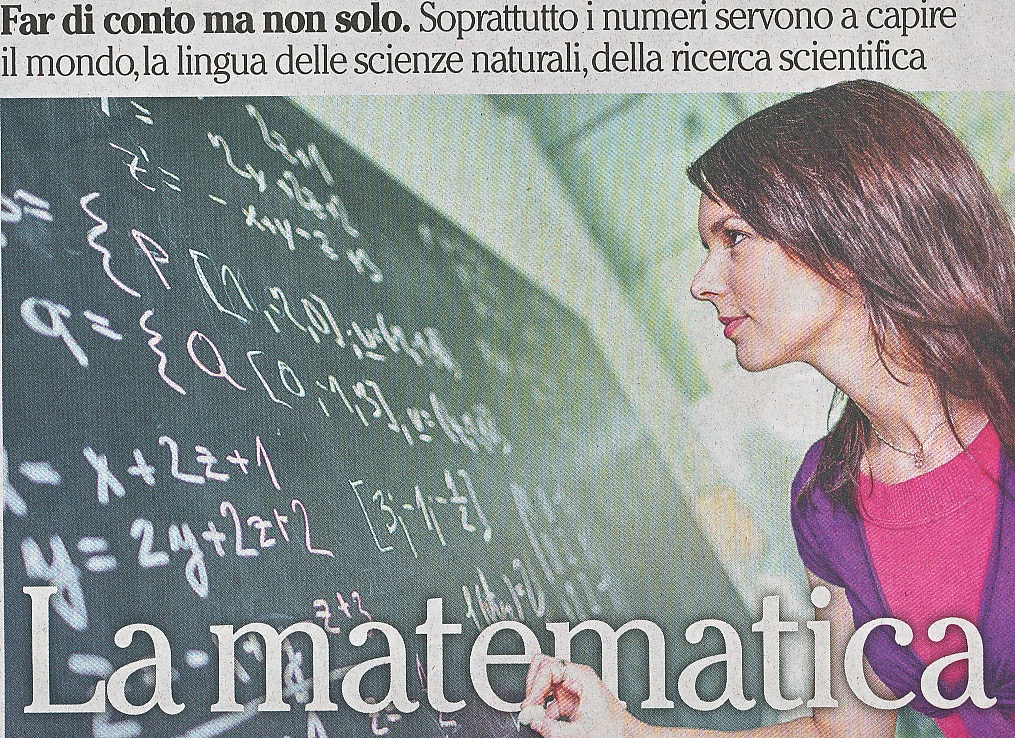Ricordiamo bene l’impatto violento che la pandemia, in primavera, aveva avuto anche sulla scuola. L’inattesa calamità aveva messo in luce il valore della presenza di allievi e docenti negli spazi scolastici, ricordandoci la centralità educativa della convivenza e della comunicazione, un’essenza che supera la capacità di raggiungere gli obiettivi dettati dai programmi. A chi vagheggia una selezione sempre più precoce, conviene chiarire che la scuola dell’obbligo non ha tra i suoi tanti e difficili compiti quello di preparare gli allievi alla scuola che «viene dopo», attraverso una gerarchia che dalle scuole di maturità scende fino al certificato di formazione pratica.
Il nostro ministro dell’educazione, intervenuto proprio una settimana fa su queste pagine, a proposito di scuola dell’obbligo ha scritto che servono dei provvedimenti «che migliorino la personalizzazione dell’insegnamento e le possibilità per i docenti di differenziarlo in base alle diverse capacità degli allievi». Non si può fingere che le differenze prodotte dall’origine sociale, economica e culturale, dalla lingua, dalla religione e dalla propria storia siano solo fatalità.
Fin qui i tentativi per mirare a condizioni migliori per differenziare l’insegnamento ruotano attorno alla diminuzione del numero di allievi per classe e alla presenza di figure specializzate. A seconda del bisogno, nelle aule della scuola obbligatoria si possono incontrare i docenti di appoggio, di sostegno pedagogico e di lingua e integrazione degli alloglotti, oltre a logopedisti, psicomotricisti, specialisti per la gestione dei casi difficili e operatrici pedagogiche per l’integrazione.
Permane, sullo sfondo, la solitudine del docente, che è il vero regista di ciò che succede nella sua aula. È piuttosto difficile capire i motivi che conducono la maggior parte dei sistemi scolastici a puntare tutto sul deus ex machina. Oggi non si parla più di vocazione, come s’usava in altri tempi, anche se la figura del maestro di scuola elementare o del professore della media ricordano per tanti versi i preti che, per primi, si occuparono dell’istruzione di bambini e ragazzi.
Forse bisognerebbe cominciare a pensare a una diversa organizzazione dell’insegnamento obbligatorio; per esempio l’insegnamento in équipe, vale a dire un gruppo di insegnanti che gestisce in comune l’equivalente di un numero di allievi che, normalmente, sarebbero ripartiti in due, tre o più classi. Lavorare insieme – come già succede in molti altri ambiti – offre alternative interessanti per gli insegnanti stessi, che potrebbero sviluppare dinamiche generatrici di successo educativo: nella relazione coi loro allievi e con le famiglie, e con originali possibilità di elaborazione e di sperimentazione della didattica e della valutazione.
Insegnare in équipe non è una soluzione magica; laddove è già una realtà segue logiche diverse l’una dall’altra. Ma ha l’indubbio pregio di mettere insieme docenti con bravure diverse, affinché la qualità del gruppo sia maggiore della somma delle capacità individuali. Lavorare con colleghi che hanno capacità, esperienze e passioni eterogenee diversifica i contributi, ma non toglie nulla ai singoli.
Eppure è un’impostazione di cui non parla nessuno. È legittimo sperare che prima o poi l’istituto che forma, abilita e aggiorna i nostri insegnanti cominci a guardare oltre la famosa siepe cantata dal poeta, per tornare a essere un luogo di riflessione e di stimolo anche al di là dei contenuti, delle didattiche e delle tecnologie.