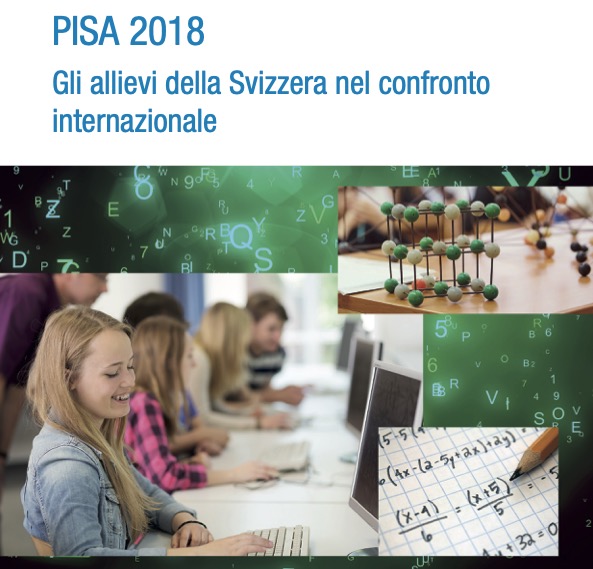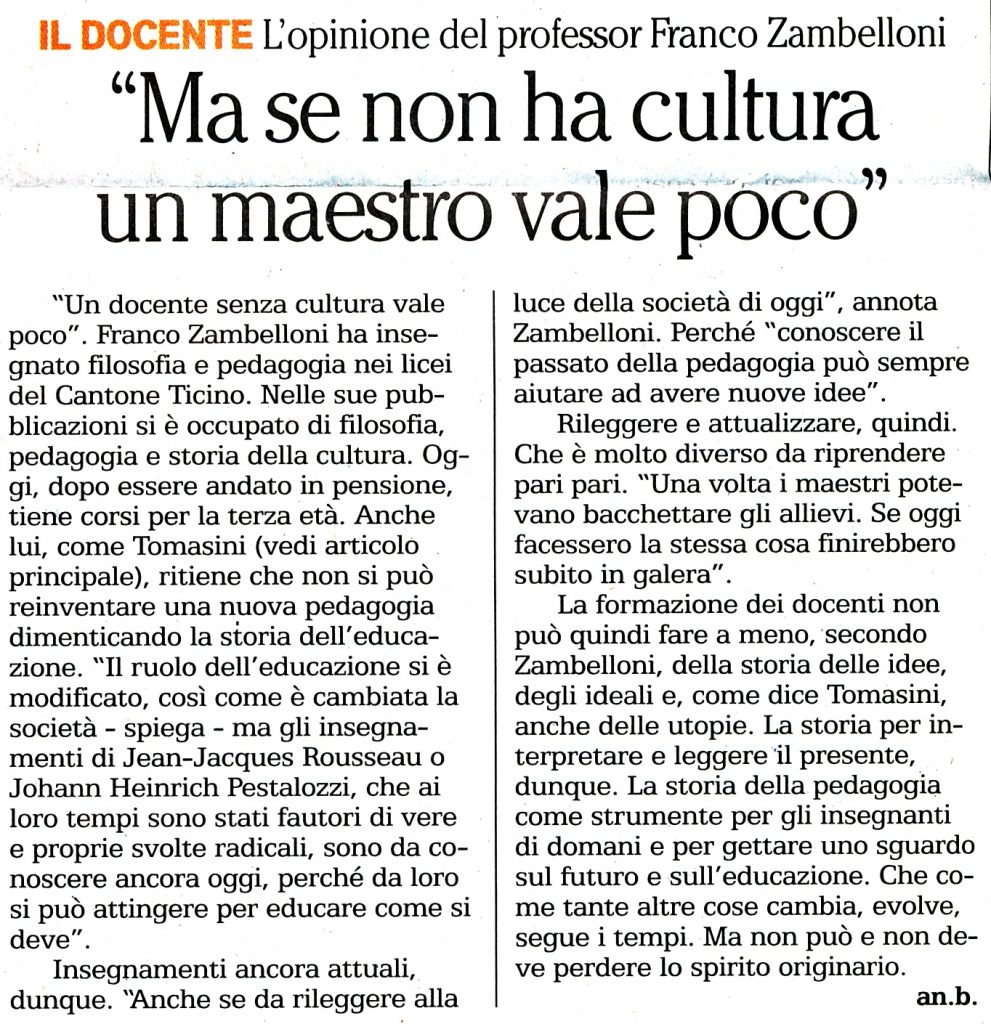Ormai siamo alla frutta, pur avendo saltato diverse portate. Così è arrivato il momento di chiudere con la domanda delle domande: ma che scuola è la scuola dell’obbligo ticinese, quella che termina con la licenza di scuola media (anche se non a tutti va bene)? Dipende dai punti di vista.
Nei confronti internazionali la scuola ticinese esce sempre con buoni voti. Prendiamo PISA, che è la verifica più conosciuta e che ogni tre anni valuta in tre ambiti – lettura, matematica e scienze – il livello dei quindicenni di una sessantina di paesi industrializzati. Da noi le analisi si concentrano su paesi simili al nostro: i paesi confinanti, alcuni paesi bilingui (tra cui il Canada) e la Finlandia, che sin dalle prime indagini PISA ha ottenuto risultati tra i migliori del mondo. Per contro, non avrebbe un gran senso il confronto con paesi culturalmente diversissimi.
Se guardiamo i punteggi ottenuti nell’ultimo rilevamento (2018) vediamo che la scuola svizzera è risultata, in media, tra le migliori di questo gruppo e che quella ticinese è tra le migliori in Svizzera. Ma le medie, come si sa, descrivono alcune cose e ne tralasciano altre. In tutti i paesi scolarizzati ci sono i primi della classe, in proporzioni diverse. Ma dall’altra parte della classifica ci sono quelli così tanto lontani dalla media da risultare del tutto incompetenti nei tre settori considerati. In Svizzera sono circa uno su dieci.
Diceva don Milani che «la scuola ha un problema solo, i ragazzi che perde». Non siamo più negli anni ’50 dell’Italia rurale – non lo siamo più da un pezzo – eppure, ancor oggi, c’è un numero importante di ragazzi che a venticinque anni non ha in mano lo straccio di un diploma: tanto che il cantone Ticino ha istituito la norma che mira ad assicurare che tutti i giovani residenti, dopo la scuola obbligatoria e fino alla maggiore età, siano seguiti e accompagnati in un progetto individuale di formazione che permetta loro di ottenere un diploma – ad esempio un certificato di formazione professionale. È difficile pensare che, tra gli allievi malmessi già alla fine della scuola obbligatoria, non vi siano quelli che si erano già persi prima, e che continueranno a brancolare senza un orizzonte.
I confronti internazionali servono anche a mettere in luce queste difficoltà dei sistemi formativi, benché di solito si tenda a mettere sotto i riflettori i cannonieri, le partite vinte e il posto in classifica. Il paese ha bisogno anche dei suoi campioni, ma il compito della scuola dell’obbligo è un altro. Sono convinto che per mirare all’educazione di futuri cittadini consapevoli, critici e liberi serva in primo luogo un ambiente sereno, che accolga e accompagni tutti. Il numero dei «fuori classifica», sommato a quello dei «minimo per la sufficienza», non fornisce grandi garanzie di cooperazione e di crescita. La competizione per stare a galla assorbe troppe energie preziose.
Non so in cielo, ma a scuola non è vero che gli ultimi sono beati, anzi. D’accordo, non siamo al punto di quegli stati dove la competitività scolastica esasperata ti porta a buttarti giù da un ponte se boccheggi o fallisci. Ma forse sarebbe utile sostenere con maggiore convinzione quelle discipline, che già fanno parte dei piani di studio, come la storia, la geografia e le arti – senza scordare la filosofia – che contribuirebbero a un’educazione civica più viva e sensata.
Insomma, proprio per chiuderla qui: «La scuola potrebbe fare di più!», per usare un’espressione che le è tanto cara.
Qualche nota, oltre l’articolo
In occasione di tutti i miei articoli pubblicati sul Caffè a partire dal 1° novembre, il giornalista Andrea Bertagni ha curato le Analisi di tanti operatori della scuola ticinese sui temi che avevo proposto. È stato certamente un lavoro non facile, anche perché i tempi sono sempre stati molto stretti. Lo voglio ringraziare per questo lavoro prezioso. Non ho mai messo il naso nelle sue scelte, solo in pochi casi posso dire che conoscessi la persona invitata a parlare dei «miei» temi. Questa è l’ultima Analisi pubblicata, un colloquio con la maestra Raffaella Moresi, che, appunto, non conosco.
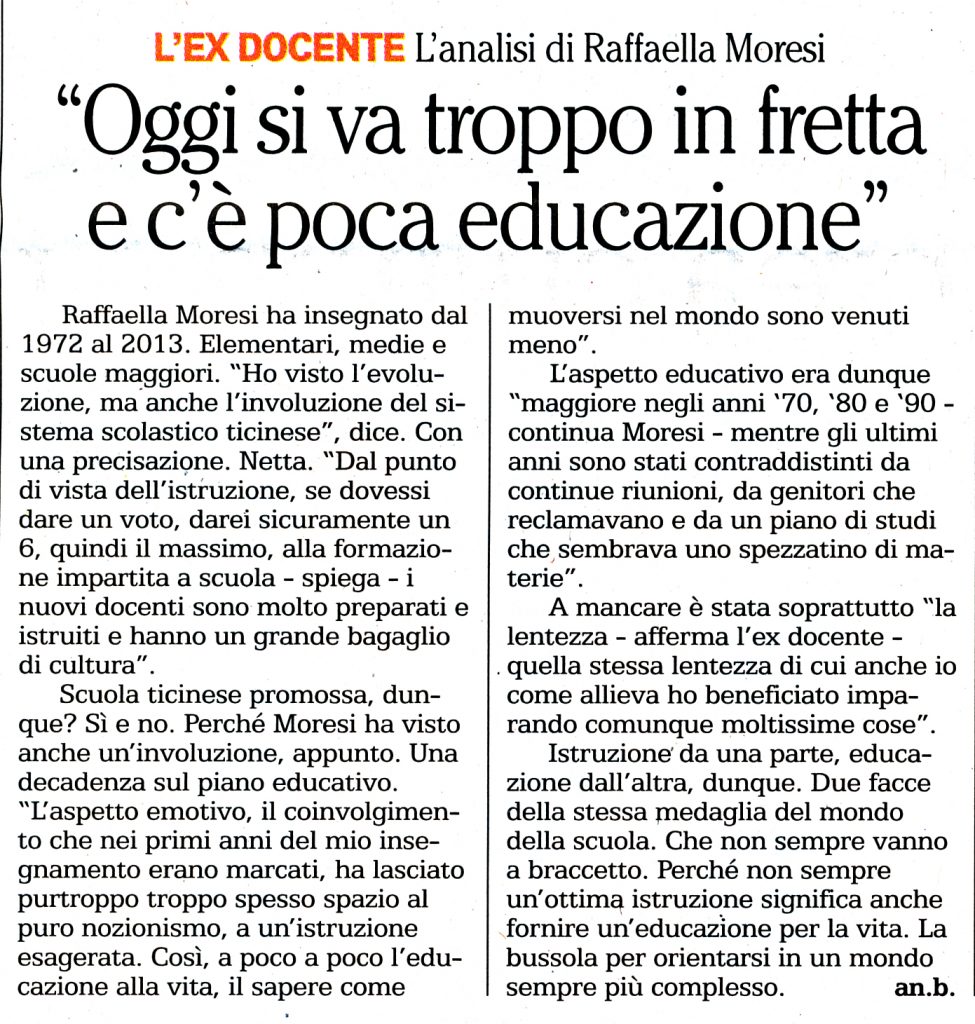
Oggi il Caffè è uscito per l’ultima volta. Ha scritto in prima pagina il suo direttore Lillo Alaimo:
GRAZIE. Questa è l’ultima edizione del Caffè, nato 28 anni fa come quindicinale e 23 anni fa diventato settimanale. Un grazie particolare va ai lettori che in questi anni ci hanno premiati. Riconoscenza va a coloro che hanno contribuito alla nascita e alla crescita di questo giornale. Non può mancare un augurio a quanti e a quanto verrà dopo il Caffè, «la Domenica».
Poche parole che dicono molto sulla chiusura del domenicale, che era stata annunciata, sempre in prima pagina, sull’edizione del 9 maggio.
Segnalo due articoli pubblicati in quei giorni su Naufraghi/e:
- Un Caffè amaro (di Riccardo Fanciola, 10 maggio 2021)
- Domande e risposte sui fondi di… Caffè (di Enrico Lombardi, 11 maggio 2021).
Questa è stata l’ultima puntata della mia collaborazione con il Caffè. Era iniziata il 12 luglio di un anno fa, con una seria di cinque articoli, Verso la ripresa delle lezioni – si andava all’apertura di un nuovo anno scolastico, dopo le tribolazioni di Covid-19 – l’ultimo dei quali era apparso sull’edizione del 30 agosto. Poi la collaborazione è continuata sulla scorta di un accordo con il direttore Lillo Alaimo, che non ho neanche rispettato fino in fondo [La formazione scolastica alla prova del tempo. Materia per materia così la scuola si rinnova].
Quest’ultimo contributo parla, indirettamente, del perché non ho rispettato a 360° la proposta di Lillo Alaimo (ma gliel’avevo detto, non ho ordito nessun intrigo).
È stata una bella esperienza. Grazie.