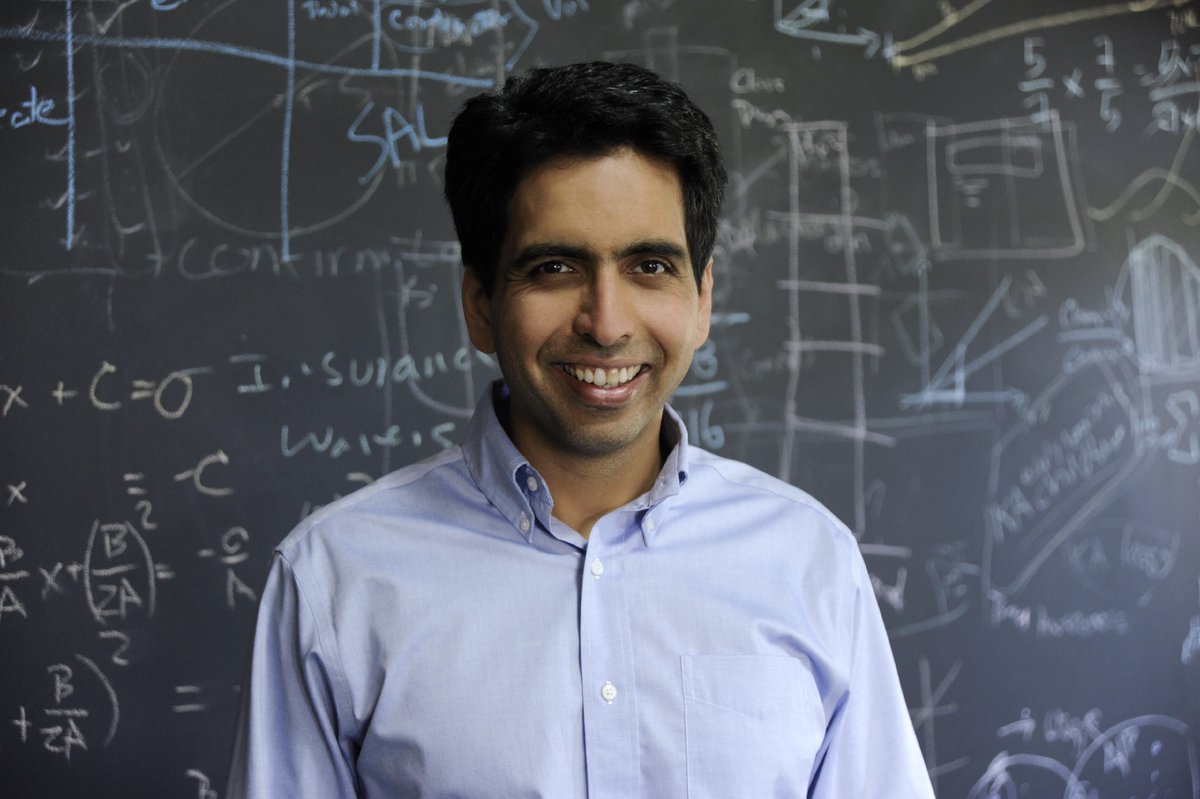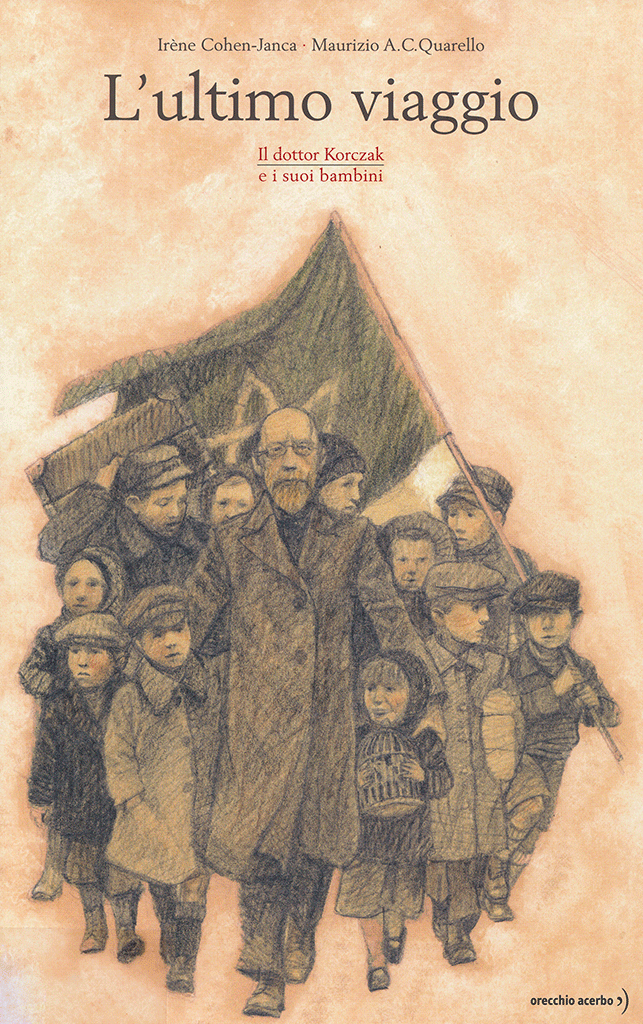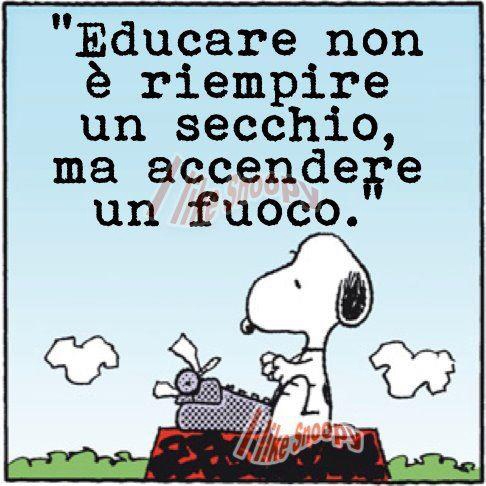Ebbene sì, anch’io, una volta, ho fatto il fondatore – senza nessun merito particolare, se non quello d’essere amico di alcuni che, in quell’occasione, Fondatori lo furono davvero. Fatto sta che il 2 giugno del 1993 firmai gli statuti dell’Associazione degli Amici dell’Organo di Locarno (AOL), approvati dall’Assemblea costitutiva del 2 giugno 1993.
Sono ancora con loro, con gli amici che ci sono ancora, perché questo manipolo di appassionati continua da cinque lustri a proporre il grande repertorio della musica organistica, senza quella puzza sotto il naso che troppo spesso distingue chi si perita di far cultura.
E non poteva andare che così, se solo si pensa che il direttore artistico dell’associazione, Giovanni Galfetti, è un musicista sensibile e un Maestro a tutto tondo. Figlio d’arte, Giovanni insegna oggi al Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, l’ex scuola magistrale. C’era durante tutte le metamorfosi di quella scuola degli ultimi trent’anni o giù di lì, dalla post-liceale all’Alta scuola pedagogica a oggi. Il suo sito testimonia, persino con troppa modestia, il suo grande impegno di musicista, educatore e uomo di cultura.
In occasione del venticinquesimo anniversario dell’AOL, La Rivista, mensile illustrato del Locarnese e valli, ha pubblicato sul suo numero di dicembre 2016 un mio articolo, con alcuni ricordi e qualche aneddoto. L’intento era quello di scansare a ogni costo toni dotti e saputelli: se, con Giovanni e qualche altro, continuo a dare una mano, è perché non ci siamo mai lasciati ingolosire dell’elitismo, che è l’anticamera della petulanza. Perché siamo amici del Re, mica volgari cortigiani, che, come canta Verdi, sono vil razza dannata.
Mi piace riproporlo di seguito, mentre la copia dell’originale può essere scaricata qui.
Una sera d’autunno del 1990 mi chiamarono Giovanni Galfetti e Marco Balerna. Mi raccontarono che in primavera si doveva organizzare per bene l’inaugurazione dei rinnovati organi della collegiata di Sant’Antonio. A quel tempo la mia cultura organistica era quella dei noti paracarri: conoscevo a malapena l’inizio della Toccata e fuga in re minore di Bach. I due amici sapevano però che ero un musicofilo onnivoro e curioso, che credevo nella diffusione della cultura – non solo quella musicale, ovvio – e che se c’era da dare una mano non mi sarei tirato indietro.
Scoprii presto alcune cose: che nella collegiata c’era un bell’organo romantico, che da tanti anni vivacchiava come un vecchio trascurato dai parenti, strusciando i piedi e spargendo armonie disarmoniche, col fiato corto; che già nel 1986 la Città di Locarno, proprietaria dello strumento, aveva destinato un credito importante per il restauro; e, per finire, che i rinnovati organi erano uno solo, quello lì, e che il plurale era un francesismo del Balerna. In ogni modo, non rifiutai l’invito e nella primavera di 25 anni fa andò in scena un battesimo coi baffi: concerto inaugurale con il principe degli organisti, Daniel Chorzempa, musicista di origine polacca ma cresciuto a Minneapolis, una stella di prima grandezza del panorama organistico.
Nasce l’AOL
Com’era normale che fosse, non eravamo pratici di organizzazioni di quel tipo. Così Chorzempa ci fece un poco ammattire – e lascio perdere dettagli che ci farebbero arrossire. Resta che la fase inaugurale, in quell’intensa primavera, fu emozionante, perché dopo il principe ospitammo Jeanine Lehmann, grande interprete svizzera, e poi alcuni bravi organisti di casa nostra: Livio Vanoni, Diego Fasolis e Giovanni Galfetti. Fu forse grazie alla passione e agli stimoli di quei giorni che avviammo la creazione dell’AOL, l’associazione degli Amici dell’Organo di Locarno, con lo scopo di valorizzare gli organi delle chiese locarnesi, in particolare lo strumento Urbani-Bossi-Marzi della collegiata, e di promuovere e organizzare concerti e altre attività musicali legate all’organo. L’AOL vide la luce il 2 giugno del 1993, alla presenza di una ventina di soci fondatori, tra i quali voglio citare Giovanni Galfetti, l’anima artistica del gruppo, Marco Balerna e l’arciprete Storelli don Ernesto, come autografò quella sera l’approvazione degli statuti. È in quell’anno che è partita un’avventura artistica e culturale straordinaria.

L’AOL, finché lo strumento non ricominciò e dar segni di sfinimento, ha proposto per diversi anni tre concerti tradizionali – per Santo Stefano, per la domenica delle Palme e per Pentecoste, oltre, in alcuni anni, il concerto di Ognissanti – decine e decine di matinée, con l’indispensabile sostegno dell’Ente per le Iniziative del Locarnese, e qualche concerto speciale, ospitando alcune punte di diamante della scena organistica internazionale. Mi piace rammentare e sottolineare che, con l’unica eccezione dei concerti inaugurali, l’AOL non ha mai chiesto un biglietto d’entrata, accontentandosi di un’eventuale offerta libera all’uscita, a seconda della disponibilità e del piacere provato. Forse è questo dettaglio, forse è il genere musicale in sé e i luoghi in cui stanno gli organi, forse sono altre caratteristiche misteriose: ma il pubblico, il nostro pubblico, è particolare e simpatico. Non ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, il bastone di cristallo, né la gardenia nell’occhiello. Sotto le navate della collegiata ho visto i pubblici più diversi e compositi: dal musicista attento al critico pedante, dal melomane che annuisce rapito a quello che riflette e vola in chissà quali mondi fantastici; ma anche intere famiglie con figli grandi e piccoli al seguito. Per ciò che mi concerne, da quella telefonata autunnale di cinque lustri fa ho scoperto un mondo artistico meraviglioso, un crogiuolo di compositori e di culture incantate, un repertorio inatteso ed emozionante, come sa fare l’arte, magari esaltata da luoghi che stuzzicano anche gli spiriti più laici.
Quindici anni di grande musica
Il cammino con gli amici dell’AOL ha riservato anche qualche aneddoto. Mi viene in mente quell’organista svizzero, protagonista di un concerto di Santo Stefano d’una ventina di anni fa, che dette qualche gatta da pelare al nostro direttore artistico: perché la panca dell’organo era troppo alta rispetto alle sue gambette – fu necessario tagliarne un pezzo, in quel dì di festa – e perché quel giorno non si era sbarbato e bisognava trovargli un rasoio. Capricci da stelline della TV.
Nel 1996 ospitammo una delle più grandi organiste del ’900, Marie-Claire Alain, figlia di Albert e sorella di Jehan, organisti importanti, una famiglia da enciclopedia, allieva di alcuni grandi della musica francese, da Maurice Duruflé a Marcel Dupré, compagna di corso di alcuni dei più importanti organisti della scuola francese del Novecento, come Pierre Cochereau: insomma, un monumento. Al termine di un concerto entusiasmante e indimenticabile, e dopo il ricevimento a casa Rusca con discorsi e rinfresco, questa donnina che certo non se la tirava, benché fosse Lei, chiese se era possibile mangiare un boccone. Non ci avevamo pensato, e fu abbastanza difficile trovare un ristorante ancora aperto a quell’ora, dove fosse possibile andare oltre un panino imbottito col pane del giorno prima. Quel martedì sera finimmo in un ristorante della città vecchia, con un piatto di spaghetti e un bicchiere di vino sfuso, a chiacchierare del più e del meno come un gruppo di vecchi amici.

Due anni dopo, il 5 maggio, data di per sé poetica, ecco un’altra serata speciale, con un altro grande vecchio della musica organistica francese, definito da alcuni l’Arthur Rimbaud dell’organo. Jean Guillou, classe 1930, dal 2014 organista titolare emerito del grande organo della chiesa di Saint-Eustache di Parigi, restò a Locarno alcuni giorni. Propose un programma che spaziava da Bach a Mendelssohn, da sé stesso a una delle sue celeberrime trascrizioni, in questo caso il «Prometeo» di Franz Liszt. E finì con un’improvvisazione su due temi proposti da Giovanni Galfetti. Non dimenticherò mai quel concerto, in parte per il programma così scoppiettante, in altra parte perché durante l’esecuzione del brano d’apertura, a chiesa strapiena, l’organo andò in tilt: una canna un po’ anarcoide improvvisò uno sciopero dello zelo, continuando a cantare la sua nota. Concerto interrotto. Galfetti uscì sul sagrato a strapparsi i capelli. Guillou non perse l’aplomb: lasciò la consolle, entro fisicamente nell’organo, trovò il difetto, rimediò e continuò il programma, terminato in un tripudio.
Mi sia concesso un ricordo molto personale. Il giorno precedente andai a trovarlo sull’organo, portando i miei figli di nove anni. Stava provando il «Prometeo», un’esultanza tardo-romantica che ben riflette la forza del poema sinfonico di Liszt. Ci accolse come un nonno felice e, mentre dava fiato poderoso all’organo, invitò i due jeuns anges a varcare la porticina accanto alle tastiere, quella che porta nel cuore dell’organo, in quel bosco di canne. L’uno varcò la soglia, ma ne uscì difilato, un po’ spaurito. L’altro venne fuori solo dopo la nota finale, e per un po’ di settimane continuò a disegnare canne d’organo che mandavano note lassù, chissà fino a dove.
L’incertezza e la rinascita
Al di là di questi nomi importanti, l’AOL ha invitato alle tastiere dell’organo di Sant’Antonio decine e decine di organisti, noti e meno noti, musicisti di lungo corso e giovani esordienti. Il pubblico ha sempre accolto molto positivamente, a volte con entusiasmo, le tante proposte musicali, a volte mescolate a voci soliste o ad altri strumenti. Così anche quando, una decina di anni fa, fummo costretti a ridurre l’attività a causa delle precarie condizioni dell’organo, abbiamo sempre fatto il possibile per mantenere viva la pur giovane tradizione, proponendo anche in quel periodo difficile il grande concerto di Santo Stefano e le matinée dei mercoledì primaverili e autunnali.
Già da quest’anno, tuttavia, il programma tornerà ai fasti di un tempo (anzi, di più). Grazie alla tangibile sensibilità culturale della Città e del Cantone, il nostro strumento, che è stato definito il più grande e importante organo romantico del Ticino, ha ripreso a suonare, a suonare bene, disponibile con tutte le sue caratteristiche, che sono tante e seducenti, al servizio degli organisti che vorranno proporre le loro scelte artistiche al nostro pubblico affezionato. In settembre c’è stata una sorta di prova generale, con quattro matinée molto seguite e apprezzate, offerte da Marina John, da Marco Balerna col trombettista Ivano Drey, da Roberto Olzer e da Giovanni Galfetti. Poi, il 23 ottobre, c’è stato il concerto inaugurale, per dare il benvenuto all’organo rinato: alle tastiere Francesco Finotti, organista onorario del Duomo di San Lorenzo in Abano Terme (PD); e sul pulpito, a presentarlo, Bepi De Marzi, l’autore del celebre «Signore delle cime», clavicembalista e organista nei prestigiosi Solisti Veneti di Claudio Scimone. Con un pubblico decisamente inusuale – l’arciprete Don Carmelo Andreatta, commosso, non ha saputo trattenersi: «Dovreste venire al mio posto e guardare giù: uno spettacolo!» – il tempo è trascorso svelto e delizioso, sulle onde della musica, dell’interpretazione accattivante di Finotti e delle affascinanti introduzioni di De Marzi.
P. S.: Nel brano Jean Guillou esegue il finale di «Prometeo», poema sinfonico di Franz Liszt, nella trascrizione per organo dello stesso Guillou (Registrato nella Collegiata di Sant’Antonio a Locarno il 5 maggio 1998).