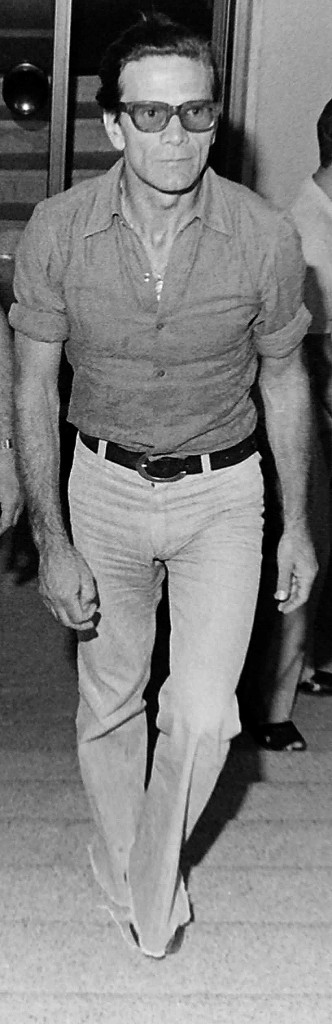Viviamo tempi strani.
Qualche giorno fa ho pubblicato una breve riflessione sull’insuccesso: La forza dell’insuccesso e l’elogio del fallimento. Paolo Di Stefano, in un articolo apparso sul Corriere della Sera, ha introdotto la sua riflessione con la frase di un autore che sarà svelato solo nell’ultima frase, tra parentesi: «Il successo è il solo metro di giudizio di ciò che è buono o cattivo». Sveliamo il mistero per chi non ha avuto voglia di andarsi a cercare la soluzione. La versione originale recita: «Der Erfolg ist der einzige irdische Richter über das Recht oder Unrecht».
L’autore è Adolf Hitler, il libro Mein Kampf [Volume I, capitolo 12].
Mica male, per un principio di politica dell’educazione e della formazione che aiuta a sistemare tante coscienze. ’Sta tiritera delle pari opportunità copre ormai tutto l’arco costituzionale, infinito come un cerchio: destra-centro-sinistra-centro-destra, e via girandoci intorno.
D’accordo, istituire la scuola media obbligatoria è stato un atto progressista, così come portare i licei anche a Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Ma sono cose di quarant’anni fa. Sarebbe come contentarsi della rivoluzione agricola, di quella industriale o di quella francese. Non è vero che sono sufficienti le pari opportunità per dare concretamente a ognuno la giusta occasione per riuscire a dare il meglio di sé. Basta guardare la questione femminile: nessuno se la sente di sostenere che il solo fatto di nascere donna possa generare disuguaglianze sociali, politiche o economiche. Cavoli: ci sono le pari opportunità! Eppure…
Ho detto che nessuno se la sente di?
Chiedo scusa.
Ho esagerato.
In realtà qualcuno c’è.
L’Unione Democratica di Centro, come si sa, è un partito di destra, malgrado l’aggettivo un poco temerario, e il sostantivo – centro – che è lì per ragioni storiche. Qualche giorno fa, l’11 maggio per la precisione, la sezione vodese dell’UDC ha pubblicato quel ch’è definito Son premier document de reference politique: «L’UDC, la voie du bon sens!». Il documento, di una settantina di pagine, è una specie di bibbia elvetica del XXI secolo. L’UDC (vodese…) traccia il suo Mein Kampf dicendo la sua sulla famiglia e sulla formazione, sulla giustizia, sulla sicurezza e su tutti i temi che interrogano ogni paese dell’occidente, senza naturalmente scordare le religioni, l’asilo e, pensa te!, anche le migrazioni.
Un paio di giorni fa, al capitolo «Famiglia», c’era scritto, tra le altre cose, che bisognava smetterla con la storia che non si potevano tirare un paio di cazzotti ai propri figli, sano principio democratico di educazione alla pace. Il Corriere del Ticino di sabato scorso titolava: «UDC Per educare i figli ci vogliono le sberle». E nell’edizione pubblica e online: «Sberle ai figli per salvare la famiglia». Ecco qua il capitolo di cui si parla.
Chiaro?
Il lunedì di Pentecoste, 16 maggio, la via del buonsenso dell’UDC ha già avuto un primo ripensamento. Neanche ventiquattr’ore dopo, il trattatello di pedagogia democentrista è già sparito: Le présent chapitre fait actuellement l’objet d’une mise à jour. Gli schiaffi e le sberle si sono dissolti. È scomparso l’intero capitolo. Attenderò con curiosità l’esito dell’aggiornamento tanto improvvisato e repentino. Ma non ci potevano pensare prima?
Naturalmente ci sono posizioni pirotecniche anche al capitolo Formation, con chicche come questa: «Sebbene la formazione in un’Alta Scuola Pedagogica non sia inutile, conviene tener presente che “la pedagogia non è una scienza, ma una tecnica”». Eccetera.
Oggi tutti dichiarano la loro adesione al principio universale delle pari opportunità. Mi viene in mente una vignetta esemplare, che circola da tanti anni:
 Eccole qua, le pari opportunità: il compito è uguale per tutti, nella più completa indifferenza alle differenze – un’apatia che non è per nulla neutra, politicamente parlando. Tra l’altro ne avevo già parlato; ad esempio: I politici, il DECS e l’indifferenza alle differenze o Un mal inteso senso delle pari opportunità.
Eccole qua, le pari opportunità: il compito è uguale per tutti, nella più completa indifferenza alle differenze – un’apatia che non è per nulla neutra, politicamente parlando. Tra l’altro ne avevo già parlato; ad esempio: I politici, il DECS e l’indifferenza alle differenze o Un mal inteso senso delle pari opportunità.
Ho la netta sensazione che anche i sostenitori dei quattro scapaccioni educativi non siano così rari: ma non è una posizione che fa tendenza, meglio non dirlo troppo in giro. Forse basterà aspettare un po’, ma poi ci arriveremo.
A differenza del consenso verso le pari opportunità, credo che le punizioni corporali, anche senza arrivare alle frustate e ai fagioli sotto le ginocchia, abbiano il loro pubblico, neanche troppo di nicchia.
Botte a parte, e senza troppe acrobazie retoriche, non si può scordare che pochi anni fa un gruppo di insegnanti ticinesi aveva lanciato il suo «Appello per la scuola», per far sì che i genitori di questo cantone potessero essere «… compiutamente informati in merito alla scuola che frequentano i nostri figli» (v. Troppa pedagogia!).
Non sarebbe male se, in tempi accettabili, anche chi si compiace della sua adesione alla solita solfa delle pari opportunità si desse una mossa. Con le pari opportunità non si riesce neanche a risolvere la questione femminile. Figuriamoci tutto il resto, ch’è addirittura più complicato.