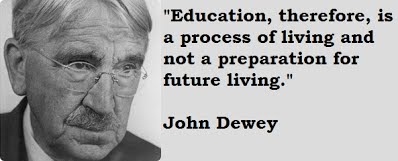La storia delle idee pedagogiche – che non si deve confondere con la storia delle istituzioni scolastiche – è un percorso che dura da secoli, innescata da quei pensatori che, nell’antichità, erano pure scienziati o matematici: basti pensare ad Aristotele, che già nel IV secolo a. C. affermava che le cose che bisogna imparare, «prima di farle noi le apprendiamo facendole: per esempio, si diventa costruttori costruendo, e suonatori di cetra suonando la cetra». Col passare dei secoli il quadro si è vieppiù affollato e ha arricchito il dibattito di idee e sperimentazioni con gli sguardi del medico, dello psicologo, del sociologo…
Continuo a essere convinto che la storia delle idee pedagogiche sia un strumento che non può mancare nella cassetta degli attrezzi di chi opera nella scuola. È una storia appassionante, con temi che, anche in tempi recenti, non hanno mancato di innescare discussioni accese. Si pensi a Pestalozzi, che nel 1798 accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «erano nella condizione alla quale conduce l’estrema degenerazione della natura umana. Arrivavano con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi».

Nella storia della pedagogia vi sono molte vicende appassionanti. Potrei raccontare di Janusz Korczak e dei suoi ragazzi del ghetto di Varsavia, dove elaborò interessanti strategie per risolvere i conflitti tra allievi – prima di essere deportato con i suoi ragazzi nel campo di sterminio di Treblinka nel 1942. O quella di un altro medico, Jean-Gaspard Itard, convinto che fosse possibile educare chiunque (la sua storia è quella raccontata dal film «Il ragazzo selvaggio» di Truffaut). O, ancora, delle esperienze di Jean Piaget, Don Lorenzo Milani, Maria Montessori, Célestin Freinet, la nostra Maria Boschetti-Alberti, tanto per citare qualche nome tra i più popolari.
Quest’anno ricorre il centenario della fondazione della Lega internazionale per l’educazione nuova (LIEN), che fu fondata a Calais nel 1921 e che, nel 1927, tenne a Locarno il suo IV congresso, con oltre mille partecipanti provenienti da ogni continente. Nelle intenzioni dei suoi fondatori LIEN riunisce e promuove quel movimento che, ancora oggi, si ispira alla scuola attiva, alla collaborazione e alla cooperazione tra allievi. Essa appartiene alla storia delle idee pedagogiche e quel congresso fu ospitato dalla scuola normale di Locarno.
A festeggiare il centenario dell’Educazione nuova anche in Ticino non ci sarà però il DFA, erede istituzionale della scuola normale di un secolo fa. Da oltre un trentennio la formazione dei docenti non passa più dalla storia delle idee, degli ideali, e, sì, a volte anche delle utopie, che per tanti anni hanno ispirato le politiche scolastiche e contribuito a costruire le democrazie.
Credere che sia possibile reinventare una nuova pedagogia per questi tempi complicati dimenticando la storia dell’educazione – che a volte si è incrociata con la storia della scuola – è una scelta vanitosa o imprudente, perché la cultura professionale non può nascere dal nulla. Le epoche e i contesti economici, culturali e sociali dove questa storia ha proseguito il suo percorso non erano semplici, né banali.
A questo punto ci si potrebbe pure chiedere chi sono i cattivi maestri.
Nota aggiuntiva
Mi piace, in questa occasione, pubblicare il parere del prof. Franco Zambelloni, interpellato da Andrea Bertagni, giornalista del Caffè, e pubblicato dal domenicale insieme al mio articolo (uscito col titolo Non si può non conoscere la storia della pedagogia).

«Zambelloni ha insegnato filosofia e pedagogia nei licei del Cantone Ticino», ha scritto Bertagni. Ma Zambelloni è pure stato direttore della scuola magistrale di Lugano, che ebbe vita breve negli anni ’70.
In quegli anni la massa di studenti che frequentavano la magistrale “storica”, quella di Locarno, per diventare insegnanti di scuola dell’infanzie, elementare e di economia domestica indusse l’istituzione di una sede a Lugano, dapprima solo per le prime tre classi (il quarto anno, quello più professionalizzante, si svolgeva ancora a Locarno), poi come istituto completo e autonomo, alla guida del quale si alternarono Franco Zambelloni e Alberto Cotti.
L’avventura della vecchia scuola magistrale, però, stava per giungere al capolinea. È in quegli anni che, oltre allo storico liceo di Lugano, furono istituiti i licei di Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Ed è pure di quegli anni la decisone di trasformare la scuola magistrale da seminariale (vi si accedeva a quindici anni) a post-liceale.
Per la cronaca: entrata in funzione nella seconda metà degli anni ’80, la magistrale post-liceale divenne poi Alta Scuola Pedagogica (ASP) nel 2002, più o meno in concomitanza con l’avvio del Processo di Bologna. A partire dal 2009/10 l’ASP – che era un istituto gestito interamente dal Cantone tramite il Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport – confluì nella Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana come suo dipartimento (poi denominato DFA, Dipartimento Formazione e Apprendimento).
È comunque negli anni post-liceali che inizia la lenta discesa della pedagogia nella scala dei valori della cultura professionale degli insegnanti.