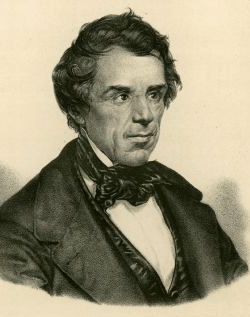In questo cantone smodato succedono a volte delle “cose” che converrebbe propagandare a dovere, mentre invece se ne viene a conoscenza un po’ per caso. Nel passato fine settimana gli occhi del Ticino tutto – si fa ovviamente per dire – erano rivolti agli appuntamenti referendari, quello cantonale sui rifiuti (partecipazione del 41.7%) e quello federale sull’energia (42.3% in Svizzera), alla Notte bianca di Locarno e alla manifestazione podistica straLugano (per la cronaca ha vinto un keniano).
Al LAC di Lugano c’era invece il concerto di Superar Suisse. Carneade? Sì.
Sono grato al direttore generale delle scuole comunali di Lugano, Sandro Lanzetti, che me ne ha accennato giusto due mesi fa, in occasione di un incontro informale e amichevole, e di aver messo in questa informazione tanta passione e un’emozione neanche troppo velata.
 «Superar Suisse» è la ramificazione di un progetto europeo, che, a sua volta, si è ispirato al famoso «El Sistema», un modello didattico musicale, ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, che consiste in un sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini di tutti i ceti sociali.
«Superar Suisse» è la ramificazione di un progetto europeo, che, a sua volta, si è ispirato al famoso «El Sistema», un modello didattico musicale, ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, che consiste in un sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini di tutti i ceti sociali.
Superar è un termine spagnolo che significa andare oltre i limiti, vincere e crescere andando oltre i propri confini.
Si legge nel sito elvetico che «Superar utilizza tutte le possibilità e gli effetti positivi che la promozione musicale e artistica rappresentano, al fine di dare un notevole contributo al cambiamento in senso egualitario della società. Superar è stata fondata nel 2009 dal Konzerthaus di Vienna, il Vienna Boys Choir e la Caritas dell’Arcidiocesi di Vienna come un progetto musicale dell’Europa centrale ricalcante lo stile del progetto “El Sistema” venezuelano. Nel corso degli anni Superar è cresciuta rapidamente, sia in Austria che in altri paesi. Attualmente è attiva in 14 sedi in Austria e in dieci sedi in Slovacchia, Svizzera, Liechtenstein, Romania e Bosnia. Superar Suisse è stata fondata nel 2012. [Essa] rende reale un’educazione musicale di alta qualità sia nella formazione della voce e del canto, sia nella formazione strumentale orchestrale per tutti i bambini e adolescenti – a prescindere dalla loro origine familiare e situazione economica».
Per farla breve, ho assistito a un momento musicale e sociale molto appassionante, assieme a un pubblico folto, entusiasta e caloroso. Al LAC, domenica, c’erano i ragazzini del coro e dell’orchestra di Lugano (oltre cento ragazzine e ragazzini tra gli otto e i dieci anni), con i cori di Winterthur e del Vorarlberg e le orchestre di Zurigo e Milano. Sotto la direzione dei maestri Marco Castellini, Carlo Taffuri e Pino Raduazzo hanno dato vita a un’ora di belle emozioni, dove i termini di energia, entusiasmo e divertimento hanno caratterizzato l’evento, annullando le inevitabili esitazioni esecutive.
È vero che il seme originario – El Sistema venezuelano – nel frattempo ha generato l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar e ha lanciato nel firmamento artistico mondiale musicisti di sicura fama, uno su tutti il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel. Ma la forza di Superar, discendente europeo di El Sistema, risiede nel grandissimo progetto di coinvolgere chi, per scelta autonoma, non avrebbe probabilmente mai imboccato un’avventura artistica come questa.
Sarebbe banale, e pure stucchevole, imboccare un discorso sulla forza educativa della musica d’assieme, che si potrebbe facilmente ergere a modello educativo. Però mi piace l’idea che questi ragazzi, sotto la guida e la partecipazione di maestri che non sono assillati da sciocchi traguardi di pagelle e certificazioni inoppugnabili e troppo spesso definitive, diano vita – gioiosamente e insieme – ad armonie che sono artistiche e, nel contempo, sociali. Qualche insegnamento lo dovrebbe pur ricavare anche la scuola dei test, degli esami reiterati e un poco tribunaleschi. Quella dell’immediata e finta spendibilità di acquisizioni scolastiche troppo spesso solo scolastiche.
Mi ha detto un collega luganese all’uscita: «Conosco tanti di questi ‘orchestrali’ e ti posso garantire che, tra i banchi di scuola, non sono sempre facilmente gestibili».
Chissà come mai a scuola no e in orchestra sì? Vuoi vedere che…
 Superar Suisse sarà alla Tohnalle di Zurigo l’11 giugno alle 11.15 e il 29 giugno alle 19 alla Elisabethenkirche di Basilea.
Superar Suisse sarà alla Tohnalle di Zurigo l’11 giugno alle 11.15 e il 29 giugno alle 19 alla Elisabethenkirche di Basilea.
I principi di Superar sono:
- la regolarità e l’assiduità: almeno due lezioni, ma al meglio tre o quattro alla settimana.
- Gratuità: La partecipazione alle lezioni Superar sono gratuiti per i bambini e genitori.
- Pari opportunità: Superar si prefigge che tutti i bambini e i giovani possano accedere all’istruzione musicale, che si estende evidentemente in campo artistico e culturale. In tal modo Superar vuole rafforzare la loro partecipazione nella società e potenzialmente migliorarne le opportunità.
- Preparazione artistica: Superar stabilisce elevati livelli artistici e di insegnamento per la selezione dei suoi tutor. Regolari aggiornamenti di essi anche contemporaneamente a Tutor Superar di altri paesi – che garantiscono l’alta qualità dell’insegnamento.
- Respiro internazionale: Superar è finora l’unico progetto ispirato al programma El Sistema venezuelano, ad essere attivo in diversi paesi, tenendo concerti congiunti, corsi di formazione e incontri, sia per i tutor che per la direzione Superar, nonché per i bambini e gli adolescenti che ne fanno parte.
- Ulteriori sviluppi: Superar è concepito come un programma di costruzione e formazione che fornisce moduli avanzati per permettere a tutti anche un futuro percorso artistico.