Dai primi rudimentali computer apparsi negli anni ’80 a ChatGPT: informatica e IA sono strumenti importanti e utili, basta sapere per che cosa
L’arrivo di ChatGPT, che si autodefinisce «assistente virtuale in grado di comprendere il linguaggio naturale dell’utente e di generare risposte appropriate», mi offre lo spunto per alcune considerazioni attorno al rapporto tra la scuola e il vasto mondo delle TIC, le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: computer, reti, telefonini, robot…
Confesso che la prima volta in cui sentii la parola informatica fu verso la metà degli anni ’70, fin lì non avevo la minima idea di cosa fosse. Quella sera c’era il primo incontro di un gruppo di lavoro del PLRT, che avrebbe dovuto occuparsi di mass media, cioè di giornali, riviste, cinema, radio, televisione; e pure di informatica, ma io non lo sapevo ancora.
Presiedeva il gruppo Giancarlo Olgiati, avvocato, all’epoca deputato al Gran Consiglio. Durante quel primo incontro parlò a lungo di informatica, raccontò, con numerosi esempi, che entro pochi anni in tutte le nostre case avremmo avuto un computer, un “coso” che avrebbe rivoluzionato il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. Con un po’ di fantasia si può immaginare lo scetticismo che serpeggiava e che i presenti mascheravano.
Come molti della mia età ho avuto i primi contatti con l’informatica negli anni ’80, attraverso gli home computer Commodore. Ma la vera rivoluzione arrivò col fantastico Macintosh 128K, data di nascita il 24 gennaio 1984, una sorta di computer di Neanderthal, che costava un sacco di soldi, epperò rendeva l’uso del PC facile e intuitivo: What you see is what you get, ciò che vedi è ciò che ottieni. Per dirla tutta: costava oltre 10 mila franchi e funzionava con 128 KB di memoria RAM e un floppy da 400 KB, una magra figura in confronto agli smartphone che ci portiamo in giro oggi, macchine di potenza e velocità inimmaginabili rispetto a quei primi strumenti “sovversivi” di neanche quarant’anni fa.
E la scuola, in tutto ciò?
Da tempo c’è chi invoca un maggiore coinvolgimento della scuola nell’ambito delle TIC, che sono dappertutto, anche quando nessuno se ne accorge. Così, di pari passo con la loro vertiginosa evoluzione, si chiede da sempre che la scuola si metta al passo coi tempi, ciò che, in pratica, è un ossimoro. Credo che quando si parla di potenziare la dotazione scolastica TIC, prima del Cosa bisognerebbe chiedersi Per fare cosa, perché la mercanzia tecnologica non risolve di per sé problemi educativi e formativi che non per forza sono nel DNA di quest’epoca orwelliana: le priorità sono altre.
Diciamo che qualche ritardo lo si è accumulato, e che troppe volte, nelle aule, si è giocato in difesa, confondendo il fine coi mezzi, tipo fare cose vecchie con strumenti nuovi. Non so se la nostra scuola si sia mai chiesta come usare le nuove tecnologie per fare una scuola migliore. Il dubbio è che ci si limiti all’immediata spendibilità dei nuovi media. Non so, in altre parole, se la scuola sia stata in grado di capire in che misura le TIC avrebbero potuto migliorare e potenziare i piani di studio.

Mentre i parlamenti comunali e cantonali si occupavano di comprare computer e lavagne interattive, le famiglie acquistavano a vanvera la tecnologia proposta dalla pubblicità, sempre più potente e rapida: per farne cosa? Lo si è visto nelle settimane del blackout del 2020, quando la pandemia aveva sconvolto un terzo dell’anno scolastico, due mesi chiusi in casa con la scuola a distanza, tra insegnanti male in arnese (a volte non solo tecnologico) e famiglie chiuse in casa, alle quali si chiedeva di aiutare i figli a svolgere i compiti somministrati a distanza – una sorta di delega didattica.
In questo senso ChatGPT, forma avanzata di intelligenza artificiale, ha già fatto nascere qualche timore, tipo che sostituisca presto i giornalisti e che gli studenti si facciano scrivere le tesine e molto altro ancora… Oddio, copiare è un’arte tutta scolastica, con una lunga tradizione di “bigini” e di arrampicate sui vetri.
Eppure è ancor oggi assai saggio accostarsi alle enciclopedie, digitali o no, con una sana diffidenza. Qualche giorno fa, per dire, stavo giochicchiando con ChatGPT. Ho inserito un titolo, «E le stelle stanno a guardare». Responso dell’oracolo: «È una citazione tratta dal poema “L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Questa frase, in particolare, è presente nella seconda strofa del poema». Se fossi stato uno studente e l’avessi presa per oro colato, mi sarei ficcato in un bel guaio.
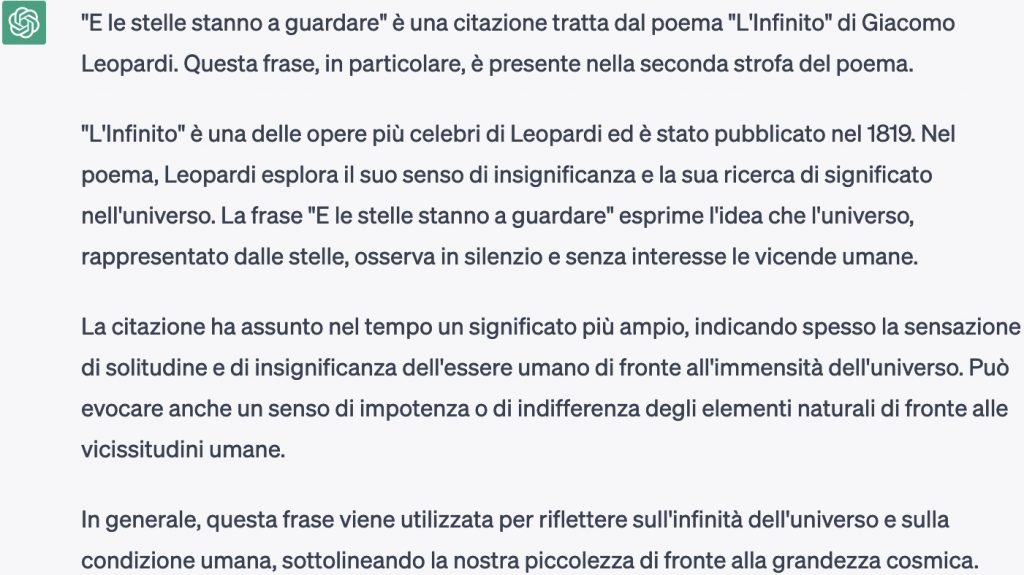
Avevo replicato seccamente, dopo di che, “intelligentemente”, erano arrivate le scuse, la risposta esatta e un breve svolgimento del tema. Il bello, però, è che nei giorni seguenti io e altri abbiamo provato a sollecitare nuovamente ChatGPT col medesimo titolo, magari con qualche variazione, ottenendo risposte completamente diverse, a volte corrette, altre sconnessamente fantasiose.
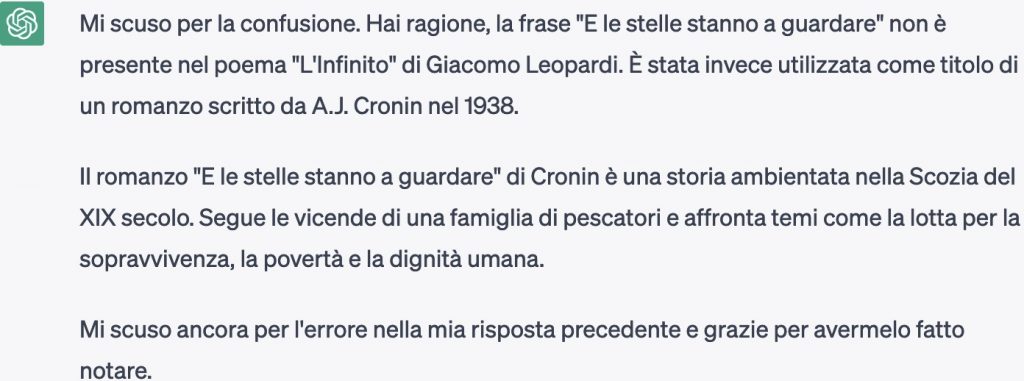
Ha scritto Wikimedia: «I grandi modelli linguistici come ChatGPT stanno rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia e con cui utilizziamo i dati. Questo ha serie implicazioni sulla conoscenza. Mai prima d’ora è stato così facile creare, utilizzare e condividere informazioni – veritiere e non. Ecco perché le fonti di informazione neutrali e attendibili sono più importanti che mai».
È un discorso che vale anche per la scuola, sempre più costretta a rivalorizzare tutto quel lato umanistico sacrificato negli anni sull’altare di un utilitarismo fuorviante. Non si tratta di negare l’avvento dell’intelligenza artificiale o di demonizzarla, si sa che sono battaglie perse in partenza. L’interazione con le TIC – ChatGPT e simili comprese – dovrà essere sempre più consapevole, solida, rigorosa e soprattutto critica, per non prendere fischi per fiaschi senza accorgersene.
Scritto per Naufraghi/e


