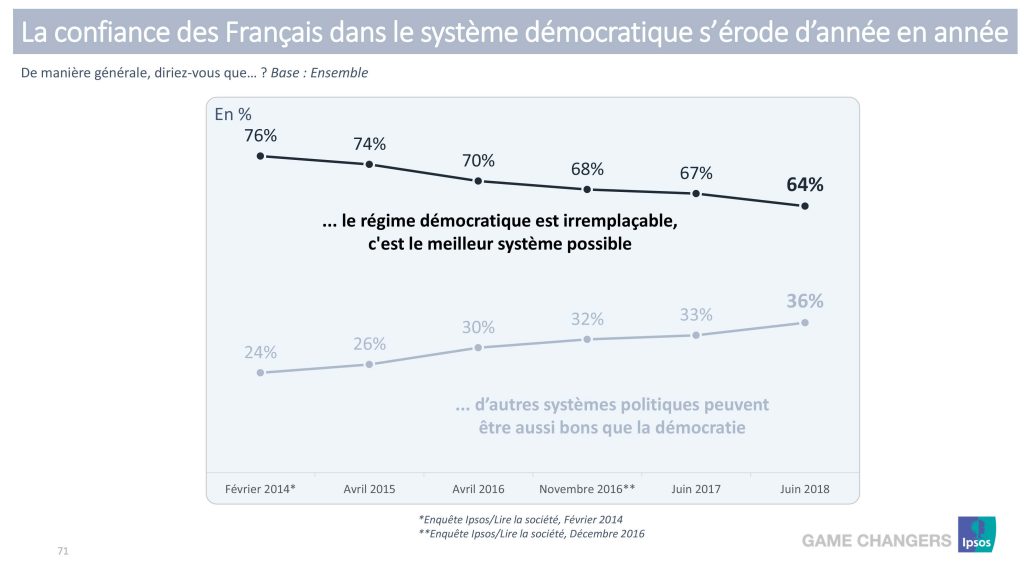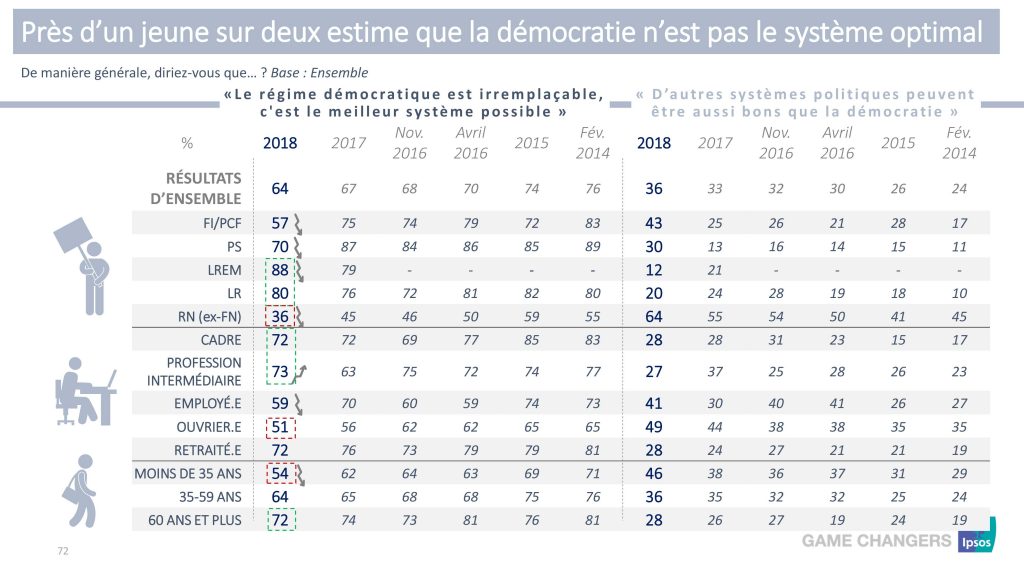Ci sono espressioni che, ogni tanto, conviene circostanziare e rammentare, sennò si rischia di chiacchierare a vanvera: io ti dico A e tu interpreti Z, benché l’espressione sia sempre quella. È un po’ come l’aggettivo «solare», che va molto di moda da qualche tempo nei curriculum vitae: «Sono una ragazza solare», e vattelapesca cosa significa. Da circa un ventennio si è scoperto che «La scuola è un’istituzione» (continuazione: e non un servizio), un’affermazione che si incontra abbastanza di frequente, una specie di monito: «Attento a te, guarda che la scuola è un’istituzione!». Allora ci riprovo, alla partenza della campagna elettorale che rinnoverà gli organi politici della Repubblica, con la certezza che se ne sentiranno delle belle.
La scuola, infatti, non è un servizio, come lo sono la distribuzione dell’elettricità, la raccolta dei rifiuti, la gestione della rete viaria, la posta o la ferrovia. Molti godono del marchio di «servizio pubblico» – e un qualcuno, una volta, lo era per davvero, benché poi sia stato messo sul mercato, e buona notte al secchio. Ci sono invece dei compiti che oltrepassano la semplice funzione di offrire un servizio, sotto forma di prestazione a pagamento diretto. Le votazioni su La scuola che verrà, il Salmo svizzero o l’educazione alla cittadinanza hanno mostrato due cose: che anche ai supposti «addetti ai lavori» ogni tanto manca l’ABC dei processi che fanno funzionare l’apprendimento (e, conseguentemente, l’insegnamento); e che si vuole una scuola che istruisca e che svolga compiti di selezione precoce.
Se la scuola che oggi prevale nelle idee della maggioranza è questa, allora siamo di fronte a un servizio, vale a dire a un organismo che fornisce un prodotto o una prestazione. È seccante doverlo ripetere, ma la scuola dell’obbligo dovrebbe avere lo stesso valore politico e culturale della giustizia e dell’esercito, vale a dire istituzioni che non possono perseguire interessi individuali. L’educazione non può ubbidire a leggi di mercato, così come i giudici non devono soggiacere alla soddisfazione dei condannati; deve invece rispondere a principi specifici, definiti dai primi articoli della legge della scuola. La scuola dell’obbligo è diversa dalle scuole che vengono dopo. Essa non deve formare medici e idraulici, architetti e falegnami, maestri e bancari, tutti, possibilmente, di alto livello; ma ha un obiettivo diverso e più nobile, quello di gettare le basi per educare i cittadini di domani.
L’educazione non è disgiunta dalla conoscenza e dall’istruzione. È incomprensibile che ci si ostini a sostenere che senza la meritocrazia, applicata coi voti scolastici, sia impossibile «fare scuola» senza diminuirne il livello. Quando lo Stato decide che tutte le persone tra i quattro e i quindici anni devono – devono! – andare a scuola, non può limitarsi a inseguire la selezione delle menti scolasticamente più leste. Il suo compito è invece quello di fare in modo che ogni ragazzo possa raggiungere il massimo delle sue possibilità culturali e intellettive entro i quindici anni, nel contesto sociale, famigliare, economico e culturale in cui sta crescendo. Se lo Stato non è in grado di garantire ciò e sceglie invece, per mezzo della scuola pubblica e obbligatoria, di ridursi a sancire la rapidità e i picchi più alti dei successi scolastici, tanto vale metterla sul mercato: costa meno, non crea illusioni né recriminazioni antipatiche ed egoiste, e si può sempre cambiare. Insomma: soddisfatti o rimborsati.